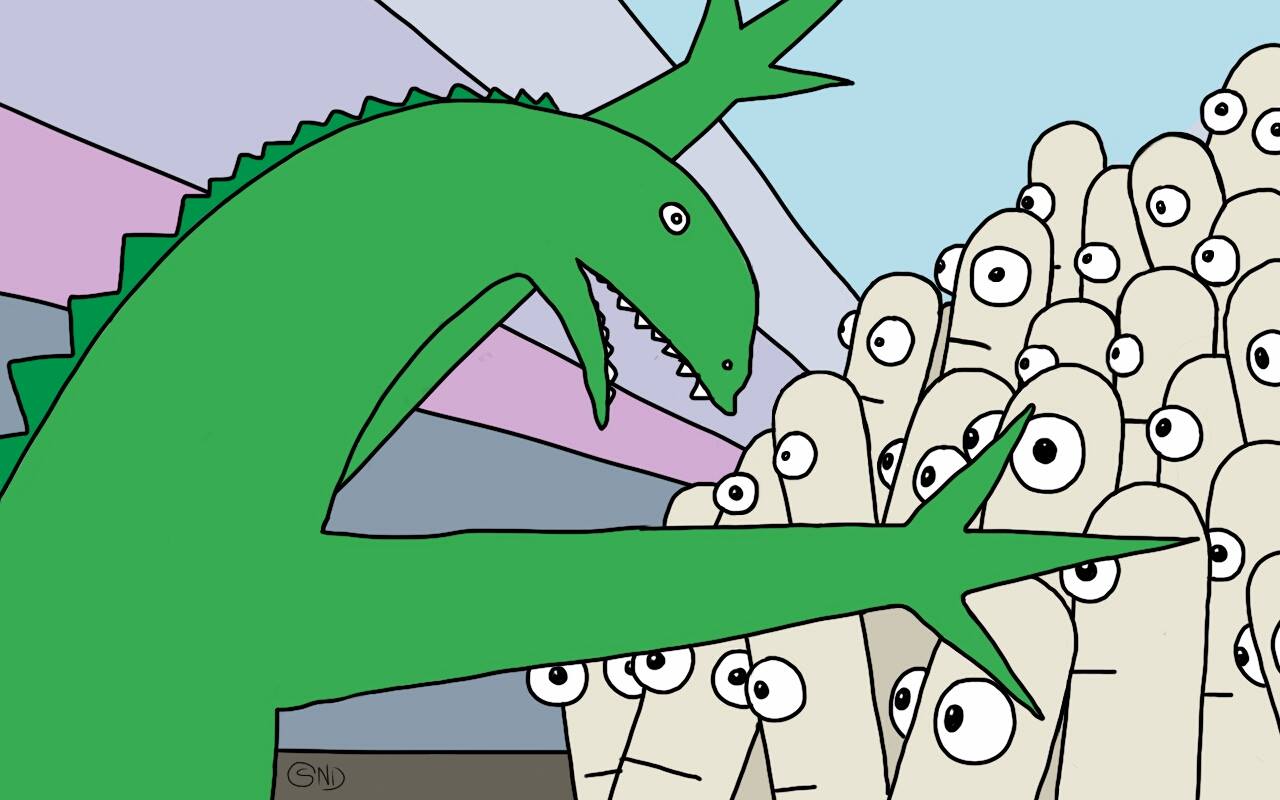Di SANDRO MEZZADRA
Si chiama ASAP, Act in Support of Ammunition Production, e va messo in atto ASAP, As Soon As Possible. L’approvazione da parte del Parlamento europeo del piano per incrementare la produzione di armi consentendo ai Paesi membri di utilizzare parte dei fondi del “Next Generation EU” mostra quanto in profondità il regime di guerra sia penetrato all’interno delle istituzioni e delle società europee. La tendenza è chiara: da una parte occorre ricostituire gli arsenali svuotati per l’invio di armi all’Ucraina; dall’altra – su tempi più lunghi – il riarmo deve costituire una priorità strategica per i governi europei, coerentemente con quel che accade in altre parti del mondo. Ci sono i campioni, a partire dalla Polonia che ha portato le spese militari al 4% del PIL (contro il 2% richiesto dalla NATO), ma non v’è Paese europeo che si sia astenuto dall’aumentare gli investimenti in armamenti. Lo Stockholm International Peace Research Institute calcola per il 2022 una spesa complessiva di 345 miliardi di dollari, qualcosa in più del PIL di un Paese come il Pakistan.
Intanto, a Chisinau (in Moldavia) si è riunita la Comunità Politica Europea, una sorta di piattaforma istituita lo scorso anno su proposta di Macron per coordinare il dialogo tra Paesi membri dell’UE, Paesi candidati a entrarvi, Paesi che un giorno potrebbero essere tra i candidati e Paesi fuoriusciti (la Gran Bretagna) o storicamente attestati su una posizione di neutralità (la Svizzera). Non sorprende che ancora una volta il mattatore sia stato il Presidente ucraino Zelensky. Nel suo intervento ha chiarito un paio di cose, se mai ve ne fosse stato bisogno. In primo luogo, quel che conta davvero è la NATO, e “tutti i Paesi che hanno una frontiera con la Russia” devono farne parte. La guerra, poi, non può che concludersi con la vittoria ucraina, per cui l’unica opzione è la resa incondizionata della Russia (questo e non altro è il “Piano ucraino” in dieci punti). L’Ucraina, in fondo, si propone come modello per la nuova Europa: come ha scritto sulla New Left Review Volodymyr Ischchenko, con la loro volontà di combattere e con la loro disponibilità al sacrificio gli Ucraini “hanno dimostrato di essere non solo come gli occidentali, ma anche meglio di loro”. La “politica dell’identità” che ne deriva segue la logica di un rigoroso nazionalismo.
“N on c’è un’Europa di serie A e una di serie B”, ha dichiarato l’ineffabile Giorgia Meloni a Chisinau. La si può capire. In quella che abbiamo da tempo definito l’Europa “a trazione polacca” si trova benissimo. E l’Ucraina di Zelensky anche per lei può essere un modello. In visita a Kiev nello scorso mese di febbraio, ha dichiarato che la guerra di resistenza all’invasione russa è in fondo come il nostro Risorgimento. Si attende il ricorso alla leggenda del Piave, magari riadattata per difendere la Crimea, parte del sacro suolo patrio dell’Ucraina. Ma c’è poco da scherzare: il punto è che Meloni interpreta correttamente la tendenza in atto in Europa dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Il regime di guerra si manifesta in primo luogo attraverso una rimessa al centro dello stesso processo europeo della nazione e del nazionalismo, che ha nell’asse tra Kiev e Varsavia il suo motore ma è ben lungi dal riguardare soltanto questi due Paesi. Pensiamo davvero che i risultati delle recenti elezioni in Grecia e in Spagna (ma anche delle amministrative italiane) siano del tutto esenti dalle pressioni esercitate dal regime di guerra? All’orizzonte, guardando alle elezioni europee del prossimo anno, si profila una netta virata dell’Unione Europea in senso “confederale”, verso quell’Europa dei popoli e delle nazioni a lungo sognata dalle destre e oggi in qualche misura imposta dagli sviluppi della guerra in Ucraina. La conseguenza sarà un’accentuata dipendenza dagli USA e l’irrilevanza dell’Europa nel nuovo mondo multipolare? Poco sembra importare a Zelensky, Duda, Meloni e ai loro pari.
Dovrebbe importare a noi. Se c’è un aspetto dell’integrazione europea che abbiamo sempre pensato andasse salvaguardato e potenziato è il suo carattere “post-nazionale”. Non lo abbiamo mai inteso in modo ingenuo o lineare. Abbiamo lottato contro le istituzioni europee, ne abbiamo denunciato le politiche neoliberali e i tratti criminali della gestione dei confini e dei movimenti migratori. Ma l’orizzonte postnazionale, materialmente radicato in un bilancio delle catastrofi del nazionalismo nel ventesimo secolo, ci è sempre parso potesse rappresentare un terreno avanzato di lotta. Continuiamo a pensarlo, nonostante gli scenari in cui ci troviamo ad agire. La guerra, con il suo carico di distruzione e di morte, e il regime di guerra, che installa al centro della spesa pubblica il riarmo, devono e possono essere fermati. È una battaglia, del resto, che non va condotta soltanto su un astratto “piano europeo”. Il riferimento alle elezioni in Grecia, Spagna e Italia dovrebbe chiarire che in gioco sono anche gli sviluppi nelle dimensioni locali e nazionali. È a partire da qui che occorre lavorare per esercitare un potere di veto sulla guerra e sul regime di guerra, per affermare un contropotere capace di far crescere rapporti sociali, rapporti di forza che della guerra e del regime di guerra costituiscono la negazione radicale.