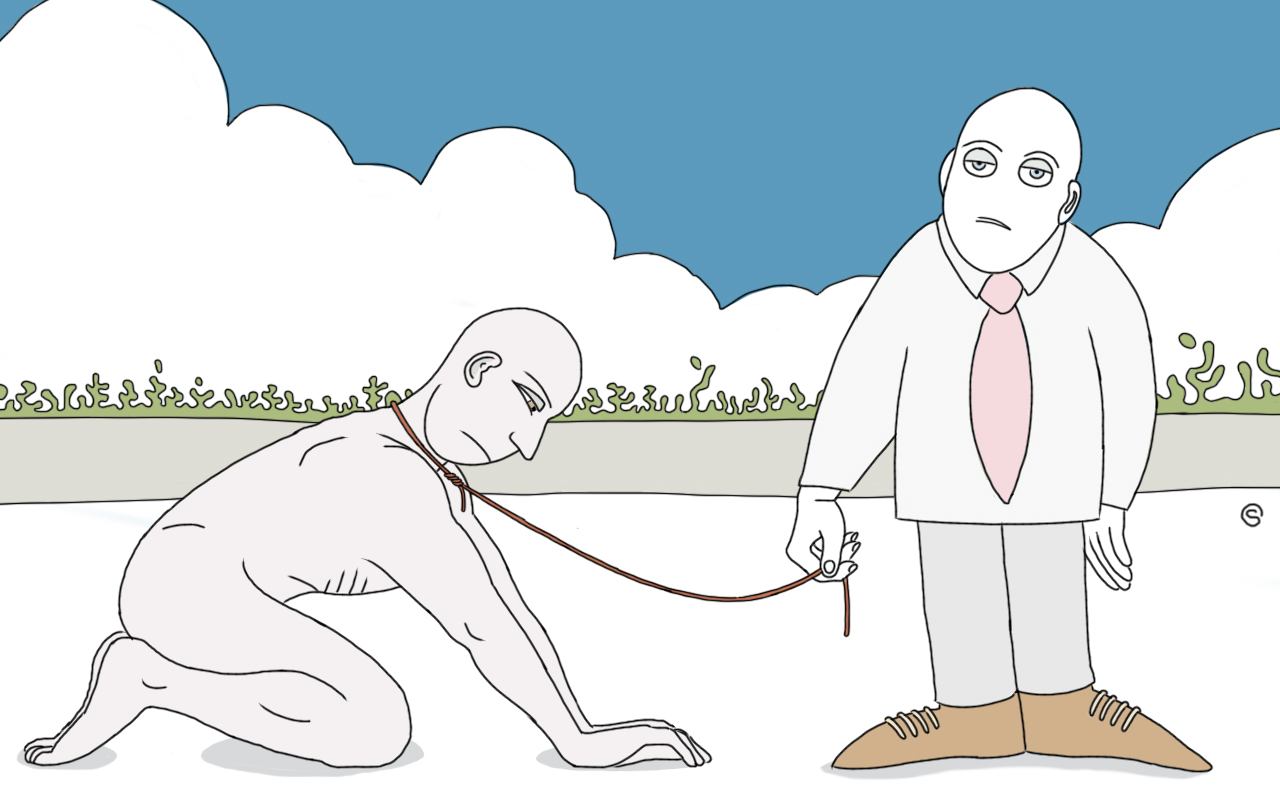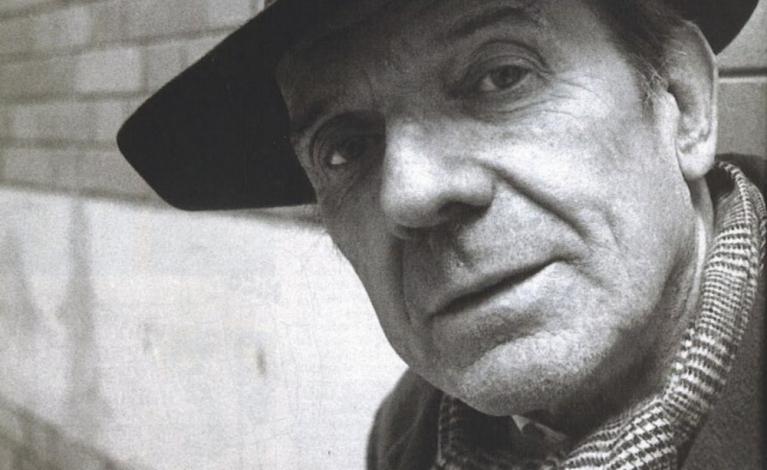di FRANCESCO FESTA.
Riflessioni a margine della presentazione de La mala setta. Alle origini di mafia e camorra. 1859-1878, L’Asilo, 15 aprile 2016
Tra le interpretazioni classiche sulla storia del Mezzogiorno d’Italia (ad esempio, quella dello storico e meridionalista Piero Bevilacqua in Breve storia dell’Italia meridionale), la tesi maggiormente condivisa è che la durata secolare del fenomeno sia dovuta al fatto che la camorra e la mafia costituiscano un aspetto interno alla costruzione dello stato nazionale italiano: un aspetto riguardante il rapporto fra centro e periferia. Dunque, non un fenomeno di “banditismo sociale” (come definito da Eric Hobsbawn) o di pura criminalità; ma fenomeni che si sono alimentati del processo di unificazione. Inversamente, ciò vuol dire che l’Italia unita si è andata formando su un’ambigua relazione di scambio fra centro e localismi. In altri termini: il ceto politico nazionale ha offerto alle periferie risorse pubbliche in cambio di consenso.
Altra tesi è che la grande criminalità sia espressione di una borghesia abortita. Ritengo, invece, che non fosse – e non sia ancor oggi – una borghesia abortita: bensì, una borghesia pienamente realizzata: una grande borghesia imprenditoriale e proprietaria – tanto meridionale quanto nazionale – che è cresciuta nei suoi interessi grazie a quel rapporto perverso con il ceto politico locale e con lo stato nazionale.
Altra tesi delle ricerche sull’argomento è che quel rapporto viziato fra centro e periferia sia stato interrotto durante il fascismo. Vale a dire che la camorra storica sia stata sconfitta, avendo il regime fascista interrotto il legame con le classi dirigenti locali e accentrato a sé, nella gerarchia del regime, il potere periferico.
A ben guardare, però, alla fine dell’Ottocento la camorra aveva allargato le relazioni, aumentato gli affari e gli amici autorevoli e ricattabili che garantivano alla camorra quanto fosse necessario ottenendo in cambio consenso e ordine sociale. In fondo, alla fine dell’Ottocento, si parlava già di “Alta camorra” quando si additava il politico di riferimento. Ad esempio, il deputato Alberto Aniello Casale, soprannominato il “padrone del Comune” o il “sindaco ombra” di Napoli era a capo di una fitta rete camorristica, amministrativa e politica che gestiva un ampio sistema di corruzione. Questa rete si fondava sul clientelismo, come pure sulla complicità del governo centrale. Francesco Saverio Nitti inequivocabilmente diceva:
Al Governo fa assai comodo date le instabili vicende della politica, di avere una base solida; così tutti i Governi lavorano il Mezzogiorno e lasciano fare [mentre] il Governo lavora chiudendo gli occhi sui furti, spesso determinandoli, fomentando la corruzione, mantenendo impunite colpe chiare e patenti. Si può dire in tutta onestà che a Napoli il più grande e il più pericoloso camorrista sia sempre stato il governo.
Secondo alcuni storici, il fascismo ha effettivamente sconfitto questa camorra post-unitaria. Agli inizi del Novecento, il deputato Aniello Casale – il sindaco ombra – si dimette. Dopo pochi anni, durante il fascismo e la centralizzazione del potere, cambiano le condizioni sociali in cui prima cresceva la camorra: cioè, s’interrompe quel rapporto perverso con i ceti politici. Si mantiene in vita solo una camorra, per così dire, rurale, quella del casertano, i cui luogotenenti vengono assoldati dal regime, diventano Ras locali del fascismo. Tuttavia, questa interpretazione non regge poiché non tiene conto del fatto che le radici della camorra restarono ben salde tanto da rifiorire dopo l’arrivo degli americani e dopo il ‘45, se non con le medesime organizzazioni, almeno con le stesse pratiche.
Non varrebbe la pena affrontare questi concetti, ormai secolari, come la camorra e la mafia, mettendo un attimo da parte il tema tanto caro alle fiction, alle inchieste giornalistiche, alla stampa nei termini di lotta titanica fra bene e male, vittoria o sconfitta fra lo stato e la mafia? Forse non sarebbe il caso di affrontare tanto la camorra quanto la mafia in termini di rapporto fra realtà e rappresentazione per indagare gli elementi che le rendono possibili?
 Badate: utilizzo il termine concetto per parlare di camorra e mafia, poiché penso appunto che vadano compresi il senso, il significato, la forza rappresentativa e soprattutto la costruzione del concetto in sé, e di mafia e di camorra. Consci che con mafia e camorra s’intendono tanto organizzazioni, sistemi quanto habitus, condotte, prassi, comportamenti, costumi. In questo modo si farebbe chiarezza di tante interpretazioni, a mio parere, senza alcun fondamento, se non utili politicamente e strumentalmente.
Badate: utilizzo il termine concetto per parlare di camorra e mafia, poiché penso appunto che vadano compresi il senso, il significato, la forza rappresentativa e soprattutto la costruzione del concetto in sé, e di mafia e di camorra. Consci che con mafia e camorra s’intendono tanto organizzazioni, sistemi quanto habitus, condotte, prassi, comportamenti, costumi. In questo modo si farebbe chiarezza di tante interpretazioni, a mio parere, senza alcun fondamento, se non utili politicamente e strumentalmente.
Ad esempio le interpretazioni cosiddette culturaliste sul fenomeno mafioso: quelle che leggono la mafia come una sorta di oggetto dalla natura quintessenziale, proprio della natura siciliana o campana, o tipico della identità meridionale, le cui radici risalgono al Medioevo oppure alla preponderanza spagnola o addirittura alla dominazione romana. Oppure: l’idea che il camorrista sia il lazzarone nel ‘600; la plebaglia all’epoca di Masaniello; e poi risalga questa figura nel sottoproletariato, giungendo all’oggi, senza soluzione di continuità.
Molto spesso, queste interpretazioni vengono utilizzate per spiegare anche e soprattutto la “questione meridionale” secondo tratti razzializzanti: cioè tratti di essenzializzazione e di naturalizzazione, che rinviano a interpretazioni positivistiche, lombrosiane o, più recentemente, neo-positivistiche. Interpretazioni che non nascondono una sorta di antimeridionalismo e talvolta di vero e proprio razzismo antimeridionale (intendo qui col termine di razza – e del suo farsi verbo, razzializzare – la costruzione di discorsi e di pratiche, di processi economici e culturali di discriminazione che puntano alla subordinazione di un gruppo sociale da parte di un altro).
Il libro La mala setta illumina e prende le distanze da tutta questa letteratura. E non solo. Fa luce anche sulla “questione meridionale” e sulla storia del Sud Italia, lette finora come contesto sociale, economico e politico in cui sono cresciute le formazioni criminali nel corso dell’800. Ne La mala setta vi sono tanti esempi giudiziari, polizieschi e criminali (tra i più noti, il battesimo dell’unità italiana con l’introduzione di misure giudiziarie emergenziali, vale a dire la Legge Pica dell’agosto 1863: “Procedura per la repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle Provincie infette”, contro il reato del brigantaggio e poi esteso al reato del “camorrismo”: una misura eccezionale e temporanea prorogata fino al 1865, con cui si istituiva uno stato di eccezione nelle province meridionale oltre l’adozione di pratiche extragiudiziarie: ammonizione, domicilio coatto che formarono al ritmo del fuoco e del sangue anzitutto le popolazioni: si pensi agli eccidi di Casalduni e Pontelandolfo nel Beneventano); ed esempi di bande criminali (come il primo processo ad una banda criminale, quello nei confronti della “Balla”, una banda che operava a Bologna fra il 1860-61); oppure esempi di corruzione e di metodi corrotti della polizia mostrando come fossero uguali in tutta la penisola e come la “questione meridionale” sia stata più una rappresentazione e meno una condizione originaria.
La ricerca di Francesco Benigno è davvero preziosa per capire come si producano e si veicolino i discorsi, le rappresentazioni, le immagini, le narrazioni, il senso intorno al Mezzogiorno d’Italia; e come si riproducano i campi di forze e le condizioni che alimentano condotte e prassi che concettualmente chiamiamo mafia e camorra. Benigno scava all’interno di un periodo controverso: 1859-1879. Cioè un anno prima dell’unificazione della penisola (di Garibaldi e della “spedizione dei Mille”); poi, gli anni ‘60, gli anni della legge Pica e della guerra al Brigantaggio (della “guerra al Brigante”); gli anni 70, anni del consolidamento del regime politico unitario e dell’avvicendarsi delle forze politiche in campo: la destra storica e la sinistra storica. La mala setta ci introduce nelle condizione sociali e nel contesto territoriale (urbano, cittadino) in cui agiscono quelle pratiche poliziesche e giudiziarie che fondano e regolano quello che viene chiamato “ordine pubblico”, che è anzitutto ordine politico. Infatti, il libro tratta insieme due argomenti – mafia e camorra – da sempre studiati separatamente proprio perché sono entità che vanno guardati insieme alla formazione dell’ordine politico, cioè dell’opposto; è dentro la formazione dell’ordine politico fatta da poliziotti, magistrati, che si può intendere anche l’organizzazione del disordine. Ordine politico che, per esistere, richiede l’individuazione e di nemici e di amici, secondo gli interessi delle forze politiche in campo. Quindi: borbonici e repubblicani, in seguito anarchici e socialisti e internazionalisti (con l’avvicendamento della Destra e della Sinistra liberale), infine i meridionali. Nella lettura del libro, in controluce s’intravede proprio come si vada formando, per così dire, la cittadinanza politica italiana o l’identità italiana, cioè come si formi lo stato unitario a partire da pratiche informali o da manipolazione dell’ordine pubblico. Come dire: “destabilizzare per stabilizzare” o “fare l’ordine con il disordine”, due espressioni che ritornano nel libro. (l’ultima proviene dalla Francia, dal 1848, dal Ministro della polizia francese durante le rivolte parigine concetto di Marc Caussidiere: servirsi dei criminali per sorvegliare e contrastare i criminali più pericolosi, che erano naturalmente i criminali politici).
Il metodo adoperato nel libro è di individuare il rispecchiamento fra crimine tra fiction e realtà, dove la rappresentazione (romantica o pittoresca) gioca una funziona essenziale. Con Dumas, citato in conclusione del volume: “in generale gli storici si contentano di evocare fantasmi, mentre i romanzieri fanno dei personaggi in carne ed ossa”.
La rappresentazione non è una prerogativa contemporanea, sostiene Benigno: “il crimine risulta indistinguibile dalla sua rappresentazione, una sorta di fantastico schermo su cui si proiettano le ansie sociali e le inquietudini culturali di una società”. In fondo, la rappresentazione svolge un doppio potere: quello di rendere presente ciò che è assente e di costituire legittimità di questa presenza esibendo qualificazioni, giustificazioni, e titoli. Se la rappresentazione riproduce non soltanto di fatto, ma anche di diritto, le condizioni che rendono possibile la sua riproduzione, si capisce allora l’interesse del potere ad appropriarsene. Per Foucault: la rappresentazione è la combinazione del sapere con le pratiche di potere, il campo dove operano le pratiche e i dispositivi che producono il discorso con cui una società viene controllata, selezionata e organizzata in un certo numero di procedure in modo da consolidare poteri e scongiurare pericoli.
La rappresentazione oltremodo si muove nel campo dell’“ideologia”, nel campo del senso comune. Gramsci ha indagato proprio il campo dell’ideologia, cioè di come si formino il senso comune e i luoghi comuni all’interno nella cultura popolare. Gramsci è andato oltre le semplificazioni dell’“economicismo marxista”, secondo cui la società si fonda solamente sulla struttura, cioè su elementi economici; mentre la rappresentazione, i luoghi comuni, gli stereotipi appartengono alla sovrastruttura, ossia al riflesso dell’economia. Invece, il senso comune, le rappresentazioni, le immagini veicolate nella società rispondono a istanze economiche, politiche e ideologiche, che a loro volta si combinano in modi differenti. Non a caso, in Alcuni temi della quistione meridionale, segnala come si siano formate ideologia e immagini sui meridionali visti come “palla di piombo” dei settentrionali oppure il Sud quale luogo arretrato e di criminali. Testualmente, scrive Gramsci: “l’ideologia diffusa in forma capillare dai protagonisti della borghesia nelle masse del Settentrione” rappresenti “il Mezzogiorno” dentro il refrain di “palla di piombo che impedisce più rapidi progressi allo sviluppo civile dell’Italia”, perché “i meridionali sono biologicamente degli esseri inferiori, dei semibarbari o dei barbari completi, per destino naturale; se il Mezzogiorno è arretrato, la colpa non è del sistema capitalistico o di qualsivoglia altra causa, ma della natura che ha fatto i meridionali poltroni, incapaci, criminali, barbari”.
E ne La Mala Setta incontriamo appunto esempi di tipizzazione, immagini stereotipate, processi di simbolizzazione, ciò che Benigno definisce la “costituzione criminale”: ossia, la produzione di immagini, veicolate dalla letteratura e dalla stampa dell’epoca (oggi: sono le fiction, i romanzi, le inchieste da battaglia: Saviano in ogni dove), che vengono agitate o utilizzate per ragioni strumentali; e comunque agitate sempre a ridosso di determinate congiunture politiche. La costruzione di un “abito” che diviene discorso e poi viene incanalato e si riproduce come rappresentazione e auto-rappresentazione: come sostiene Benigno, “l’abito che fa il monaco”. In questo modo tutto diventa camorra (prassi, organizzazione, metafora, costume, condotte…). Per l’appunto, Stuart Hall parlava della “politica della rappresentazione”, ossia che la rappresentazione ha una doppia funzione, esercita un doppio potere: in chi rappresenta e nel rappresentato.
Inoltre, ne La mala setta vi è un tentativo – molto efficace – di considerare i discorsi sul crimine organizzato italiano dell’800 come parte del più generale tema delle classi pericolose (rileggendo criticamente un classico della storia sociale della rivoluzione industriale: Louis Chevalier, Classi lavoratrici e classi pericolose nella Parigi della rivoluzione industriale). Benigno demitizza la vulgata sulla camorra: vulgata che nell’Ottocento ha costruito la figura del camorrista e del mafioso, astraendolo dai contesto sociali, presenti tanto al Sud quanto al Nord. Nel senso che la letteratura nella seconda metà dell’800, o il teatro di strada (pensiamo alle guarattelle napoletane o ai pupi siciliani) danno vita a un idealtipo di criminale. D’altro canto, la letteratura romantica – il romanticismo – ha diffuso in Europa l’idea di popolo come cuore della Nazione e in qualche modo i criminali sono stati pensati e rappresentati (Balzac, Hugo, Monier) come un “popolo altro” da noi, diverso, con le sue tradizioni, i suoi costumi e persino i suoi linguaggi (Argot). Quindi pensare i criminali come qualcosa altro da noi significa anche pensare i criminali organizzati, che costruisce da sé le proprie strutture organizzative in qualche luogo misterioso. Pensiamo ad esempio alle poesie e ai racconti di Ferdinando Russo dove la camorra e i camorristi diventano icone di una narrazione e di una rappresentazione che si riprodurrà, da allora in poi, praticamente sempre eguale, almeno a livello di immaginario collettivo. Così, camorristi e mafiosi, nella letteratura picaresca della seconda metà dell’800, incarnano il coraggio, abilità, la valentia, comportamenti ambiti, che suscitano attenzione e prestigio verso quel “popolo altro”, verso quel popolo posto ai margini della nazione. Oppure l’invenzione di tradizioni: ad es. il rito sacro dei “Beati Paoli”, un cerimoniale d’iniziazione cui si rifanno i mafiosi ancor oggi. Ecco, tutto ciò sono invenzioni e idealtipi che ripetuti come specchi hanno prodotto senso e discorso, divenendo materia per quelle classi pericolose nel riconoscere elementi di associazione e per la politica nell’utilizzo delle medesime classi per fini e interessi di determinate dalle congiunture politiche.
Ma queste immagini sono state materia anche per i positivisti della Scuola criminologica, quella di Cesare Lombroso, capace di produrre idealtipi di criminali legandoli alla natura, all’ethnos. Esemplare è il testo L’Italia barbara e contemporanea di Alfredo Niceforo che ha alimentato stereotipi sul Sud a partire da questo tipo di rappresentazione e tipizzazioni: mafia e camorra, brigantaggio e feudalesimo, superstizione analfabetismo e magia, barbarie e corruzione e via discorrendo.
Immagini e rappresentazione che producono tipi ideali e oggetti su cui intervenire: per l’appunto l’Altro, il diverso, ossia concetti od oggetti geografici come il Sud Italia o Palermo o Napoli: entità geografiche tutte omogenee, senza differenze al loro interno. Altro modo per spiegare come funzionano le rappresentazioni e le immagini, molto simile al metodo de La mala setta è il modello teorico utilizzato da Edward Said in Orientalismo. Said decostruisce tutte le rappresentazioni prodotte nel corso del ‘700 e dell’800 sull’Oriente, come entità geografia omogenea e come cultura e ideologia anch’esse omogenee, e in quanto tali artefatte. E nel decostruire Said spiega anche come funzionino quei discorsi e a quali interessi e fini corrispondano (la colonizzazione politica ed economica). Se si individua il Sud e la sua popolazione, che li si tratti come terreno per l’azione politica, come luogo connotato da una storia o da una cultura politica caratteristiche, come oggetto di appartenenza, come portatore di determinati tratti psicologici, come somma delle diverse realtà sociali interne e differenti in esso; il sud resta sempre e comunque un concetto, un oggetto, un tutto organico, dove è più facile intervenirvi tramite rappresentazioni e nel riprodurre immagini che diventano poi reificazioni. Immagini che funzionano – e vengono subite – anche in chi vive il Sud, giungendo ad auto percepirsi così come viene rappresentato, disegnato in base a cliché diffusi nel senso comune.
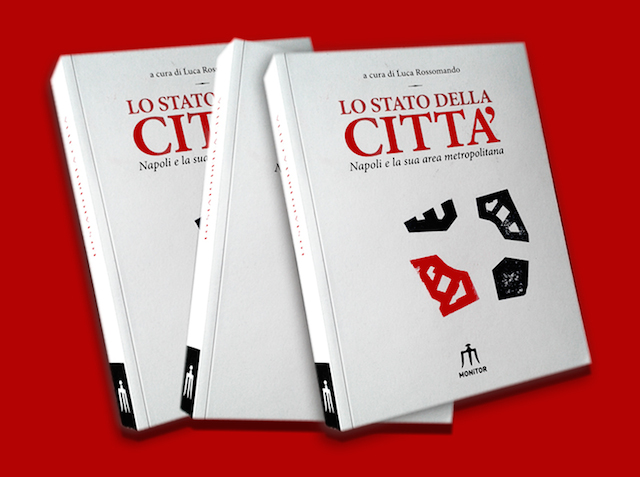 Indubbiamente l’azione riflessiva della rappresentazione non consente, se non attraverso una chirurgica sottrazione politica e culturale, di sfuggire ai discorsi mainstream, i quali catturano all’interno della categoria di camorra e di camorrista (o di mafia e di mafioso), tanto capziosamente quanto ideologicamente, ogni iniziativa sociale che incuta pericolosità politica. Esemplare è l’editoriale di Stefano Folli su la Repubblica, all’indomani dell’insediamento del Commissario speciale per Bagnoli e delle manifestazioni di protesta alla visita di Renzi a Napoli, in cui sostiene, richiamando quel preciso ordine del discorso, che i “centri sociali sono infiltrati dalla camorra”. Oppure, del settembre 2014, l’editoriale di Paolo Macry sul Corriere del Mezzogiorno, “I ghetti di Napoli e le responsabilità della politica”, uscito qualche giorno dopo la morte del diciassettenne Davide Bifolco, sparato da un carabiniere di servizio, e dopo le manifestazione spontanee di protesta nel quartiere di Soccavo. Scriveva Macry: “‘Lo Stato non ci difende ma ci uccide. Difendiamoci’, diceva ieri uno slogan al Rione Traiano. È questo il confine che separa e circoscrive il ghetto: il rifiuto dello Stato e della sua forza legittima […] In alto, come suol dirsi, le responsabilità sono enormi. Ma é anche vero che, quando un intero territorio diventa ghetto e si chiude nella propria logica antagonista, riportarlo nello Stato é cosa assai difficile”. Questa rappresentazione non lascia spazio ad altre interpretazioni: o stato o camorra. E se lo stato e la camorra mantenessero una condizione di correità? Se all’interno dell’ordine si rifletta il disordine e viceversa? E ancora: tra stato e camorra vi sono vie di fuga? Possibile immaginare e costruire relazioni sociali ed economiche emancipate dalla violenza e dalla forza tanto legale quanto criminale?
Indubbiamente l’azione riflessiva della rappresentazione non consente, se non attraverso una chirurgica sottrazione politica e culturale, di sfuggire ai discorsi mainstream, i quali catturano all’interno della categoria di camorra e di camorrista (o di mafia e di mafioso), tanto capziosamente quanto ideologicamente, ogni iniziativa sociale che incuta pericolosità politica. Esemplare è l’editoriale di Stefano Folli su la Repubblica, all’indomani dell’insediamento del Commissario speciale per Bagnoli e delle manifestazioni di protesta alla visita di Renzi a Napoli, in cui sostiene, richiamando quel preciso ordine del discorso, che i “centri sociali sono infiltrati dalla camorra”. Oppure, del settembre 2014, l’editoriale di Paolo Macry sul Corriere del Mezzogiorno, “I ghetti di Napoli e le responsabilità della politica”, uscito qualche giorno dopo la morte del diciassettenne Davide Bifolco, sparato da un carabiniere di servizio, e dopo le manifestazione spontanee di protesta nel quartiere di Soccavo. Scriveva Macry: “‘Lo Stato non ci difende ma ci uccide. Difendiamoci’, diceva ieri uno slogan al Rione Traiano. È questo il confine che separa e circoscrive il ghetto: il rifiuto dello Stato e della sua forza legittima […] In alto, come suol dirsi, le responsabilità sono enormi. Ma é anche vero che, quando un intero territorio diventa ghetto e si chiude nella propria logica antagonista, riportarlo nello Stato é cosa assai difficile”. Questa rappresentazione non lascia spazio ad altre interpretazioni: o stato o camorra. E se lo stato e la camorra mantenessero una condizione di correità? Se all’interno dell’ordine si rifletta il disordine e viceversa? E ancora: tra stato e camorra vi sono vie di fuga? Possibile immaginare e costruire relazioni sociali ed economiche emancipate dalla violenza e dalla forza tanto legale quanto criminale?
Oppure famose sono le due inchieste su Napoli di Giorgio Bocca, all’interno delle quali si percepiscono nitidamente i tratti dell’orientalismo. Nel 1990, Bocca non esitò a partire lancia in resta contro le regioni meridionali infestate dalle mafie. Secondo Bocca, la divaricazione tra Nord e Sud dei risultati elettorali era riconducibile alla classe politica trasformista e corrotta, con radici ben solide nella società meridionale incapace di comprendere il senso della modernità, ma pronta a concedere tutto al proprio pessimo elettorato in cambio di sostegno. Soltanto il titolo del libro, L’Inferno, era saturo di allusioni storiche, rinviando al più famoso adagio, ripreso da Benedetto Croce nel 1923, che ricordava come il Mezzogiorno fosse sì un paradiso, ma popolato da diavoli. A suo dire, Bocca non aveva alcuna intenzione di mostrare un atteggiamento antimeridionale o razzista, anche se la sua inchiesta sul Mezzogiorno è pregna di descrizioni scontate, di cliché, di descrizioni paesaggistiche vecchie di secoli. Stereotipi per sostenere la tesi che la tradizionale classe politica, delegittimata al Nord, al Sud invece aveva ancora acqua in cui riprodurre il proprio consenso; e allo stesso tempo, Bocca voleva risvegliare la società meridionale e “scardinare un sistema politico foriero di tante nequizie”. E nell’auspicio che da Nord giungesse a Sud una nuova resistenza, che il secessionismo nordista alleato di una politica del Rinascimento meridionale scardinasse la corruzione, la criminalità e le condotte “putrescenti”, Bocca intravedeva un rischio: in questi meccanismi interattivi, come vasi comunicanti, il Mezzogiorno avrebbe potuto infettare il resto dello “stivale” con l’illegalità e l’immoralità. Infatti, nel 2006, in Napoli siamo noi, la sua lettura del Mezzogiorno si fa ancor più sconfortata: l’infezione dell’illegalità gli sembrava avere ormai risalito la penisola e il degrado meridionale, anziché eccezione nel panorama nazionale, gli pareva la mostruosa raffigurazione di una linea di tendenza ormai generalizzata.
Uno sguardo altro o una via di fuga dall’orientalismo e dalle tipizzazioni naturalizzanti lo si ritrova in Come si diventa camorristi. La trasformazione di una società meridionale di Marco De Biase. Con una mossa di sottrazione e poi di illuminazione delle cause, l’autore toglie terreno alle analisi sulle caratteristiche, sulla natura, sui comportamenti, per registrare come l’attività camorristica sia il punto di arrivo di un processo sociale e politico di formazione, all’interno del quale il senso comune, l’ideologia e le rappresentazioni fungono da variabili essenziali. A ben guardare, un recente articolo di Luciano Brancaccio, La camorra dei mercati, (presente nel volume collettivo Lo stato della città. Napoli e la sua area metropolitana, a cura di Luca Rossomando, Monitor Edizioni, 2016) consolida questa tesi: vale a dire, “la camorra non una variabile esogena che emerge da un mondo oscuro penetrando il mondo economico. Ma il frutto, il risultato dell’operare congiunto di fattori di ordine storico che favoriscono la trasformazione di un’attività imprenditoriale in attività mafiosa”. Come si diventa camorristi è una ricerca condotta in un paese rurale dell’avellinese. Non una città. Ma un paese, senza condizioni tipiche da accogliere fenomeni simili. Cionondimeno vi è nata un’organizzazione camorristica. A dimostrazione di come ciò che facilmente riconduciamo alla natura, e chiamiamo ethnos, coincide con una rigida pianificazione. Ciò che chiamiamo costumi deviati e riconduciamo volentieri alla dimensione dell’etica, coincide parimenti con la stessa pianificazione. Balfield, autore di una ricerca degli anni ‘50, di classica impostazione neopositivista sulla questione meridionale, e ideatore del concetto (ancora in voga) di Familismo amorale – quale causa dell’arretratezza meridionale – s’interrogava sulla possibilità che un intervento dall’alto potesse deviare dal proprio corso il tempo immobile delle popolazioni meridionali, aiutarle a venir fuori dal loro atavismo culturale; e concludeva che non esistono prove sulla possibilità di cambiare l’ethos di una popolazione in base a un piano determinato. Come si diventa camorristi presenta inequivocabilmente che è la politica, l’economia, il piano a produrre l’etica; che le rappresentazioni e il senso comune plasmano i contesti urbani e producono a loro volta il sociale. Nel caso di Come si diventa camorristi è stato il terremoto, il post terremoto e la fine di quel ciclo economico che hanno generato disillusione, fine delle aspettative, fallimenti economici, cause per cui alcuni – o molti – hanno poi scelto la strada emulativa delle pratiche violente e delle attività camorristiche per sostenere ancora quelle condotte e quelle scelte economiche e politiche.