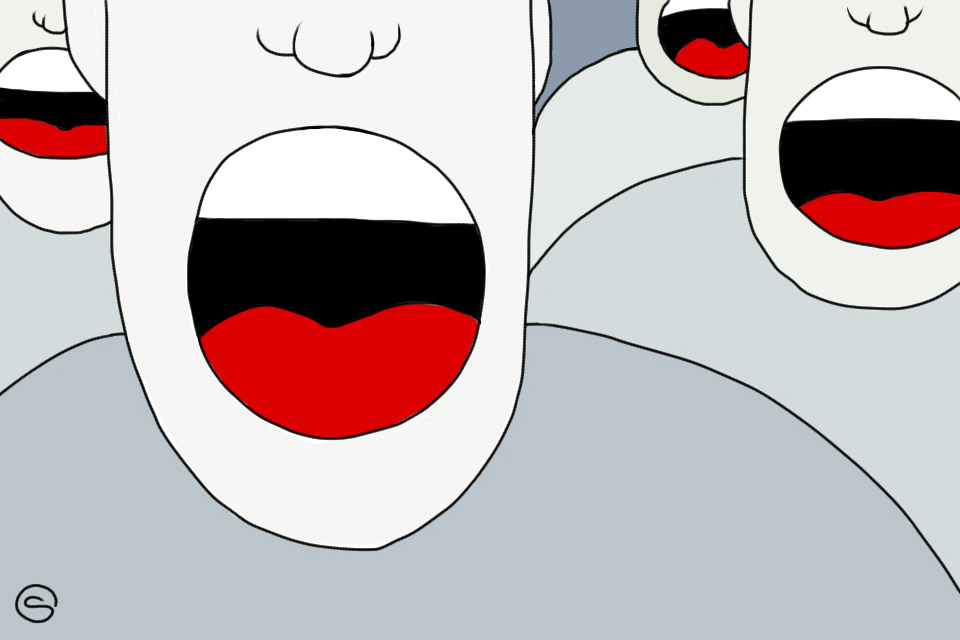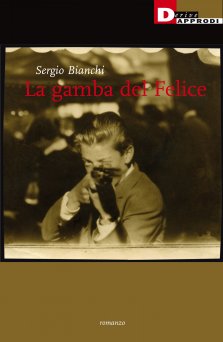di GIROLAMO DE MICHELE.
Trump prima di Trump: la parodia anticipante di DFW
Occuparsi delle elezioni presidenziali statunitensi senza farsi trascinare dal sempre misero gioco del “tifare per”, significa chiedersi a cosa fanno segno alcune novità: ad esempio la “variante Sanders”, scioccamente catalogata come “populista” da chi, avendo sprezzato come modernariato radicaleggiante i movimenti come Occupy dai quali Sanders trae linfa, ricorre a un lemma buono per tutte le stagioni, dunque per nessuna.
E soprattutto Donald Trump, del quale non può sfuggire il fatto che David Foster Wallace, nel suo capolavoro Infinite Jest, abbia saputo descrivere i tratti essenziali con vent’anni di anticipo; per citare uno fra i tanti howling fantods ad averlo notato,
Usually parodies are written after the thing they parody. Leave it to David Foster Wallace, though, to break that rule and make fun of an event long before it happened.
Infinite Jest è, fra le molte cose, una narrazione distopica sull’intreccio fra capitale finanziario (yes, I know, questo sintagma nel libro non c’è: il che ha creato problemi di comprensione per qualche Zdanov de’ noantri), e intrattenimento come processo di assoggettamento. In un’America nella quale gli USA si sono annessi di fatto Canada e Mexico, il presidente che ha creato un gigantesco muro per isolare Maine e Baia di Hudson e farne una enorme discarica per rifiuti è John Gentle, the Famous Crooner, «il fondatore del nuovo Partito Pulito degli Usa che era stato per tre anni una specie di barzelletta nazionale post-Perot, finché il Ppusa, senza che nessuno se lo aspettasse, si aggiudicò la vittoria per il quadriennio grazie allo spasmo reazionario di un elettorato incattivito, e quelli dell’Uwsa e di LaRouche e i Libertari si mangiarono le mani per l’invidia mentre i Democratici e i Repubblicani rimasero fermi a guardare ammutoliti, come due compagni di doppio che pensano che la palla la prenderà sicuramente l’altro»:
Johnny Gentle, che invocò nel suo Discorso Inaugurale una Nazione più Ordinata e Pulita. Che promise di ripulire il governo e farlo dimagrire e spazzare via i rifiuti e lavare con gli idranti le nostre strade infestate di sostanze chimiche e di dormire pochissimo finché non avesse trovato il modo di liberare la psicosfera americana dagli spiacevoli rottami di un passato da buttare, che promise di liberare dagli effluvi tossici che asfissiano le nostre autostrade e imbrattano le strade secondarie e rovinano i nostri tramonti e insozzano quei porti nei quali sono ancorate le chiatte piene di spazzatura che si vedono in televisione (il primo presidente degli Stati Uniti a dire la parola merda in pubblico, rabbrividendo), le chiatte rugginose che scarrocciano su e giù per le coste sudice di petrolio o galleggiano puzzolenti a emettere CO mentre aspettano l’apertura di nuove discariche interrate e depositi tossici che il Popolo chiede a gran voce ma mai nella propria città. Il Johnny Gentle, Capo del Governo, che tira sul podio un pugno guantato di gomma così forte da far quasi staccare il Sigillo e dichiara che, Cazzo ci deve essere qualcuno, a parte noi, a cui dare la colpa. Per unirci nell’opposizione a qualcuno. E promette di mangiare leggero e dormire molto poco fino a che non li troverà – tra gli ucraini, o i teutoni, o quei pazzi dei latini. È probabile – e qui fa una pausa con un braccio alzato e il capo basso come faceva a Las Vegas nei momenti topici – che siano più vicini a noi di quanto non si possa immaginare. Giura che troverà un Altro che farà nascere di nuovo coesione e rinnovamento. Poi prenderà delle decisioni importanti [Infinite Jest, pp. 459-462].
 Come Gentle, Donald Trump non considera accettabile alcuna forma di imperfezione, e considera se stesso dotato (così come Howard Hughes, il suo punto di riferimento) di quella infallibile capacità di guidare l’America: «Il Presidente J.G., il Famoso Crooner che disse che non ci avrebbe chiesto di fare delle scelte difficili approfittando della sua posizione, perché quelle scelte le avrebbe fatte lui per noi: voleva soltanto che ci rilassassimo e ci godessimo lo spettacolo».
Come Gentle, Donald Trump non considera accettabile alcuna forma di imperfezione, e considera se stesso dotato (così come Howard Hughes, il suo punto di riferimento) di quella infallibile capacità di guidare l’America: «Il Presidente J.G., il Famoso Crooner che disse che non ci avrebbe chiesto di fare delle scelte difficili approfittando della sua posizione, perché quelle scelte le avrebbe fatte lui per noi: voleva soltanto che ci rilassassimo e ci godessimo lo spettacolo».
Come Gentle, che «prevedeva di tagliare l’adipe budgetaria con un coltello bello grosso», Trump promette un immediato e radicale taglio del bilancio governativo: «We are going to ask every department head in government to provide a list of wasteful spending projects that we can eliminate in my first 100 days. The politicians have talked about this for years, but I’m going to do it» [qui].
Con Gentle, Trump condivide l’avversione per il sonno – «I don’t sleep more than four hours a night» [qui]; «I have friends who are successful and sleep ten hours a night, and I ask them, “How can you compete against people like me if I sleep only four hours?”» [qui], e il culto dell’aspetto esteriore, in particolare dei capelli: «Il Johnny Gentle che con il suo Ppusa ha capito per primo che il rinnovamento americano non poteva che essere una questione estetica».
Tratti gentleani di fatto di Trump sono altresì il complottismo, dal surriscaldamento globale creato dai cinesi per colpire l’industria americana alle false voci sulla nocività dell’amianto, la cui rimozione dal Word Trade Center è stata la vera causa del crollo delle Torri l’11 settembre.
.@dubephnx If we didn’t remove incredibly powerful fire retardant asbestos & replace it with junk that doesn’t (cont) http://t.co/d10u18dh
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 ottobre 2012
Ma soprattutto, Gentle e Trump condividono la fobia dei germi e dello sporco, l’avversione per la stretta di mano e il contatto fisico: una misofobia che per Trump è forse la causa soggettiva della sua xenofobia. Non c’è bisogno di leggere Foucault (anche se aiuta) per comprendere come l’ossessione immunologica abbia uno stretto collegamento, storico oltre che psicologico, con la nascita del razzismo moderno, fondato non più sul rispecchiamento dei conflitti fra nazioni nelle differenze fra popoli, ma sulla classificazione dell’Altro come infetto, impuro, contagioso.
Chiedersi a cosa fa segno il successo di Trump, il suo genuino populismo, significa far uso del pensiero critico per interpretare non solo l’America che viene, ma quella che ruggisce dalla sua pancia profonda – a condizione di non farsi prendere dal sociologismo remissorio per un subproletariato prodotto dalla crisi che costituirebbe la base sociale di una qualche barbarica ribellione. Significa indagare non solo, com’è ovvio, la composizione di classe di questi nuovi barbari, ma anche i processi di soggettivazione che li hanno generati: per riconoscerne evidenti analogie in processi molto più vicini, in termini geografici, a noi.
Odisse nel rancore della pubblica opinione
È un libro solo in apparenza marginale a fornirci, sul rovescio della trama, qualche preziosa indicazione: Tabloid inferno. Confessioni di una cronista di nera di Selene Pascarella (Alegre, 2016). Collaboratrice per anni di una stampa pulp costituita da un sottobosco di riviste che vivono ai margini della cronaca nera – meglio: che ne prendono spunto per ricrearla ad uso delle passioni di un pubblico rancoroso –, Pascarella ne racconta i meccanismi specifici, i frame, le strutture di base:
Il racconto di nera è un flusso continuo. Un delitto non è mai un delitto ma una novel fiction che si sviluppa nell’arco di anni. Occorre tenere le fila di vicende orizzontali complicatissime e inserire sviluppi verticali guardando sia al fruitore di lungo corso che al neofita. Il finale deve sempre essere lasciato aperto e allo stesso tempo bisogna inserire paletti riconoscibili per aiutare il lettore a formulare un giudizio sui fatti [p. 32].
La narrazione di nera ha una mission: mescolare la narrazione giudiziaria – “i racconti giudiziari tendono a far sembrare il mondo di per sé evidente, una storia continua che eredita il passato legittimato” [J. Bruner, La fabbrica delle storie] – con la finzione letteraria che “evoca il familiare allo scopo di turbare le nostre aspettative si di esso [ib.]”, creando il verosimile con l’imitazione della realtà. Mescolando i due stili, le narrazioni di nera realizzano “una forma di continuità retroattiva” che riadatta “il passato ai nuovi sviluppi narrativi, mettendo in una diversa luce eventi già descritti, azioni date per acclarate. L’universo che unisce narrativa, racconto giudiziario e cronaca diviene più coeso ad ogni aggiustamento retroattivo, sfumando le discrepanze fra i territori di origine fino a rendere irriconoscibili i confini” [pp. 83-84].
In questo modo, Pascarella ci mostra la costruzione di un’opinione pubblica pulp, così come altri due studi sugli hate speechs – L’odio on line di Giovanni Ziccardi e Morti di fama di Lipperini e Arduino – mostrano le dinamiche della cultura dell’odio on line sul quale ha preso posizione anche Stephen King (a proposito di un articolo del “Time”).
Good cover story in TIME about the growing culture of hate on the internet. Helps to remember TROLL rhymes with ASSHOLE.
— Stephen King (@StephenKing) 19 agosto 2016
Ma Pascarella dice anche di più: mostra la costruzione dell’opinione pubblica pulp, e al tempo stesso mostra come i desideri e le passioni tristi di un’opinione che si abbevera nel rancore costruisce un’informazione dalle quale si attende neverendig stories e colpevoli verosimili ma alternativi, per soddisfare quel desiderio notturno di fare a pezzi con l’immaginazione i nemici che sublima le cattive inclinazioni cui non è possibile dare seguito di giorno. Per il momento.
Di più: Pascarella mostra – pur senza affrontarle – anche le dinamiche della progressiva pulpizzazione dell’informazione mainstream, che scivolando nel gorgo del sottobosco pulp, ne condividono le narrazioni tossiche. E spiega, così come i libri di Ziccardi e Arduino-Lipperini, come sia la narrazione a costruire realtà che a loro volta richiedono narrazioni orientate alla ricerca del nemico: di un nemico fittizio ma verosimile.
Senza ricorrere a Spinoza e Gramsci – con buona pace per gli interdetti di Tronti e Bordiga, beninteso – basta usare la testa per capire il circolo vizioso, il feedback negativo che si genera fra la causa e l’effetto: esistono ragioni profonde per spiegare il rancore delle piccole comunità periferiche, che si percepiscono escluse, se non vittime, dai processi globali che sembrano scavalcarle – sulle quali ha scritto cose importanti Aldo Bonomi, da Il rancore fino a La società circolare, passando per La comunità maledetta, che non per caso teneva sullo sfondo la guerra civile nella ex-Jugoslavia. Ma la comprensione delle cause di lungo periodo non può trasformarsi in un alibi sociologizzante per tradurre in assoluzione la comprensione del carattere politico di questo rancore.
Un rancore che oggi si mostra, senza alibi né giustificazioni, nella feccia razzista di Gorino.
Il paese dalle finestre che ridono
 Davvero bizzarro il fatto che i cantori delle comunità del rancore, i teorici dell’organizzazione dei nuovi barbari – alla Formenti, per capirci –, quelli che sognano di guidare il terremoto di notte, e di giorno vagano come ebeti don Chisciotte in giro per il mondo, incapaci di leggervi altro che la conferma dei propri segni e dei propri sogni e l’ipostatizzazione del proprio atavico risentimento, abbiano taciuto sulla rivolta di Gorino. Niente letture della composizione di classe delle barricate razziste della bassa ferrarese, neanche da chi non si era fatto scrupolo di glissare sul sessismo di Trump definendolo “linciaggio mediatico” (ma una qualche compagna femminista “a piede libero” che gli conficchi nel cranio un paio di concetti basilari?); di costruire narrazioni pulp-complottarde sull’omicidio della deputata labourista Jo Cox nei giorni precedenti la Brexit; di esaltare l’inevitabile barbarie del fasciojihadismo sputando sulla memoria della compagna Valeria Solesin (una misera frequentatrice dell’ambiente accademico che andava a “consumare il meritato aperitivo in un Bataclan qualsiasi”): davanti alle barricate di Gorino non ci sono alibi che tengano. Davanti a poche donne indifese, per di più cristiane, non c’era alibi che potesse mascherare il fatto che non le volevano perché sono delle negre, di quelle che sporcano le corriere, scimmie inferiori come i negri dell’Etiopia che la fascistissima nonna Elena da Gorino ha sfruttato ai tempi della sua gioventù colonialista. Calarsi nel flusso di questa barbarie populista ha un prezzo: quello di ritrovarsi a cantare tutti insieme – da Naomo Lodi ai fascisti del terzo millennio, passando per gli Skrewdriver – Il domani appartiene a noi.
Davvero bizzarro il fatto che i cantori delle comunità del rancore, i teorici dell’organizzazione dei nuovi barbari – alla Formenti, per capirci –, quelli che sognano di guidare il terremoto di notte, e di giorno vagano come ebeti don Chisciotte in giro per il mondo, incapaci di leggervi altro che la conferma dei propri segni e dei propri sogni e l’ipostatizzazione del proprio atavico risentimento, abbiano taciuto sulla rivolta di Gorino. Niente letture della composizione di classe delle barricate razziste della bassa ferrarese, neanche da chi non si era fatto scrupolo di glissare sul sessismo di Trump definendolo “linciaggio mediatico” (ma una qualche compagna femminista “a piede libero” che gli conficchi nel cranio un paio di concetti basilari?); di costruire narrazioni pulp-complottarde sull’omicidio della deputata labourista Jo Cox nei giorni precedenti la Brexit; di esaltare l’inevitabile barbarie del fasciojihadismo sputando sulla memoria della compagna Valeria Solesin (una misera frequentatrice dell’ambiente accademico che andava a “consumare il meritato aperitivo in un Bataclan qualsiasi”): davanti alle barricate di Gorino non ci sono alibi che tengano. Davanti a poche donne indifese, per di più cristiane, non c’era alibi che potesse mascherare il fatto che non le volevano perché sono delle negre, di quelle che sporcano le corriere, scimmie inferiori come i negri dell’Etiopia che la fascistissima nonna Elena da Gorino ha sfruttato ai tempi della sua gioventù colonialista. Calarsi nel flusso di questa barbarie populista ha un prezzo: quello di ritrovarsi a cantare tutti insieme – da Naomo Lodi ai fascisti del terzo millennio, passando per gli Skrewdriver – Il domani appartiene a noi.
In verità, Gorino mostra tutta intera la faccia di quel livore comune alla lower-middle class rurale britannica che ha avuto un ruolo determinante nella Brexit e al ceto sociale che negli Stati Uniti sostiene Trump – con una differenza: qui non è possibile tirar fuori a cazzo una fantasmatica working class, britannica o nordamericana, che salvi la capra marxista e il cavolo populista. Gli abitanti di Gorino hanno paura dei migranti, o meglio della loro ombra (ma non della propria ignoranza) perché vivono in luoghi dove i migranti non ci sono, e difendono con ferocia la loro pervicace intenzione di rimanere immobili in un mondo attraversato da mutazioni irreversibili.
 Come quella lower-middle class britannica che ha votato Leave, vivono prevalentemente in provincia, non conoscono i migranti, ma proprio per questo li temono ancor più di chi ne è a contatto e non ha uno status generazionale da difendere; hanno un medio-basso titolo di studio; non sono culturalmente e socialmente attrezzati a far fronte alle trasformazioni sociali portate dalla globalizzazione.
Come quella lower-middle class britannica che ha votato Leave, vivono prevalentemente in provincia, non conoscono i migranti, ma proprio per questo li temono ancor più di chi ne è a contatto e non ha uno status generazionale da difendere; hanno un medio-basso titolo di studio; non sono culturalmente e socialmente attrezzati a far fronte alle trasformazioni sociali portate dalla globalizzazione.
Difendono un individualismo proprietario gretto e arraffatore, attraversato da tutte le sfaccettature del rancore che esprimono il “reale” Trump e il letterario, ma proprio per questo realissimo, Johnny Gentle. Difendono un mondo chiuso, omertoso, del quale aveva già narrato tutto La casa dalle finestre che ridono: come dimostra un delitto di paese, l’assassinio di Willy Branchi, avvenuto proprio in quei luoghi e avvolto da trent’anni di silenzi, che sembra scritto da Pupi Avati (o Selene Pascarella).
Solo chi è incapace di leggere i processi di soggettivazione che creano una plebe reazionaria (il movimento dei forconi non ha insegnato niente?) che presunti apprendisti stregoni credono di poter governare – così come gli apprendisti del Tea Party credevano di fare, inconsapevoli di star creando le condizioni che hanno permesso a Trump di lanciare un’OPA sul GOP – non vede, evidentissimi, i segni di un populismo fascista rispetto al quale, come diceva un filosofo tedesco (citando un saggio orientale), occorre tracciare una chiara linea di demarcazione: che è, con buona pace di chi crede che “intellettuale” sia un epiteto, il modo filosofico-politico più corretto di tradurre e interpretare l’espressione “pensiero critico”.