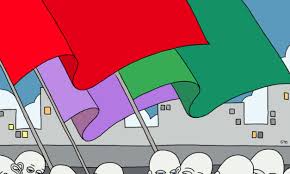di TONI NEGRI.
Queste note erano state preparate prima del convegno sui populismi tenutosi a Roma tra il 16 e il 18 giugno 2017. Sono state poi integrate tenendo presenti gli sviluppi della discussione.
Il populismo nel moderno: l’istituzione demagogica del monarca
Quand’ero giovane, nel secondo dopoguerra, non c’era dubbio che il populismo fosse una cosa di destra, di estrema destra. Quel che aveva detto Carl Schmitt nello scritto dedicato al movimento nazista nel ’33, corrispondeva a ciò che nel populismo riconoscevamo: un regime dove «da cima a fondo e in ogni atomo del popolo la leadership dominava» e dove «l’identità nazionale costituiva/imbeveva la base psicologica e antropologica d’ogni interesse e desiderio politico del popolo».
Poteva esserci un «populismo di sinistra» immersi, come allora eravamo, nel moderno? Quando il politico fosse saldamente ancorato alla sovranità nazionale ad egemonia capitalista? Lo escludevamo. Ed anche quando esso appariva con evidenza, ad esempio nel «nazional-popolare» del PCI, lo consideravamo un peccato minore: divenne maggiore solo più tardi quando il PCI, con insolenza, cominciò a sfumare la sua natura di classe e a presentarsi esclusivamente come «partito di tutto il popolo».
I primi dubbi sulla possibilità di una diversa qualificazione del populismo cominciarono ad essere sollevati davanti all’esperienza argentina del partito peronista, prima considerato para-fascista, poi dubbiosamente assunto, come modello ambiguo a struttura para-democratica – episodica e transitoria nella mutazione politica di un paese del sottosviluppo. Finché non arrivò Laclau.
Torniamo a noi: c’era comunque stato un populismo tra la fine del XIX e il XX secolo, affermatosi nel declino della modernità, che era sempre stato di destra. Era una risposta alla crisi dello Stato sovrano della modernità attorno a tre punti.
Primo: un rimedio all’incapacità che lo Stato aveva di mediare la molteplicità degli interessi, delle contraddizioni e degli antagonismi che si esprimevano nella società, entrata nel capitalismo maturo.
Secondo: un tentativo di superare quella crisi attraverso l’affidamento ad una nuova legittimità incarnata dalla triade popolo-nazione-patria.
Terzo: al richiamo ai valori ingenui e leali del popolo, del luogo d’origine, contro l’astrazione del lavoro e la mercificazione della vita, e contro le esauste strutture della democrazia rappresentativa, poteva opporsi l’energia di un leader capace di assemblare i soggetti, di interpretarne i bisogni e di decidere un progetto.
È opportuno subito sottolineare che, nel perpetrare questa missione, nello sviluppo del populismo si compenetrano e reciprocamente si implicano tutti gli elementi ricordati, in una circolarità da cui è impossibile uscire. Guardiamo l’avviluppo dal primo punto, laddove il populismo (del moderno) si presenta come risposta alla difficoltà sempre più grande di rispondere alla molteplicità di interessi contraddittori e di antagonismi che la società capitalista matura esprime. Il progetto di costruzione della mediazione lo si coniuga qui con l’urgenza di riattivare la sovranità come luogo del comando: quale miglior figura a questo scopo della traduzione della sovranità nella leadership? Si può dire, riferendosi alla classificazione classica delle forme di governo (monarchia/aristocrazia/democrazia e il loro rovescio «cattivo»: tirannide/oligarchia/demagogia, che stanno in rapporto complementare e ciclicamente progressivo) che qui ci si trovi a fronte del «lato cattivo» della democrazia, e cioè sul punto nel quale, nel ciclo delle forme di governo, a fronte della crisi democratica, cioè alla demagogia, segue la restaurazione del potere monarchico. Il populismo in questo caso lo si può classificare come istituzione demagogica del monarca, del potere di uno solo.
Ma non è che le cose, in questo caso, vadano al meglio. La reductio ad unum della sovranità apre contraddizioni multiple e a svariate aporie. È per questo che, sempre nel quadro della modernità, il richiamo alla leadership cerca nuova legittimità nel ricorso al popolo/nazione/patria. Una cosa solida dove Ortung e Ordnung, nazione/terra e ordine combacino ed il potere si dia come corpo del sovrano. Si esalta così, nel populismo, una concezione leviatanesca del potere (molto al di là di quanto concepito da Hobbes): una potenza organica, una forza senza relazione che trova limite solo all’esterno di se stessa. Senonché è facile notare come, anche in questo passaggio, il richiamo valorifico e legittimante sia aperto a multiple contraddizioni. Guardiamo quella estrema: qual è la sigla del richiamo alla triade populista? Essa può essere materiale (la tradizione, la lingua, l’antropologia e le forme di vita, come vuole Carl Schmitt) oppure può darsi in termini di egemonia/eccezionalità sovrana e carismatica (come pretende Laclau). Può cioè essere reazionaria o conservatrice, aprire alla barbarie della consuetudine e del razzismo e a quella della guerra, oppure essere semplicemente identitaria ed aperta a segni progressisti dell’egemonia sovrana. Insomma, la seconda faccia del populismo (nel regime della modernità) come figura di governo e di assemblaggio politico con riferimento al «popolo», sta fra eccezione e formalismo sovrani – figure comunque instabili e oscillanti, scivolose verso il nichilismo, caratteristico segno della fine del moderno.
Si può dunque, al termine di un primo percorso, concludere (e può confermarlo qualsiasi analisi della vicenda populista in America Latina come in Europa, da valutare comunque dentro prospettive diverse) che il populismo è più un segnale della crisi che un suo consistente superamento. È più un problema che la sua soluzione. Se il populismo di destra nasce come proposta reazionaria per bloccare le contraddizioni dell’esercizio della sovranità tra XIX e XX secolo in regime di maturità e crisi del capitalismo, nel suo riprodursi alla fine del XX secolo propone figure irrealistiche di legittimazione e di efficacia giuridica.
Il populismo nel postmoderno: un fantasma senza sostanza
Tuttavia, dobbiamo vedere se esso (in particolare il populismo di sinistra) non sia un sintomo di altri sviluppi ed analizzarlo in quanto tale, seguendo l’indicazione metodica althusseriana che considera il sintomo sia un segno di realtà, sia la falsificazione di questa. Esso sembra infatti presentarsi, come vedremo, quasi come un effetto di implicazione paradossale e talora configurarsi configurarsi come indicazione, specifica e mistificata, del ricomparire del politico a fronte del modo di produrre nel postmoderno – ci si lasci dire, a fronte del comune. È in riferimento a quest’ultima mistificazione del sintomo che attraversa il populismo, eventualmente di sinistra, che l’analisi va condotta e il sintomo riconosciuto, rovesciato e combattuto.
Oggi dunque le condizioni che hanno costruito il populismo nella modernità non si ci sono più. Il populismo che si presenta oggi nel postmoderno (nel postfordismo e nell’età digitale) sulla scena politica è uno scarno copione di quello sviluppatosi nella modernità e infine derivato nel fascismo. È un fantasma senza sostanza. Perché? Essenzialmente, perché le contraddizioni che, nello Stato sovrano della modernità, il populismo cercava di mediare e/o risolvere in termini di leadership, sono divenute strutturali. Il declino del ceto medio e l’estinzione della società civile, nonché la metamorfosi digitale e sociale del lavoro e la dissoluzione dei vecchi gruppi corporativi (inclusi quelli rappresentanti la classe operaia) determinano una conflittualità ed un antagonismo sociali a fronte dei quali la proposta populista può solo moltiplicare la produzione di soluzioni illusorie. Laddove il soggetto politico sia frantumato, può darsi che risulti possibile istituire demagogicamente una leadership. Ma la situazione non può essere considerata stabile nè le contraddizioni risolte. Dove il populismo insiste per la partecipazione, la moltitudine (il soggetto frantumato e moltiplicato) determina effetti di destituzione (si veda, ad esempio, l’aumento del rifiuto di partecipare alle elezioni e molti altri aspetti simili nell’attuale momento politico). Altrettanto si può dire per quanto riguarda l’efficacia della governance populista: qui la moltitudine (il soggetto frantumato e moltiplicato) disconosce l’efficacia del gesto sovrano come fattore di equilibrio politico della conflittualità fra potenze sociali (ad esempio si può a tal proposito notare la pesantezza delle lotte europee sulle «leggi sul lavoro»). E quando il populismo cerca di costringere in un abito costituzionale sempre più stretto il soggetto frantumato e moltiplicato, si assiste a un gigantesco esodo della moltitudine dalle strutture dell’organizzazione politica della vita (di conseguenza, ad esempio, ne vengono le leggi di polizia e di «eccezione»).
Quando poi il populismo produca un nuovo assetto di legittimazione, costruito su popolo/nazione/patria, anche questa operazione sembra poco realistica. Dove si colloca più la passione/nazione nel quadro del mercato globale e quale significato assume? Dov’è più la patria dopo le due grandi guerre del XX secolo e in era nucleare? E riguardo alla globalizzazione: son forse reversibili le condizioni sulle quali essa è stata costruita? Che dire poi dei posizionamenti dinnanzi alla determinante ecologica? È chiaro che a queste domande la risposta non può essere che negativa.
Questa negatività va naturalmente relativizzata. Esistono infatti importanti movimenti e comportamenti individuali diffusi che si sviluppano in contrasto alla globalizzazione e rivelano una larga fiducia non tanto nel rinnovo delle strutture «nazionali» del potere quanto nella possibilità di sviluppare lotte ed ottenere risultati dentro la dimensione globale a partire dalle condizioni nazionali. Sarebbe cieco negare queste possibilità di azione che vanno invece incrementate. Ma occorre, nel contempo, tener presente che queste lotte sono inquadrate nella scena globale. Vale a dire che invece di pensare che non esista più una possibilità politica una volta crollato il regime nazionale e sovrano della modernità, bisogna coglierne la crisi come spazio di riorganizzazione generale del sistema globale: la globalizzazione è un’occasione e non un limite.
Il populismo di sinistra: il rovescio – mistificato – del comune
Oggi il «populismo di sinistra», se interpretato (come vorremmo fare) con benevolenza, propone innanzitutto la verticalità della leadership. Di che cosa è sintomo questa rivendicazione? Di una nuova percezione del fatto che la legittimità democratica riposa su un «popolo» che, materialmente, è una molteplicità forte, un rapporto comunicativo orizzontale, un insieme di singolarità. Non si tratta più semplicemente di unificare la molteplicità ma di sussumere l’orizzontalità, l’insieme delle singolarità nella verticalità del comando. Nel muoversi in questo senso, il comando populista si oppone alla forma-orizzontale nella quale i movimenti, a partire dal 2011, hanno organizzato le lotte, le occupazioni, e si sono espressi in favore della leaderless e contro rappresentanza e gerarchie politiche. Il populismo di sinistra trasforma quindi il fenomeno leaderless (ci si è permesso di abbreviare così il ragionamento) nel suo contrario, assumendo il rifiuto della rappresentanza (della casta, di un sistema politico ossificato, ecc.) e dell’«autonomia del politico» come materia della trasformazione «rousseauiana» della molteplicità nell’Uno sovrano.
Come reagire a questa operazione? Insistendo sul fatto che non è mistificabile e riducibile in maniera autoritaria quella orizzontalità che le lotte hanno costruito. Essa propone di fondare ogni legittimità sociale sui progetti politici che dai movimenti moltitudinari promanano. Ogni strategia politica e sociale è dei movimenti e non può espropriata. La trasfigurazione verticale della molteplicità mistifica quanto c’è di più nuovo e forte nella figura dei movimenti oggi: il fatto di trattenere la strategia politica in se stessi e di cercare di organizzarla, di costruirla e di svilupparla in «istituzioni-non-sovrane». Dentro la mancanza di unità dell’«insieme di singolarità» della moltitudine (ché così la si vede dal basso mentre dall’alto era vista come soggetto frammentato) vive piuttosto il desiderio di formare un’ontologia plurale e cooperativa di coalizioni politiche. Molti movimenti parlano ormai in termini di interelazionalità, di connessioni variabili e potenti di rivendicazioni, di lotte e di istituzioni: così si organizza la nuova potenza della moltitudine.
Vi è poi un altro percorso sintomatico da compiere nell’analisi del populismo di sinistra, al fine di svelarne un’altra mistificazione. Nell’insistenza con la quale esso promuove i discorsi sui valori del «popolo» (nazione/patria) si possono certo riconoscere ripugnanti pulsioni identitarie e razziste. Ma c’è anche un’indistinta percezione comunitaria che va qui colta e criticata perché non è possibile irridere alla protesta contro il dominio della finanza sulla vita né alla denuncia dell’alienazione crescente che il lavoro vivo subisce nello sfruttamento/estrazione del suo valore. Non sarà difficile vedere dietro queste sofferenze del «popolo» l’oscuro riconoscimento di una operazione ben complessa e definita: quella del denaro, del capitale finanziario che sfrutta il comune, il lavoro collettivo associato, ed estrae valore dall’insieme biopolitico della natura e della società. Il populismo traduce qui le molteplicità cooperanti in un mostro unitario al quale non sa proporre che la trasfigurazione nell’identico, nell’equivalente astratto del popolo – ripetendo l’illusione del gioco dialettico, che sempre rinnova la falsificazione della realtà nel descrivere lo sfruttamento del capitale. Criticando quest’operazione, riconosciamone comunque l’efficace aggiornamento che esso opera (da parte capitalista) della mistificazione borghese nell’identificazione del nuovo soggetto dello sfruttamento: la moltitudine, innervata dal modo di produrre del comune.
È troppo benevola questa nostra valutazione del populismo postmoderno? Forse. È tuttavia utile svolgerla perché essa non apre solo alla demistificazione formale di quel processo dialettico. Ma anche ad un successivo e più importante approfondimento della critica. Nel senso dello svelamento di ciò che, rovesciado il tavolo da gioco, appare: l’urgenza di una politica di riappropriazione di quel comune, strappatogli nell’assetto finanziario dello sfruttamento da parte della moltitudine, da parte dell’insieme di soggettività potenti che la costituiscono. Smascherando lo Stato e tutte le oblique finzioni che il populismo propone, organizzando il comune in termini cooperativi, non-proprietari, costituenti.
Una politica della solidarietà e del comune
Un ultimo capitolo. C’è una caratteristica del populismo postmoderno (larvatamente in quello di sinistra) ed è di farsi concubino del neoliberalismo. Come? Lo vediamo nelle versioni «centriste» del populismo (oggi particolarmente vivaci: Macron, M5S e, forse, Ciudadanos) quando la mitologia liberale del merito, del mercato e dell’imprenditorialità viene proposta contro i «lacci e lacciuoli» imposti al mercato dal vecchio sindacalismo e dalle organizzazioni degli interessi dei subordinati. Ma come? Rivendicando al lavoro, al duro lavoro del popolo il merito di costruire la ricchezza e di contribuire alla finanza/fiscalità pubblica. Gli individui diventano così popolo attraverso il lavoro – un lavoro che coordina nell’unità popolare ricchi e poveri, padroni e sfruttati, comandanti e comandati. Le regole di questo lavoro sono, né più né meno, le regole del capitalismo, del vivere nel rapporto di capitale. Ma oggi emerge una sproporzione, meglio, appare uno sfasamento, una rottura nella ripartizione del lavoro sociale fra padroni e sfruttati, meglio, fra capitale fisso e lavoro vivo. Questo sfasamento consiste nel fatto che il lavoro vivo si mostra nella forma della cooperazione. Gli sviluppi delle tecnologie cognitive e l’espansione sociale del modo di produrre, la vita messa al lavoro mostrano il lavoro non più semplicemente come forza sociale organizzata dal capitale ma come forza comune che articola e compatta la soggettivazione del lavoro vivo. Il lavoro vivo comune si oppone alla forza-lavoro comandata (nelle forme dell’individuazione mercificata). L’innovazione, l’imprenditorialità, l’accrescimento della potenza del lavoro vivo risiedono dunque fuori dall’organizzazione capitalista della produzione (e, con ciò, del popolo che lavora). È a questo punto che il populismo può essere riconosciuto come mistificazione dell’imprenditorialità della moltitudine, del comune, del lavoro vivo.
È solo a questo punto che una «politica di classe» può essere proposta. Nel promuovere un cammino che vada oltre il populismo, sottolineandone da un lato l’improponibilità nella postmodernità: ne segue che esso va semplicemente rovesciato. E d’altro lato, vien bene ed è utile l’allusione ad una politica della solidarietà e del comune che il populismo sollecita. Dunque, su questo terreno, contro la proposta di leadership populista, va sviluppata il massimo dell’opposizione democratica di base. Sul terreno sociale, lotte sindacali, lotte sul welfare, scioperi sociali; sul terreno istituzionale, proposte municipaliste e federaliste; sul terreno costituzionale, proposte di istituzioni di contro-potere e di organizzazioni orizzontali di proposta e di controllo. Si tratta di prospettare alla moltitudine il più vasto terreno sul quale l’utilizzo della aporie della molteplicità possa essere trasformato in esperienze di rovesciamento di ogni ideologia dell’identico e dell’Uno. Senza mai confondere il rifiuto della leadership con il rifiuto dell’organizzazione. Sul secondo punto, quello cioè dove la legittimazione viene cercata sul terreno nazionale, vanno apprestate scadenze e momenti di organizzazione internazionale, continentale. Sul terzo tema, programma ed esperienze alternative del comune.
Le due grandi esperienze delle lotte con i migranti e delle lotte del nuovo movimento delle donne vanno a questo punto sottolineate. La chiave da utilizzare qui è quella del coordinamento intersettoriale, è l’articolazione dei movimenti moltitudinari.
Nelle teorie della sovranità si pongono qualificazioni della sua natura in riferimento alle tre funzioni del «prendere», del «dividere» e del «produrre». Ora, nel tempo che ci si presenta, noi proponiamo contro il populismo, nel «prendere» l’esercizio orizzontale della potenza della moltitudine contro la verticale sovrana; nel «dividere», l’articolazione del comune contro l’ipostasi «popolo»; e nel «produrre», l’imprenditorialità della moltitudine e il «rifiuto del lavoro» organizzato dal capitale.