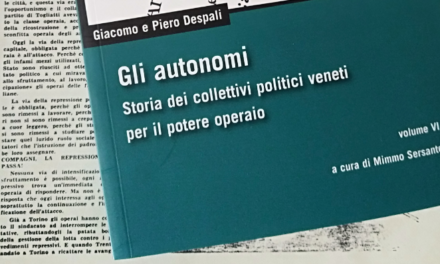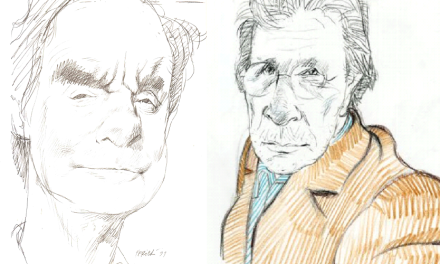Di SANDRO MEZZADRA
Una lettura, sotto la lente dell’attualità, del libro di Giovanni Arrighi Adam Smith a Pechino, Mimesis, 2021, con introduzione di Salvo Torre e postfazione di Andrea Fumagalli. Si tratta di una nuova edizione del testo dopo la prima pubblicazione, da tempo esaurita, uscita per Feltrinelli nel 2008 (edizione originale inglese 2007)
*****
Adam Smith a Pechino, di Giovanni Arrighi (2007), è un libro ormai classico. La scomparsa del suo autore solo due anni dopo la pubblicazione mette ancora più in risalto la creatività e l’apertura delle analisi presentate in questo volume, che si muovevano certo all’interno della cornice della “teoria del sistema mondo”e del lavoro dello stesso Arrighi nei decenni precedenti, ma con elementi di significativa innovazione. È dunque meritoria l’iniziativa della casa editrice Mimesis, che propone una nuova edizione del libro, arricchita di una prefazione di Salvo Torre e di una postfazione di Andrea Fumagalli. Rileggere Adam Smith a Pechino nel tempo della pandemia, e mentre tensioni crescenti segnano i mutamenti dell’ordine e del disordine mondiale, getta nuova luce su alcune delle tesi di fondo di Arrighi. Ne proporrò naturalmente una lettura selettiva, isolando alcune questioni che mi sembrano particolarmente importanti.
Adam Smith appare qui un pensatore lontano dall’immagine abituale di apologeta di un capitalismo in pieno sviluppo. Certamente teorico di una società di mercato, Smith considera tuttavia “lo sviluppo economico come processo inserito (embedded) in uno specifico ambito geografico, sociale e istituzionale e che in tale ambito trova anche i propri limiti”. Il capitalismo, definito da Arrighi a partire dallo stretto nesso tra capitale e Stato (tra accumulazione illimitata di capitale e accumulazione illimitata di potere) assume nella prospettiva di Smith caratteri profondamente “innaturali”. E si dispiega storicamente attraverso un “ciclo delle egemonie” che, nel passaggio di testimone dalla Repubblica di Genova ai Paesi Bassi, dall’Inghilterra agli USA, ne articola e garantisce l’estensione globale. Marx e Braudel, Schumpeter e Wallerstein sono i principali riferimenti teorici di Arrighi, che propone qui in forma sintetica i lineamenti di un’analisi sviluppata altrove in modo più ampio (in particolare in Il lungo ventesimo secolo, del 1994).
Quel che c’è di nuovo in Adam Smith a Pechino è l’enfasi posta sulla rilevanza, nel cruciale passaggio tra Sette e Ottocento, del confronto dell’Occidente con l’Oriente, con l’India e soprattutto con la Cina. In quella congiuntura, secondo una tesi ripresa da storici come Kaoru Sugihara e Kenneth Pommeranz, si sarebbe delineata appunto in Oriente la possibilità di una “rivoluzione industriosa” diversa dalla “rivoluzione industriale”: un percorso di sviluppo che, pur su basi di mercato, “non presenta alcuna tendenza intrinseca a imboccare la via ad alta intensità di capitale e di consumi energetici aperta dall’Inghilterra e pienamente sviluppata dagli Stati Uniti”. Siamo qui di fronte a un modello che pare ad Arrighi prossimo alla lezione smithiana: e la “grande divergenza” che sembra annunciarsi viene risolta attraverso il colonialismo, l’imperialismo e le armi, in particolare con le guerre dell’oppio che diedero avvio a quello che i cinesi ancora oggi chiamano il “secolo dell’umiliazione”.
Non si tratta di una tesi di rilevo esclusivamente storico. Se fin dalle prime battute del libro Arrighi sostiene che tema fondamentale della storia della seconda metà del Novecento è la “rinascita economica dell’Oriente asiatico”, proprio la Cina occupa il centro dell’analisi nel momento in cui a venire in primo piano sono le “genealogie del ventunesimo secolo”. E la Cina contemporanea presenta per l’autore molti tratti che si collocano in una linea di continuità con la “rivoluzione industriosa” e con la sua matrice “smithiana”. Tornerò tra un attimo su questo punto, che risulta ancora oggi tra i più originali e interessanti dell’intero libro. Prima però occorre richiamare l’attenzione sul modo in cui viene qui svolta la tesi della crisi dell’egemonia statunitense a livello globale, una tesi che Arrighi – occorre riconoscerlo – presentò insieme ad altri esponenti della teoria del sistema mondo all’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, quando la storia sembrava ai più andare in senso opposto. In Adam Smith a Pechino, nel contesto di un confronto con alcuni dei più importanti teorici marxisti degli scorsi decenni (particolarmente intenso è quello con Robert Brenner), vi sono almeno due elementi che meritano di essere sottolineati: da una parte l’enfasi sul ruolo delle lotte operaie (e non solo della concorrenza inter-capitalistica) e dall’altra sull’importanza degli sviluppi politici, economici e sociali nel “Sud” del mondo nel determinare la crisi dell’egemonia statunitense nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale. Lotte operaie da una parte, lotte anticoloniali e antiimperialiste dall’altra all’origine del nostro presente, si potrebbe dire, per marcare una vicinanza con Impero di Michael Hardt e Toni Negri (a cui Arrighi non manca tuttavia di rivolgere critiche).
L’analisi delle dinamiche monetarie e finanziarie in cui si manifesta la crisi dell’egemonia statunitense, condotta magistralmente da Arrighi, si collega d’altro canto a un’insistenza sulle trasformazioni del lavoro negli Stati Uniti e in Occidente che lo conduce a individuare in Wal-Mart il “paradigma vincente di organizzazione aziendale”. È facile immaginare che oggi, accanto a Wal-Mart, figurerebbe nelle pagine di Arrighi Amazon: ed è il caso di aggiungere, tuttavia, che il modello di business e di organizzazione del lavoro esemplificato da Amazon non sembra riguardare soltanto il mondo occidentale. La diffusione globale delle piattaforme digitali non avviene certo secondo le modalità di omologazione del mondo che Arrighi critica efficacemente a proposito dei dibattiti sulla globalizzazione degli anni Novanta (lo ricordano sia Torre sia Fumagalli nei loro interventi). Ma le profonde differenze che caratterizzano le operazioni delle piattaforme in diverse parti del mondo, compresa naturalmente la Cina, articolano in ogni caso un elemento di omogeneità di cui occorre tenere analiticamente conto. Questa dialettica di eterogeneità e omogeneità sembra anzi definire il sistema economico mondiale anche nella prospettiva di Arrighi, che insiste sulla compresenza di diverse forme di capitalismo, di dinamiche di mercato che le attraversano e, quantomeno come possibilità, di economie di mercato non capitalistiche. È forse anche per questa ragione che Adam Smith a Pechino appare cauto rispetto all’ipotesi di una lineare transizione egemonica dagli Stati Uniti alla Cina e sembra dare credito all’ipotesi dell’emergere di quello che oggi viene spesso definito un multipolarismo conflittuale o centrifugo, certo fondato su una posizione di forza della Cina. Anche l’accenno finale alla possibilità di una “nuova Bandung”, su “basi essenzialmente economiche”, ovvero di nuove alleanze all’interno del “Sud globale”, mi pare vada in questo senso.
In ogni caso, il modo in cui Arrighi parla della Cina in questo libro ne costituisce senz’altro uno degli aspetti più originali – ed è stato anche quello più controverso al momento della sua pubblicazione. Vediamone intanto il principale motivo d’interesse, che rimane oggi a mio giudizio essenziale. Per comprendere l’ascesa cinese, scrive Arrighi, “bisogna prima di tutto spazzare il terreno dal mito che possa essere attribuita a una presunta conversione al credo neoliberale”. Con queste parole Arrighi si riferiva a un “mito” molto diffuso in particolare a sinistra, tra l’altro veicolato dai lavori di Naomi Klein e David Harvey (che ad Arrighi era molto vicino anche umanamente). Se oggi appare evidente come la Cina si muova lungo linee distanti dal neoliberalismo, le geometrie territoriali dello sviluppo fin dalle riforme di Deng (con la proliferazione di “zone” e con i persistenti squilibri tra città e campagna) nonché il ruolo dello Stato e del partito a fronte dei capitali provenienti dall’estero definivano un modello decisamente peculiare. Certo, l’ingiunzione “arricchitevi!” rivolta ai cinesi da Deng è risuonata potentemente e a lungo nel Paese, strati capitalistici si sono formati con un aumento clamoroso della polarizzazione sociale e gli interessi legati alla ricchezza sono ampiamente penetrati nelle strutture del partito e dello Stato trasformandole in profondità (un tema al centro degli scritti di Wang Hui e più in generale delle analisi della cosiddetta “nuova sinistra” cinese fin dall’inizio del nuovo secolo). Ma solo un uso del concetto puramente evocativo e in ultima istanza vuoto poteva consentire di definire la Cina neoliberale. E d’altro canto Arrighi, lo notava con la consueta acutezza Benedetto Vecchi introducendo una sua bella intervista (“il Manifesto”, 24 gennaio 2008), ridimensiona più in generale la valenza del “neoliberalismo”, considerandolo “una parentesi” assai più che “un modello”. Mi pare un punto su cui riflettere oggi.
Arrighi interpreta l’intero percorso storico avviato dalle riforme di Deng secondo le linee generali della sua interpretazione di Adam Smith che si sono sinteticamente viste in precedenza. Centrale, nel suo discorso, è l’insistenza da una parte sulla selettività dei processi di deregolamentazione e privatizzazione in Cina, dall’altra sulla combinazione di una industrializzazione orientata all’esportazione con la promozione del consumo interno, sostenuto da imprese eterogenee, tra cui figurano anche quelle cooperative e “di proprietà delle comunità”. Il quadro tracciato da Arrighi può certo risultare spiazzante, nella misura in cui questa immagine di un’economia mista in cui l’accumulazione di capitale incontra precisi limiti nell’azione di uno Stato che mantiene un’autonomia dagli interessi economici e dalla ricchezza non rende conto a sufficienza della durezza e dei costi sociali dello sviluppo cinese (che sarebbe un esempio di “accumulazione senza spoliazione”), dei violenti processi di sfruttamento che dalle zone economiche speciali (e dunque dalle imprese legate al capitale straniero) si sono ben presto estesi alla stessa sfera “interna”. E tuttavia il carattere anomalo del sistema cinese rispetto alla modellistica e alle tassonomie occidentali emerge in modo convincente dalle sue pagine. A me pare che il punto non stia tanto nel convenire o meno sul carattere “non capitalistico” di questo sistema: la presenza di attori e dinamiche capitalistiche è innegabile in Cina, si tratta piuttosto di guardare al complesso sistema politico, sociale e culturale in cui quelle dinamiche e quegli attori operano per individuare contraddizioni e potenzialità. Da questo punto di vista, Adam Smith a Pechino è stato un testo di rottura che ha aperto spazi analitici e teorici ancora oggi fondamentali.
Non si può evitare di concludere sottolineando che il mondo – tra la crisi finanziaria del 2007-2008 e la pandemia – è cambiato radicalmente nei quindici anni che ci separano dalla pubblicazione del libro a cui queste pagine sono dedicate. Ed è cambiata in profondità la Cina, confermando la validità di alcune intuizioni di Arrighi ma al tempo stesso complicando il quadro. La proliferazione di lotte e movimenti nelle aree urbane e rurali, e soprattutto le grandi lotte operaie sostenute dai migranti interni sono aspetti su cui si sofferma l’attenzione di Arrighi, che arriva a preconizzare la nascita di un “nuovo movimento operaio”. La continuità di queste lotte, che hanno avuto un momento di formidabile accelerazione nel 2010 con lo sciopero allo stabilimento Honda di Foshan, è stato un fattore importante nell’insieme di processi che hanno portato alla fine di un’epoca dello sviluppo economico nel Paese, quello in cui la Cina è stata la “fabbrica del mondo”. La corsa alla conquista del primato tecnologico mondiale, che ha caratterizzato gli ultimi anni, ha determinato profonde trasformazioni nelle metropoli cinesi, nell’organizzazione e nell’esperienza soggettiva del lavoro. Il partito comunista, al tempo stesso, ha assunto ruoli in qualche modo nuovi, riaffermando il controllo statale dell’economia e ponendo il problema che con Arrighi possiamo definire dei limiti all’accumulazione di capitale (in particolare a fronte di colossi dell’economia digitale come Alibaba, Tencent e Baidu). Quel che sembra profilarsi, tuttavia, è un accentuato controllo non solo sull’economia ma anche sulla società, per di più alla luce di una nozione confuciana di “armonia” che sembra chiudere lo spazio per ogni conflitto (anche indipendentemente da quello che accade in una regione come lo Xinjang, in Tibet e più in generale attorno alla questione dei “diritti umani”). È il caso di ripetere, a questo proposito, che senza lotta di classe non c’è progresso – e dunque neppure sviluppo.
Si tratta di un ragionamento appena abbozzato, che dovrebbe essere articolato con ben altra ampiezza e profondità. Così come si dovrebbe dedicare molto spazio all’altra grande novità intervenuta negli anni che ci separano dall’uscita del libro di Arrighi: ovvero il gigantesco progetto logistico “One Belt One Road”, la nuova via della seta che costituisce lo specifico progetto cinese di globalizzazione – e non è certo un caso che Xi Jinping sia rimasto l’unico leader mondiale a celebrare a Davos il carattere irreversibile della globalizzazione. Mentre non mancano in Asia intellettuali che pongono quel progetto in una linea di continuità con lo “spirito di Bandung”, sono note le critiche (spesso ma non sempre strumentali) all’espansionismo economico cinese e in particolare alla “trappola del debito” che lo accompagnerebbe per molti Paesi. Non è qui possibile affrontare direttamente questi temi. Quel che è comunque certo è che il modo in cui verrà gestita nei prossimi anni dal partito comunista cinese l’articolazione (certo non lineare) tra la costruzione di un nuovo modello interno e la proiezione globale della potenza economica cinese sarà decisivo non soltanto per l’avvenire della Cina. Sono in fondo i due versanti su cui si è esercitata l’analisi di Arrighi in Adam Smith a Pechino. Su entrambi incombono potenti contraddizioni, e le forme che assumeranno le lotte di classe stabiliranno la direzione dello sviluppo.
Questo articolo è stato pubblicato contemporaneamente su Effimera.