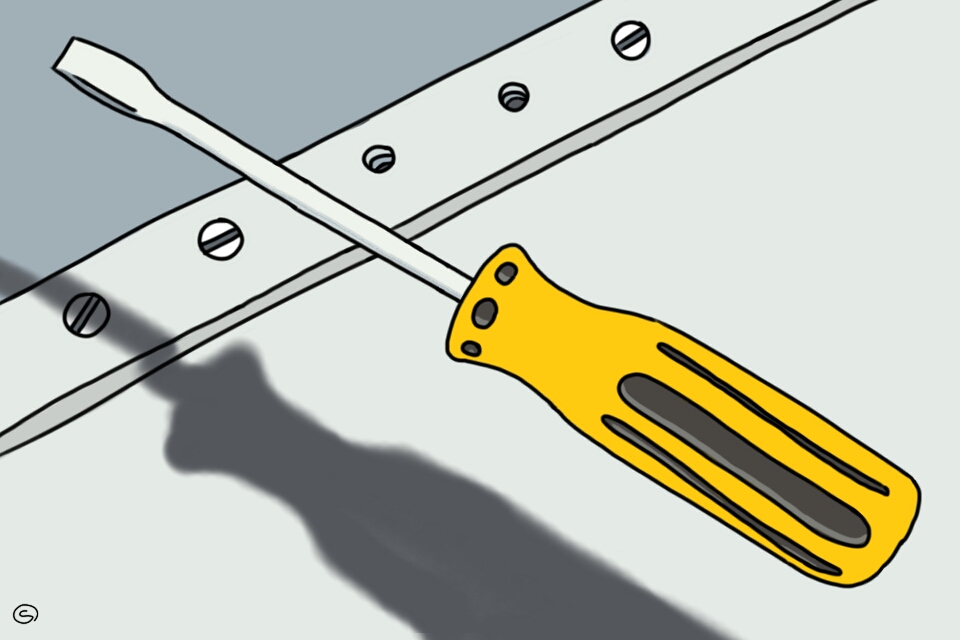di GIROLAMO DE MICHELE.
Circa quattro anni fa, il non-ancora-greco-levantino Yanis Varoufakis scrisse un testo (Never bailed out: Europe’s ants and grasshoppers revisited, dicembre 2011, qui) nel quale la narrazione delle cause della crisi greca si intrecciava con la sovversione della narrazione dominante, incentrata sulla contrapposizione fra le virtuose formiche (tedesche) del nord e le scellerate cicale (greche) del sud d’Europa. Questa narrazione fungeva da schermo nei confronti della reale contrapposizione fra cicale e formiche, che non è originata nelle identità nazionali o localizzata nell’asse cardinale nord-sud, ma radicata negli antagonismi di classe: le formiche greche lavoravano in settori a bassa produttività con bassi salari e tutele lavorative e un’inflazione reale superiore a quella ufficiale; quelle tedesche lavoravano in settori a grande produttività, e la differenza fra alti profitti e salari stagnanti creava un surplus che veniva investito, a causa dei bassi tassi d’interesse esistenti in Germania, all’estero; per contro, le cavallette tedesche (quegli inimitabili banchieri il cui scopo è massimizzare i guadagni col minimo sforzo) facevano fluire il capitale prodotto dal duro lavoro a basso costo delle formiche verso il meridione in cerca di alti guadagni, mentre le cavallette greche, e i loro alleati politici al governo, chiedevano alle cavallette tedesche (le banche) sempre maggiori prestiti, senza pensare al domani. Per contro, le formiche greche dovevano farsi carico dei costi di questa macchina finanziaria che non portava alcun reale beneficio al popolo greco.
Con lo spread non è tempo di eroi
 Di Varoufakis, all’epoca, poco si sapeva, se non che insegnava economia da una cattedra ateniese: i nomi di grido erano Monti, Giavazzi, Alesina e Ardagna. Sarebbe certo stato preferibile che editorialisti e grandi firme mainstream della stampa e della televisione – a partire dall’ineffabile coppia di anime belle Fazio-Gramellini – avessero dedicato lo stesso sguardo lubrico che in seguito riservarono al ministro greco, al suo abbigliamento, alla cilindrata della sua moto, al suo stile di vita, ai fondamenti matematici (già scricchiolanti, peraltro) dei papers dei guru dell’austerità – la ormai celebre “Excell Depression“, per dirla con Krugman: ma che te lo dico a fare?
Di Varoufakis, all’epoca, poco si sapeva, se non che insegnava economia da una cattedra ateniese: i nomi di grido erano Monti, Giavazzi, Alesina e Ardagna. Sarebbe certo stato preferibile che editorialisti e grandi firme mainstream della stampa e della televisione – a partire dall’ineffabile coppia di anime belle Fazio-Gramellini – avessero dedicato lo stesso sguardo lubrico che in seguito riservarono al ministro greco, al suo abbigliamento, alla cilindrata della sua moto, al suo stile di vita, ai fondamenti matematici (già scricchiolanti, peraltro) dei papers dei guru dell’austerità – la ormai celebre “Excell Depression“, per dirla con Krugman: ma che te lo dico a fare?
Tra i pochi a cogliere in profondità il senso del testo di Varoufakis ci fu, all’interno di un testo tutt’ora fondamentale sulle narrazioni al tempo della crisi, Lanfranco Caminiti (Di cosa scriviamo quando scriviamo di crisi, qui),1 che poneva, fra i molti (e tutti giusti) problemi, questo:
Lo spread non comunica nulla, se non un dato che sembra oggettivo e bizzarro come il tempo: accanto alle informazioni meteo, le televisioni e i quotidiani vanno introducendo le informazioni spread. Lo spread non appartiene alla nostra esperienza umana quotidiana, a meno di non essere uno che tutti i giorni interviene sul mercato secondario dei titoli. La continua reiterazione dei movimenti dello spread ha finito per uccidere qualsiasi narrazione possibile. Forse è proprio questo il punto: l’informazione ossessiva espropria la narrazione. Siamo inzeppati di analisi, grafici, ragionamenti, statistiche e sequenze, ma piuttosto che facilitarci nel comunicare qualcosa, una qualsiasi esperienza, questa mole di dati diventa disumana, un paesaggio di macerie, una voragine. Non ci sono eroi nello spread, non ci sono codardi, non ci sono passioni, amori, tradimenti. Lo spread non potrà mai essere un personaggio. E senza personaggi non ci sono storie.
Con quel testo, Varoufakis si inseriva – non importa con quanta consapevolezza – nella questione sul buon uso delle narrazioni e dello storytelling squadernata da un testo, tanto apocalittico quanto integrato, di C. Salmon2, improvvidamente (ma anche no) assunta (e rilanciata di recente) da taluni invisibili bucolici adusi a coltivare cucurbitacee e sogni destituenti, per i quali lo storytelling non è altro che una tecnica di reality-building finalizzata a far passare in secondo piani i crudi fatti, sopravanzati dalla fiction e dalle narrazioni (Gouverner par le chaos, 2010, nouvelle éd. 2014, p. 66). Questo cassandrume (tanto di Salmon quanto del phylum Tiqqun-Comité Invisibile), a suo tempo spazzolato a contropelo dai testi di Yves Citton (Mitocrazia, ed. it. 2013) e, in Italia, di Wu Ming e Enrico Manera – non a caso, frequentatori degli scritti sul mito di Furio Jesi – si distende su una davvero povera comprensione tanto del reale, quanto dei suoi rapporti con le parole che lo designano, gli enunciati e i discorsi che operano nel momento stesso in cui dicono il reale in modo diverso dallo svolgersi dell’enunciazione. Il discorso, la narrazione, le storie sono meno ciò che emerge, e più la parte sommersa dell’iceberg. L’emblematica fascinazione – anche per gli invisibili comitanti – per le seriali Apocalissi Zombie intrattiene un serrato rapporto con l’elementarietà della decifrazione del significante-zombie, persino nelle versioni che si vorrebbero più sofisticate senza fuoriuscire dal circuito della tendenza: ciò di cui abbiamo bisogno non è di meno storie meno complesse, ma di più storie, a molteplici strati narrativi, discorsivi ed interpretativi. Non di opere a grado zero, ma di interpretazioni proliferanti, nomadi e deterritorializzanti.
Ma non c’è molto da confutare – soprattutto a fronte della sostituzione del discorso dimostrativo con i toni oracolari buoni, come si vede oggi, per le bacheche fb e le richieste di “amicizia”: c’è solo da mettere in evidenza lo iato che si apre fra chi ritiene che il reale sia interamente iscritto e solo da decifrare o dipanare («démêler l’échevau du présent»), e chi crede che non smetta mai di iscriversi, perché sempre compreso nello scarto prodotto dalla continua produzione del reale.
Sovvertire la narrazione dominante
Tornando al testo di Varoufakis: il modo in cui veniva sovvertita la narrazione della favola di Esopo era rilevante per due ragioni. La prima: il ricorso al patrimonio culturale greco come riserva universale di significanti (non di significati già codificati) – di cui si parlerà qui. La seconda: Varoufakis sfuggiva al facile ribaltamento della narrazione dominante, consentito dall’istintivo quanto scontato riferimento al passato nazista della Germania. Questo ribaltamento, facile da comprendere in un’epoca di passioni tristissime, e di altrettanto tristissimi viandanti, è non per questo accettabile: perché ripropone la lettura dello scontro di civiltà, o di popoli o nazioni, che è sempre e comunque fascista – magari inconscia: ma per dirla con Bogey, è il tuo inconscio ad essere triste, baby, and you can’t do nothing. Oltretutto, identificare nel “tedesco” il nemico deforma il reale svolgimento dei fatti, fa passare in ombra il ruolo svolto con i suoi provvedimenti da Draghi (paragonato da Guido Viale a quello che tiene ferma la vittima mentre gli altri la picchiano) e sposta il fuoco dell’attenzione dalle istituzioni finanziarie sovranazionali a “popoli” e “nazioni”.
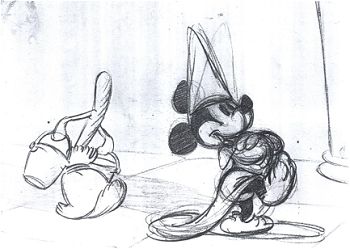 Non c’è da chiedersi come rovesciare o riterritorializzare o curvare la tutt’altro che misteriosa – ma rancorosa sì! – retta di questo discorso accolto in nome di un’attrazione per lo spurio e il populismo a prescindere: c’è solo da evitare di giocare all’apprendista stregone con parole e immagini avventate, prima che le creature sfuggano di mano e comincino a vivere di vita propria. E, constatando che di apprendisti stregoni, vecchi e nuovi, occulti e sdoganati, ce n’è fin troppi, di approntare efficaci contronarrazioni avverse alle vecchie e nuove forme di cui si ammanta il fascismo. In un’epoca nella quale ritorna di moda leggere Benjamin come autore di aforismi buoni per incartare i Baci Perugina e le spezie nella bottega bio del villaggio neo-gallico, sarà consentito ricordare che per Benjamin tanto il fascismo quanto la sua sconfitta non erano un’eventualità fra le tante, ma il nemico da battere e il compito di una lotta per la quale andavano cercate nuove armi.
Non c’è da chiedersi come rovesciare o riterritorializzare o curvare la tutt’altro che misteriosa – ma rancorosa sì! – retta di questo discorso accolto in nome di un’attrazione per lo spurio e il populismo a prescindere: c’è solo da evitare di giocare all’apprendista stregone con parole e immagini avventate, prima che le creature sfuggano di mano e comincino a vivere di vita propria. E, constatando che di apprendisti stregoni, vecchi e nuovi, occulti e sdoganati, ce n’è fin troppi, di approntare efficaci contronarrazioni avverse alle vecchie e nuove forme di cui si ammanta il fascismo. In un’epoca nella quale ritorna di moda leggere Benjamin come autore di aforismi buoni per incartare i Baci Perugina e le spezie nella bottega bio del villaggio neo-gallico, sarà consentito ricordare che per Benjamin tanto il fascismo quanto la sua sconfitta non erano un’eventualità fra le tante, ma il nemico da battere e il compito di una lotta per la quale andavano cercate nuove armi.
Si tratta dunque di comprendere che il fascismo che viene è in relazione anche al paradigma dominante della crisi come rapporto fra un nord virtuoso e un sud scellerato. Era sin dal 2011 all’opera la costruzione del greco come levantino pigro, scialacquatore, parassita, mentitore, sprecone. Con un tono più elevato, Claudio Magris (Grecia, nessun grande passato può essere un alibi, “Corriere della sera”, 9 luglio, qui) nomina la hybris come esito di una sequenza notevole sotto l’aspetto semantico: «Agire irrazionalmente, rabbiosamente, caparbiamente, tignosamente, rumorosamente, truffaldinamente». La reiterazione degli avverbi in –mente, ignorante del severo monito del Maestro – l’avverbio non è tuo amico – produce un effetto da non sottostimare: perché Cetto La Qualunque è il lampione scambiato per la luna cui qui indica il dito dell’idiota, sulla cui unghia sporca torneremo.
Qual è lo scopo della macchina che costruisce il greco come levantino? Al tempo stesso, obnubilare le vere cause della sua condizione di crisi – e le possibili narrazioni alternative – attraverso la figura di un capro espiatorio; ed elidere il rapporto fra il greco e il suo patrimonio culturale, del quale il levantino scroccone è in tutta evidenza indegno. Una volta piegata la narrazione della crisi sul soggetto, la narrazione si dispiega sul suo bordo esterno, in un secondo processo di soggettivazione che a fronte del levantino, allude all’esistenza di altri popoli virtuosi. Infine, la narrazione dei soggetti virtuosi si ripiega in direzione di altri soggetti che ne costituiscono il “fuori” (apparente): lo zingaro, il profugo, l’islamico. L’infame levantino si aggiunge al caleidoscopio di figure infami sulle quali si costruisce un’emergenza permanente, con scansione quasi cronometrica. A questo processo di soggettivazione e assoggettamento alle logiche securitarie della paura, del panico, dell’emergenza partecipano, a pari titolo, tanto coloro che le assecondano reiterando il frame del greco levantino (e/o dei suoi governanti), quanto coloro che, credendo di rovesciare il frame in una sorta di Ur-nazismo tedesco (del “popolo” e/o dei suoi governanti), non fanno che rafforzarlo per negazione.
Una pita ghiros con Sofocle
Ci sono, credo, due modi complementari di intendere il rapporto fra la Grecia attuale e il suo patrimonio culturale classico che accompagnano e favoriscono la crescita delle Albe nazifasciste.
Il primo è negarne l’importanza. Un recente ministro diceva – dando voce a ciò che molti non avevano il pudore di enunciare, ma nondimeno pensavano – che la cultura è qualcosa che non si mangia: non è che adesso vado al bar e mi faccio un panino con due fette di Dante, più o meno. O, variante – dello stesso nelle parole, degli stessi nei pensieri –, non è che possiamo prenderci la Grecia in Europa solo perché loro hanno Platone. Non si tratta di argomentare che col sapere si può anche mangiare, magari meglio: si tratta di capire a cosa fanno segno parole come cultura, sapere, intellettuale, poesia, filosofia, ecc. Dire che con Dante o Sofocle non si mangia, significa abdicare all’idea che non c’è altra Europa possibile che quella reale, nella quale – è innegabile – né Platone né Dante, né Orazio, Seneca, Sofocle, i Pink Floyd, Shakespeare, Beethoven, i Beatles, Camus, Brecht e Beckett hanno cittadinanza attiva. Il che impoverisce le alternative politiche all’opzione secca fra questa Europa delle banche, e nessuna Europa: come dire che non ci sono mondi possibili, perché ce ne sono solo di reali.
Ma l’elisione del sapere dalla costituzione materiale dell’Europa consente invece l’assunzione dei suoi contenuti, all’interno di quello sguardo post-coloniale (o meridiano) che non ribatte il frame dominante con la negazione della negazione, ma col suo sovvertimento a partire dall’autovalorizzazione di ciò che è eliso come irrilevante e minoritario: con l’affermazione dello sguardo del subalterno contro la visione coloniale, attraverso pratiche che concretizzino concezioni del mondo possibili e alternative.
 È tipico del fascismo (lo sa chiunque abbia comparato gli operai di Sironi con quelli di Guttuso, per dire) affermare che esiste un unico mondo, con il quale fare i conti in una lotta che lascerà in terra vittime e sconfitti che meritavano di esserlo. In effetti un’altra Europa non esiste, così come non esistono l’amore, la giustizia e la felicità. È per questo che si deve lottare: per farle esistere.
È tipico del fascismo (lo sa chiunque abbia comparato gli operai di Sironi con quelli di Guttuso, per dire) affermare che esiste un unico mondo, con il quale fare i conti in una lotta che lascerà in terra vittime e sconfitti che meritavano di esserlo. In effetti un’altra Europa non esiste, così come non esistono l’amore, la giustizia e la felicità. È per questo che si deve lottare: per farle esistere.
Il secondo modo, è quello di assolutizzare la cultura greca e i suoi contenuti, come fa Magris parlando di “DNA culturale” di cui sarebbe portatore il popolo greco, e giungere a prefigurare le vette della cultura come una sorta di fiaccola che passa di mano in mano – come «l’Impero Romano, la più alta creazione politica della storia» [sic], il cui degno erede sarebbe stata, negli anni Trenta, l’Inghilterra. Ad aver tempo da perdere, bisognerebbe spiegare all’illustre esperto di depressioni danubiane, oltre a un paio di cosette sull’Impero Romano (per la figura del suo fondatore, Ottaviano, può chiedere lumi a Luciano Canfora) e a come il suo erede, l’Impero Britannico, trattò i colonizzati. Resta che se esistono “DNA culturali”, e popoli o nazioni che ne sono portatori, esisteranno sempre popoli, nazioni, e infine uomini della provvidenza che si elevano al di sopra degli altri.
Può darsi che Magris, avendo dedicato un’intera vita ridurre la mitteleuropa a una depressione caspica nella quale vagano stordite le tristezze di vecchie comari della Bassa Sassonia e le miserie di piccole comunità di ebrei rumeni3, non abbia avuto tempo di leggere Detienne, Vernant, Vidal-Naquet, Foucault, ecc., che hanno dimostrato come nella Grecia classica non si siano mostrati lampi luminosi di universali eterni, ma si siano prodotti eventi culturali intrecciati a doppia elica con processi socio-economici (riforme agrarie, crisi economiche, ascese di classi sociali, nascita del diritto scritto: cose così). Come che sia, i greci hanno detto e scritto tante cose, spesso contraddittorie fra loro: il più alto elogio della democrazia convive nelle stesse pagine di Tucidide in cui sono enunciate le implacabili ragioni, legittimate da ferree leggi storiche, dell’imperialismo ateniese; così come la giusta rivolta morale contro le disumane norme regie di Antigone coesiste col legittimo esercizio della ragion di Stato di Creonte (e ci sarebbe poi anche Ismene, a voler mettere giù il carico da undici). Volendo dar retta alle favole freudiane, i greci ci hanno lasciato in eredità persino il complesso di Edipo, secondo taluni nostalgici lacaniani cardine del processo di formazione della personalità che oggi (l’Edipo) sarebbe minacciato dal turbocapitalismo consumistico, con le conseguenti svirilizzazione del maschio, confusione dei generi, sopravvalutazione del femminile, perdita delle gerarchie generazionali4.
Citare l’origine della democrazia o la resistenza al potere, o la superiorità delle leggi dell’ospitalità su quelle della città dell’Edipo a Colono, piuttosto che il significante dispotico di Edipo o l’ottusità di Creonte; così come leggere Esopo alla lettera oppure no; prendere per oro colato le improbampossibili etimologie di Heidegger e Agamben oppure no; assoggettarsi al principio d’autorità, o liberarsene; deprecare o accettare l’esortazione di Diogene il Cinico a falsificare la moneta – sono tutti gesti con i quali, attraverso una selezione critica, si scelgono propri antenati così come ci si schiera in un campo di battaglia. «Non c’è nessun testo, chiosa Magris, che possa far comprendere, ieri oggi e domani, cosa sia l’uomo come il secondo coro dell’Antigone di Sofocle»: ma a questa banalità, segue la constatazione che tra i molti significati dell’enunciato pollà ta deinà, uno è quello che attribuisce all’essere umano la capacità di erigere scudi contro le malattie incurabili. Che è quanto pretendono di fare gli attuali greci contro l’attuale arroganza delle banche ammantata da ineluttabilità: il solo fatto di opporsi all’uso fascistico-museale della cultura colloca queste pratiche, e chi le enuncia non in nome di un diritto ereditario o genetico, ma come scelta del terreno, nel campo dell’antifascismo. E viceversa.
Pollà tà idiotà
Nondimeno, c’è un’ultima lezione da trarre dalla prassi degli intellettuali laureati di aprir bocca non per affermare la verità, ma per profetizzare su cose di cui non si sa un’acca: la reiterazione dell’effetto-Miciacio. Agostino Miciacio è l’indimenticabile calzolaio di San Giovanni decollato impersonato da Totò, soprannominato “il professore” per la sua abilità nel mestiere; sicché accade che, in quanto professore, sia reputato competente in qualunque campo, persino – che professore! – nell’arte della calzoleria. Su questo effetto, Maurizio Costanzo ha costruito la propria fortuna, esibendo nel suo Show esperti in un campo – la letteratura mitteleuropea, poniamo – e facendoli chiacchierare in libertà su cose – la crisi greca, poniamo – delle quali ne sanno tanto quanto ne sa lo spettatore medio: spettatore che, sentendo l’esimio proferire stronzate, gonfia il petto e allarga le piume, fiero di sentir dire da un professore le stesse cose che pensa lui spettatore. Il mondo è pieno di idioti incapaci di oltrepassare la circonferenza del proprio ombellico: Pollà tà idiotà – cioè come possono gli intellettuali dare una mano per mantnere sempre gli stessi rapporti sociali.
Il che ci riporta al punto di partenza: alla necessità di sfuggire alla doppia presa della devozione al culto del qualitativo e del numerico, e dell’assenza di esercizio critico della lingua, che com’è noto batte se la mente vuole, di cui si nutre il fascismo del terzo millennio. E di migliorare la nostra posizione nella lotta contro di esso attraverso il ricorso critico, selettivo e narrativo al patrimonio culturale e alla produzione di realtà attraverso lo svolgimento e la sovversione dell’ordine del discorso dominante.
Nel 2012 me ne ero occupato in un testo intitolato Dalla parte di Penelope. La Grecia, le favole, la parresia e il dovere di narrare la verità, qui. ↩
Christian Salmon, Storytelling, ed. it. Fazi, 2008, sulla quale vedi la recensione di Wu Ming 2: «Buone intenzioni, premesse confuse, libro raffazzonato. Che il potere racconti storie è un’ovvietà, che noi si debba smettere di farlo è una scemenza». ↩
Rubo con piacere questa battuta ad Antonio Negri, La differenza italiana, Nottetempo 2005. ↩
Il riferimento non è solo a Recalcati o a qualche prelato cattolico, ma anche al già citato Gouverner par le Chaos, p. 81, che riprende il precedente Tiqqun, Premiers matériaux pour une théorie de la Jeune-Fille, 2001: vedi mai partendo da Lacan dove si rischia di andare a parare… ↩