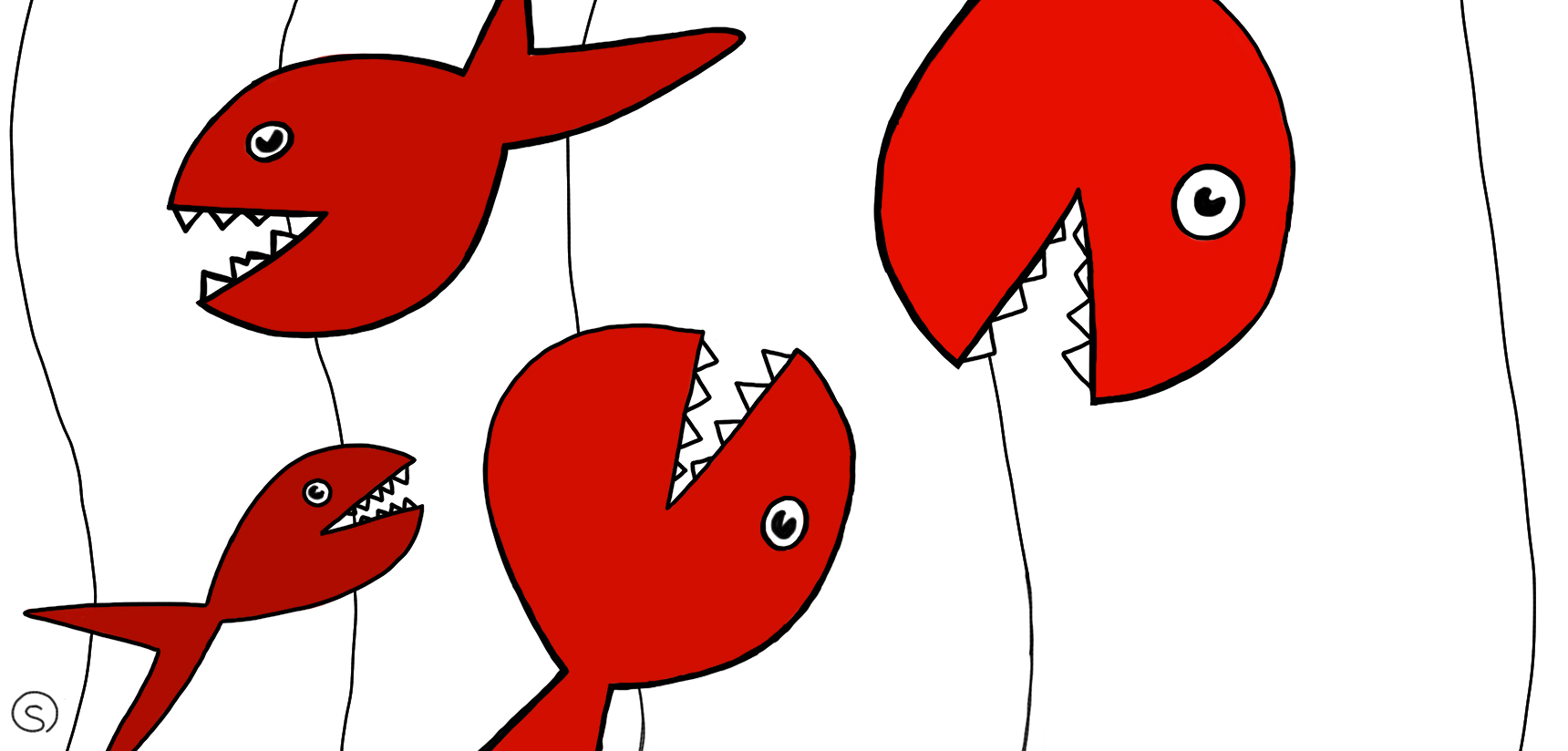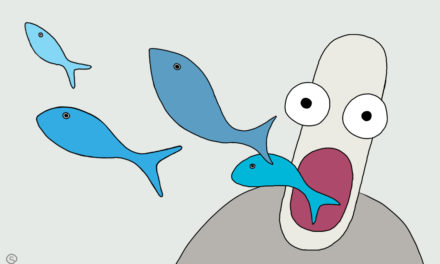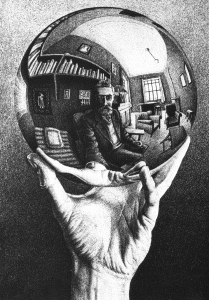di MARCO BASCETTA.
Gli anni della grande crisi hanno recato in Italia evidenti novità politiche. Imponendo scenari inediti, ma anche portando a compimento processi e tendenze in corso ormai da molti anni. Tra questi due corni, tra continuità e rotture, si svolge la narrazione della più recente storia politica italiana che Marco Revelli condensa in un breve saggio (Dentro e contro, Laterza, pp. 140, € 14) con l’intento di ricostruire i passaggi e le condizioni che hanno condotto all’attuale stile di governo, alle forme della politica su cui poggia, al suo programma di ridisegno degli assetti istituzionali e delle relazioni sociali. Programma che ruota attorno all’opportunità di cavalcare l’evidente crisi della democrazia rappresentativa indirizzandola verso l’instaurazione di un rapporto tra governanti e governati fondato sulla subordinazione consensuale dei secondi ai primi a tutto vantaggio dell’efficienza competitiva del «sistema-paese» sul mercato globale. È in questo quadro che si inscrive lo svuotamento dei corpi intermedi, partiti e sindacati, e delle assemblee elettive, in primo luogo il Parlamento, a favore di un costante rafforzamento dell’esecutivo. Il quale assume, tanto sul piano ideologico quanto su quello operativo la forma di un «populismo dall’alto», o «istituzionale», o «di governo» che si appella al rapporto diretto tra il premier e la «gente», rappresentata dalla platea sempre più risicata e imbrigliata degli elettori. Se scrivo «gente» non è per caso.
Il regno del «fare»
Si tratta infatti di un «populismo» assai singolare non facendo riferimento alcuno all’idea di «popolo» in quanto soggettività politica, sia pure astratta o immaginaria, e fonte della sovranità. Il che rende non poco problematico il ricorso estensivo a questa categoria politica nel descrivere un potere che si rivolge a quel regno borghese e operoso del «fare» e del mercanteggiare che siamo soliti chiamare, con indulgente simpatia, non «popolo» ma «società civile». È alle corporazioni che la compongono (con un occhio di riguardo per le più potenti), agli interessi e agli appetiti che la attraversano, alle pulsioni che la agitano, agli scambi che vi si svolgono, che la retorica governativa si rivolge, cercando di blandirne, di finanziaria in finanziaria, questo o quel segmento mascherato da «interesse generale». Di qui discendono quelle doti (e quella posizione sempre arrischiata e pericolante) di «funambolo» o di «illusionista» che Revelli riconosce a Matteo Renzi. Insomma un governo centralizzato e decisionista della frammentazione e della precarietà, attento a coglierne inclinazioni e potenzialità produttive, umori e paure, ma anche sempre esposto all’imprevisto.
Qualcosa di alquanto discosto, dunque, dall’afflato unificatore e omogeneizzante del populismo, del quale persiste semmai una robusta mano di vernice mediatica. Il «partito della nazione» e il suo condottiero emergono al termine di una vicenda almeno trentennale, «come la forma politica – scrive Revelli – con cui giunge a compimento la crisi terminale della democrazia rappresentativa. Non la produce, certo, quella crisi (perché essa è il risultato di un processo lungo di deterioramento, svuotamento e degrado). Ma la mette in sicurezza, per così dire. La certifica e la dichiara normale e definitiva». Resta da spiegare però cosa abbia determinato quel deterioramento, svuotamento e degrado perché questo, e non la loro certificazione finale, è l’elemento su cui poggia il successo del nuovo corso intrapreso dalla fu sinistra italiana.
Pretese di governabilità
Si tratta di quella serie ininterrotta di sconfitte del movimento operaio, radicata nella profonda metamorfosi del lavoro, della sua natura e della sua percezione, che ha travolto forme politiche
e organizzative, aspettative e strategie di vita. Sconfitta affrontata invano per un verso dai compromessi sempre più suicidi delle socialdemocrazie e per l’altro dalle illusioni resistenziali di una sinistra convinta di poter ripristinare condizioni ormai tramontate, di mantenere posture etiche private del loro fondamento culturale. Sono il materiale umano e i rapporti sociali prodotti da questa profonda trasformazione ciò a cui il renzismo mette mano per normalizzarli e ricondurli nell’alveo della competitività di mercato, sulla base di un liberismo padronale non particolarmente innovativo. Vi mette mano anche, per altri versi meno convenzionali, il movimento di Grillo che, a dispetto del suo ideologismo giacobino, riesce comunque a tastare il polso del disagio sociale e a veicolarne il risentimento e il riflesso d’ordine.
 La storia di questa normalizzazione viene, tuttavia, da molto lontano, fin dall’insorgere di quella pretesa di «governabilità» che avrebbe messo fine alla prima Repubblica, ma soprattutto ai conflitti sociali che la avevano attraversata rappresentando un fattore di sviluppo, di diffusione del benessere e di riduzione delle diseguaglianze. La magistratura, con tutto lo strumentario repressivo ed emergenziale messo a punto nel corso dei tardi anni Settanta, se ne sarebbe dovuta incaricare. Ma come i Talebani messi in campo nella guerra fredda contro l’«impero del male» i giudici schierati contro l’insubordinazione sociale sarebbero presto sfuggiti di mano ai loro stessi mandanti, finiti ingabbiati in quella opposizione tra legalità e illegalità che doveva sostituire il conflitto sociale e continua a pretendere di sostituirlo sotto le bandiere a 5 stelle. Probabilmente, però, malgrado l’epopea dello scontrino, anche la stagione del protagonismo giudiziario volge ormai al termine, vittima di quello stesso principio di «governabilità» che era stato chiamato a garantire. Laddove decisionismo, efficienza e competitività, si affiancano e sopravanzano la retorica legalitaria sia pure senza entrarvi, almeno per il momento, in rotta di collisione.
La storia di questa normalizzazione viene, tuttavia, da molto lontano, fin dall’insorgere di quella pretesa di «governabilità» che avrebbe messo fine alla prima Repubblica, ma soprattutto ai conflitti sociali che la avevano attraversata rappresentando un fattore di sviluppo, di diffusione del benessere e di riduzione delle diseguaglianze. La magistratura, con tutto lo strumentario repressivo ed emergenziale messo a punto nel corso dei tardi anni Settanta, se ne sarebbe dovuta incaricare. Ma come i Talebani messi in campo nella guerra fredda contro l’«impero del male» i giudici schierati contro l’insubordinazione sociale sarebbero presto sfuggiti di mano ai loro stessi mandanti, finiti ingabbiati in quella opposizione tra legalità e illegalità che doveva sostituire il conflitto sociale e continua a pretendere di sostituirlo sotto le bandiere a 5 stelle. Probabilmente, però, malgrado l’epopea dello scontrino, anche la stagione del protagonismo giudiziario volge ormai al termine, vittima di quello stesso principio di «governabilità» che era stato chiamato a garantire. Laddove decisionismo, efficienza e competitività, si affiancano e sopravanzano la retorica legalitaria sia pure senza entrarvi, almeno per il momento, in rotta di collisione.
La frenesia riformatrice del partito della nazione è tutta inscritta dentro questo equilibrio tra principio d’ordine e disinibizione esecutiva che si esprime, per esempio, nella soluzione prefettizia delle crisi politiche locali.
Si arriva così a quella manomissione della Carta costituzionale che si propone di conferire un quadro stabile e blindato al principio di «governabilità», e che Revelli descrive con chiarezza in tutti i suoi passaggi essenziali.
A questo punto si impone però una domanda di fondo che fuoriesce dalla contingenza politica. Una Costituzione (e ci riferiamo in particolare a quelle, come la nostra, stabilite al termine del secondo conflitto mondiale) può sopravvivere ai rapporti di forza tra le classi che ne hanno determinato la genesi e la natura? Il giurista risponderà di sì perché la Carta costituzionale non è solo un prodotto, ma anche uno strumento, una proiezione verso il futuro, un linguaggio comune, un quadro che non esclude evoluzione interna, un impianto categoriale «a priori», insomma. E anche lo storico potrebbe convenirne, ma dovrebbe onestamente aggiungere che questo è vero solo fino a un certo punto.
E questo punto non è necessariamente, nel mondo contemporaneo, una rottura bellica o rivoluzionaria. Non sono certo serviti i carri armati per inscrivere in Costituzione il pareggio di bilancio. Lo stesso articolo primo della Costituzione italiana, quello che nessuno si sognerebbe di toccare, rivela, a ben vedere, le ferite subite dalla storia: il lavoro si è infatti andato trasformando in qualche cosa sulla quale riuscirebbe impossibile fondare oggi una Repubblica. Ha cessato di essere, per dirla in estrema sintesi, una chiara soggettività politica rappresentabile nello Stato.
Riconfigurazioni istituzionali
Da questo angolo visuale la crisi della rappresentanza appare sotto tutt’altra luce. Non come tradimento dei rappresentanti arroccati nella cittadella della «casta», o asserviti agli interessi dell’oligarchia, ma come crisi dei rappresentati stessi, come trasformazione delle loro vite, delle loro aspirazioni e delle loro attività in qualcosa che non trova più il modo di incidere e pesare, né direttamente né indirettamente, sulla produzione di norme e sulla decisione politica. Se i sindacati hanno lasciato cadere fuori dalla propria sfera di pensiero e di azione una fetta sempre più imponente di società, se i partiti si sono trasformati in compagnie di ventura e uffici di collocamento, questo non è l’effetto ma la premessa delle riforme che stanno riconfigurando la geografia istituzionale italiana. Se non si prende atto di questo sostrato la marcia trionfale dell’«esecutivo» appare come qualcosa di sostanzialmente abusivo, deviante, e dunque fragile.
La lettura tutta politico-istituzionale di questi processi sfocia inevitabilmente in una risposta politico-istituzionale. E cioè nell’idea che la parte migliore della rappresentanza, cresciuta consapevolmente nella crisi della medesima, torni a rappresentare attraverso una nuova forza politica parlamentare e in prospettiva popolare, gli sfruttati, gli svantaggiati e i cittadini defraudati degli strumenti della democrazia. Laddove il discorso e il programma anticipano le lotte quando non ne prendono direttamente il posto.
Una lettura focalizzata sulle metamorfosi del lavoro e sui rapporti di classe che ne conseguono sfocerebbe invece in quella idea di «coalizione sociale» che nel reciproco riconoscimento delle diverse soggettività investite dalla crisi e dalla sua governance liberista (nonché dalla percezione dei loro limiti) troverebbe la sua immediata politicità. Ma poiché di quest’ultima non è pronta a farsi pienamente carico si arresta sulla soglia della sua stessa esistenza. Pur ben fondata sul piano dell’analisi resta incapace di continuità organizzativa e di esercitare forza politica. Troppo «in alto» gli uni, troppo «in basso» gli altri nella riproduzione perdente di quella distinzione tra sfera sociale e sindacale e sfera politica del tutto inadeguata a contrastare la poderosa fusione tra mercato e potere. Solo un rimescolamento generale imposto da una crescita fuori misura della pressione sociale sui livelli amministrativi e di governo potrebbe forse superare questo scarto. In Europa se ne vedono le tracce, in Italia assai meno.
questo articolo è stato pubblicato sul manifesto dell’11 novembre 2015