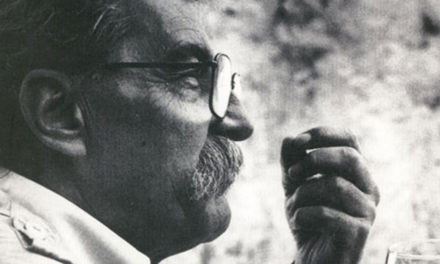Continuiamo a raccogliere materiali di riflessioni sia del collettivo sia di “esterni” che ci sembrano importanti. Le mobilitazioni che stanno caratterizzando il periodo più recente presentano caratteri di novità rilevantissimi. Dal punto di vista programmatico: libertà di movimento, riappropriazione della democrazia anche e soprattutto nelle sue dimensioni più ‘dirette’, antiautoritarismo e riapertura di spazi di liberazione, diritto alla città e rilancio della sfida alle “recinzioni” metropolitane… Sono evidentemente accenni, inizi, attraversati da mille contraddizioni: ma cambiano il panorama, ed è importante indagarli cercandone gli elementi di novità, di spinta, di trasformazione. Ma è dal punto di vista dei soggetti che il campo sta cambiando ancora più rapidamente: una trasformazione di soggettività, una composizione che non solo enuncia l’intersezionalità come fondamentale, ma sembra direttamente incarnarla, nonché un salto generazionale evidente a chi pratichi questi nuovi spazi di mobilitazione. Euronomade ha cominciato a interrogarsi su queste trasformazioni, che nel seminario di Bologna, e in qualche intervento già pubblicato, abbiamo cercato di nominare come riemersione di un evidente tratto “moltitudinario”: abbiamo l’intenzione di tornare su questa analisi, dedicando a questi mutamenti, e alle ricadute decisive che richiedono sul lato delle esperienze organizzative, un appuntamento seminariale autunnale. Nel corso del quale cercheremo anche di interrogarci, “a partire da noi”, sul senso che potrebbe avere oggi un’esperienza di “pratica teorica”, come quella di cui Euronomade è espressione, mettere a verifica, senza dare nulla per scontato, quali potrebbero essere le modalità, i luoghi, il tipo di impegno richiesti per queste sfide.
Di FRANCESCO RAPARELLI.
Viva l’Italia! Grazie ai mondiali di sci alpino di Cortina d’Ampezzo 2021 e le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026, l’Italia riparte. Lo conferma Alessandro Benetton, che senza peli sulla lingua ha chiarito a RAI News 24 (25 giugno): «gli imprenditori hanno la pancia un po’ troppo piena, bene che tornino a investire». Neanche a dirlo, lo fanno per i giovani, ed è bene che i giovani si sbrighino a ringraziare per i lavoretti sottopagati se non gratuiti che li attendono. E se non fosse così drammatico il declino italico, poi, non sarebbero così smargiassi – e patetici nello stesso tempo – i festeggiamenti per le Olimpiadi invernali: urla, vanità, tricolori, servizi fiume dei TG, speciali notte, ecc. Con Malagò e Montezemolo che si stagliano bronzei, a sottolineare che tra ricchi e poveri, in Italia e non solo, la differenza è tornata a essere somatica: i belli e i brutti, gli alti e i bassi, i magri e i grassi ecc.
D’altronde, per afferrare i colpevoli del disastro che ci tocca in sorte, «onda nera» compresa, basta leggere la stampa dell’establishment. Con precisione e mitezza, sulle pagine della Corriere della Sera Federico Fubini non fa sconti a nessuno: se l’Italia non esce dalla crisi, è colpa del nanismo delle imprese, dei loro mancati investimenti in innovazione e ricerca, della scarsità e incapacità dei manager. Insomma, in soldoni, la borghesia italiana è svanita, evaporata, scappata. Quando non è già in America, pensa di risolvere i problemi con gli eventi sportivi, le grandi opere, finanziamenti pubblici, tagli delle tasse, evasione fiscale, compressione salariale – come se non bastasse mai.
Ma leggiamo cosa scrive Fubini, liberi dalle “ideologie”:
Luigi Consiglio di Gea, un consulente, mostra che la Francia ha quasi la stessa produzione manifatturiera dell’Italia con 800 mila addetti in meno. Un addetto in Italia crea 60 mila euro di valore l’anno, in Francia di 73 mila, in Germania di 77 mila. Non perché gli italiani siano pigri, ma perché troppe imprese sono troppo piccole […]
Con riferimento ai dati di Penn World Table:
All’inizio di questo secolo in Italia si generavano 48 dollari ogni sessanta minuti di impegno, circa un quinto più che in Germania. Ma appunto vent’anni dopo la Germania è del 30% sopra; anche Spagna o Francia hanno visto rapidi progressi, mentre l’Italia è rimasta sostanzialmente ferma. Tutto questo ha ricadute per la qualità della vita, perché oggi in Italia ogni anno un occupato in media lavora l’equivalente di oltre due mesi in più di un collega tedesco per produrre poco meno di lui [corsivo mio].
In termini rigorosamente marxiani, in Italia, capitalisti nani e straccioni cavano «plusvalore assoluto», perché altrimenti non riescono a competere nello scenario europeo e globale. La nostra vicinanza al blocco di Visegrad è produttiva e salariale, non è semplicemente politica – ciò, contrariamente a quanto pensano democratici e liberali vari. Non abbiamo ancora Zone Economiche Speciali, vero, ma il Sud in parte lo è da sempre. No, non sto riproponendo la determinazione lineare della sovrastruttura politico-giuridica da parte della struttura economica – tra l’altro da Marx mai affermata: insisto sul concatenamento di fattori che ci scuotono verso Est. Tra questi, e di certo non minori per importanza: la funzione costituente dell’economia criminale, la violenta moralizzazione dei corpi delle donne e delle forme di vita giovanili/alternative, la marginalizzazione del dissenso mediatico. Il vento dell’Est è questo intreccio di dispositivi che vede protagoniste le imprese italiane, la cosiddetta classe dirigente, il «partito del PIL».
Ma il problema non è emerso agli inizi degli anni duemila, come i numeri proposti da Fubini ci indicano. Viene da lontano, più precisamente dagli anni Settanta: la crisi di comando, l’estensione delle lotte operaie e sociali (studentesche, femministe) di allora fu l’ultimo grande motore dell’innovazione produttiva. Innovazione che favorì decentramento e «capitalismo molecolare», dei distretti, del «piccolo è bello». Il cosiddetto «terzo capitalismo», dopo quello familiare e quello delle partecipate, che oggi pare – così dicono – superato dal quarto, quello delle «multinazionali tascabili». Decentramento, nanismo, familiarizzazione e individualizzazione della forma impresa, estensione a dismisura del lavoro autonomo (tanto di prima che di seconda generazione): queste le formule per rispondere alla fuga di centinaia di migliaia di giovani dal lavoro sotto padrone, ma anche – e sarebbe sbagliato negarlo – per ristabilire il comando, duro, sulla forza-lavoro. Comando ratificato tra il 1992 e il 1993, attraverso la moderazione/compressione salariale concertata, durata quasi un trentennio senza soluzione di continuità. Convinti di aver positivamente scambiato potere con salario, i sindacati confederali hanno favorito la precarizzazione di una generazione, senza badare al fatto che le imprese non stavano mantenendo i patti. Quali patti? Salari tiepidi, anzi bassi, ma investimenti in innovazione e ricerca: così diceva l’accordo tacito, a volte esplicito, ma mai rispettato dalla italica borghesia.
Ed è così che quando la crisi dei subprime (ovvero dell’indebitamento privato divenuto oggetto di speculazione finanziaria) ci ha raggiunto, con un paesaggio produttivo già in macerie, Berlusconi Sacconi e soci hanno proceduto con l’affondo: l’Italia sia di nuovo Italietta, nei gradini bassi della divisione internazionale del lavoro, fuori dai coglioni laureati e giovani pieni di speranza. Non stupisce, allora, che in Italia da un decennio in TV si parla solo di cuochi – intendiamoci, massimo rispetto per i cuochi dai «piedi scalzi» che faticano nelle cucine pubbliche e private. Chi cucina, anzi, si occupa di Food, all’inglese, che fa figo. Migranti in campagna come schiavi, con la lupara libera nelle mani di padroni e caporali per chi alza la testa. Con le donne straniere del ragusano che, come un secolo e mezzo fa negli Stati Uniti, di giorno schiave nei campi, di notte schiave del sesso (del padrone). Migranti nelle cucine: loro non fanno Food, non sono «stellati», semplicemente lavorano in nero o con metà dello stipendio «fuori busta». Pare strano che nessuno se n’accorga, considerando che gli italiani tra aperitivi e cene di certo non risparmiano; aiuta però l’adagio tra le belle anime democratiche: «…d’altronde, fanno quello che i nostri giovani non hanno più voglia di fare». Choosy, direbbe Fornero, sempre in TV perché, solo se apre bocca, Salvini conquista due punti percentuali in più. Dunque cuochi stellati. Ma poi camorristi a tutto spiano, e ragazze bone e ragazzi boni che vanno in palestra e abballano, cantano, si fidanzano, litigano, ecc.
I giovani dei quartieri bene – un po’ meno a Milano e a Torino, sicuramente a Roma – in Italia fanno il liceo. E basta. Poi si parte per London, New York, Paris, Berlin, e così via. Dell’Italia ricordano le tate filippine che li hanno cresciuti, le macchine cinquanta con le quali andavano a scuola a 300 metri da casa, le vacanze di luglio a Ponza, prima della barca a vela agostana. E ovviamente il ristorante giapponese raffinato e costoso, gli spazi autogestiti abusati con arroganza e fregandosene al momento giusto, l’equitazione, qualche spruzzatina di arte contemporanea, l’esotica avventura (per i romani) da Betto e Mary, e poco altro. Dunque, come si dice? «Scialla», nel senso che loro, mentre la nave affonda e la vita metropolitana giovanile viene desertificata, stanno sereni: non solo studiano, ma ballano scopano si drogano fanno figli all’estero. Più che scialla, direbbe Martellone (Boris): «e sti cazzi».
Ma poi sorge il problema: cosa diventa il capitalismo italiano senza borghesia? Ovvero senza riproduzione – culturale oltre che biologica, sociale – e stanzialità di classe dirigente? I 5 Stelle, per non sbagliare, hanno pensato di vendere il paese alla Cina. Germania e Francia in questi dieci anni hanno già fatto molto. E gli Stati Uniti vogliono la TAP, per motivi geostrategici molto chiari, continuando a vendere F35 come se piovesse. Capitalismo senza morale borghese: è così almeno dagli anni Sessanta, come direbbero quei due geniacci di Recalcati e Fusaro. Anzi, tutta colpa del Sessantotto: giusto! Tra l’altro, chiarisce l’ISTAT che entro il 2050 il 40% (circa) della popolazione italiana sarà oltre i 65 anni.
Proviamo a ricapitolare. Giovani (più o meno) formati cacciati all’estero da un piano di evacuazione che vede in Salvini e nel Messaggero gli esecutori ultimi; una donna uccisa – prevalentemente dal marito, compagno o suo ex, prevalentemente tra le mura domestiche – ogni due giorni; ricchezza interamente accentrata nelle mani di pochissimi, che non hanno staffetta familiare né possono contare su bravi manager; tessuto produttivo arretrato sul piano tecnologico e ridotto del 20% negli ultimi 20 anni; si lavora più di tedeschi e francesi, il salario è quella ungherese, il costo della vita quello di New York, i servizi quelli di Bagdad; paese più vecchio d’Europa, entro trent’anni composto quasi per la metà di vecchi a cui nessuno potrà pagare la pensione, tanto lo squilibrio generazionale (e la pensione dei pensionati, si sa, la paga chi lavora); libera distribuzione delle armi ai padroncini di capannoni e aziende agricole, così ladri stranieri e manodopera migrante non rompono le scatole; programmi TV sui cuochi stellati e i camorristi, in alternativa isole varie e grandi fratelli; un Decreto sicurezza ogni trimestre, affinché ci sia una pena specifica per ogni singolo comportamento del dissenso, dagli scudi in plexiglass al lenzuolo appeso ai balconi. Mai un romanzo di fantascienza è stato in grado di prefigurare uno scenario così catastrofico. Mai.
La domanda da fare e da farsi, allora, è: perché restare? Soprattutto, cosa fa chi resta? Alla prima domanda si può in prima battuta rispondere che andare all’estero, nonostante la libera circolazione europea, non è indolore o gratuito: costa. Ma c’è anche chi ha pensato e pensa – come chi scrive – di restare per combattere. Intendiamoci, l’arretratezza italiana non mi spinge a ipotizzare che siamo in una situazione simile a quella russa nel 1917 – tra l’altro, pure all’epoca la similitudine non fece presa. E non ritengo la mia scelta, e la scelta di tante e tanti altri assai attivi nelle battaglie sociali, eroica. Ci sarà senz’altro ateo spirito di sacrificio, un prendersi troppo sul serio, un po’ di vanagloria o ambizione, perché no? Il fatto è un altro: nelle condizioni in cui si trova il paese, restare non può non voler dire combattere, per costruire e consolidare istituzioni democratiche e alternative. Ciò per i militanti di base, come il sottoscritto, ma pure per i tanti dispersi ma bravi che hanno reso vivaci i movimenti tra la fine dei Novanta e il 2011 e che non se ne sono andati (nelle lotte sindacali, per esempio, se ne incontrano a frotte), le giovanissime e i giovanissimi che con il movimento femminista e quello ecologista fanno le prime esperienze di politicizzazione, i migranti che in Italia fuggono – e chi non ha perso la dignità salva nel Mediterraneo – o vengono sfruttati.
Il movimento femminista, lo sappiamo, è stato il solo a sviluppare in termini globali, radicalmente conflittuali e istituzionali (nel senso delle istituzioni indipendenti, non di quelle statali) la sua esplosione. Si addensano potenti, seppur a volte molecolari, i conflitti nel lavoro: una nuova sindacalizzazione diffusa è in marcia. Ma è da troppo tempo che, salvo le emergenze, in Italia mancano occasioni di convergenza: organizzativa, programmatica, delle pratiche di lotta. Mancano, perché la mia generazione non si è mai riuscita a liberare del tutto degli anni Settanta (e dai militanti degli anni Settanta, con il loro paternalismo normativo), e lo dico in senso positivo, non “rottamatore”. Mancano, perché di fronte all’offensiva sovranista si sceglie il ripiegamento identitario. Mancano, perché il vuoto di proposta politica, anche elettorale, successivo al 2011 si è risolto nel pieno del Movimento 5 Stelle – e i 5 Stelle, pur introducendo il reddito di cittadinanza e proponendo il salario minimo, governano e chiudono i porti con Salvini (il Ministro dei due Decreti sicurezza). Mancano, perché le forme maschili (e competitive) della politica dei gruppi, quelle ereditate dagli anni Settanta, non fanno più presa sulla società, sì impoverita ma che vuole «decidere con la propria testa»; magari arrogante, inzeppata di fake news o rispetto acritico della legalità, ma non stupida. Mancano, perché la mia generazione, forse, doveva e dovrebbe osare di più: istituzioni del lavoro vivo, della cura, contropoteri, ma anche autogoverno dei territori urbani. Per fare tutto ciò, inutile prendersi in giro, il basso è necessario, ma non in ogni congiuntura sufficiente. Il basso è la sorgente, la fonte costituente, poi però occorre consolidare, conquistare tempo e spazio, moltiplicare impresa solidale e mutualismo economico (con l’aiuto e i denari degli over 65 di «buona volontà»), servono governi che pur non essendo amici, non siano nemici. Senza illusione alcuna, senza pensare che Podemos abbia risolto i problemi, perché non è così, è fin troppo evidente. Ma senza raccontarsi la balla che de Magistris e Salvini, Ocasio-Cortez e Orbán, Colau e Bolsonaro sono la stessa cosa: perché non è così. Se, facendo seriamente come fanno le donne, istituzioni alternative – del lavoro vivo, della cura, dell’infanzia, della formazione permanente, dello sciopero –, e come fanno i gilet jaunes – radicalizzando la pratica del blocco metropolitano e del contropotere –, riuscissimo anche a favorire, per quel che ci compete, governi locali non ostili, non razzisti, non sessisti, non fascisti, non liberisti, magari questi stessi messi in rete in Europa, direi che restare sarebbe sempre faticosissimo, ma non inutile. Gesto glorioso, di certo non superbo.
Questo articolo è stato pubblicato su DinamoPress il 27 giugno 2019.