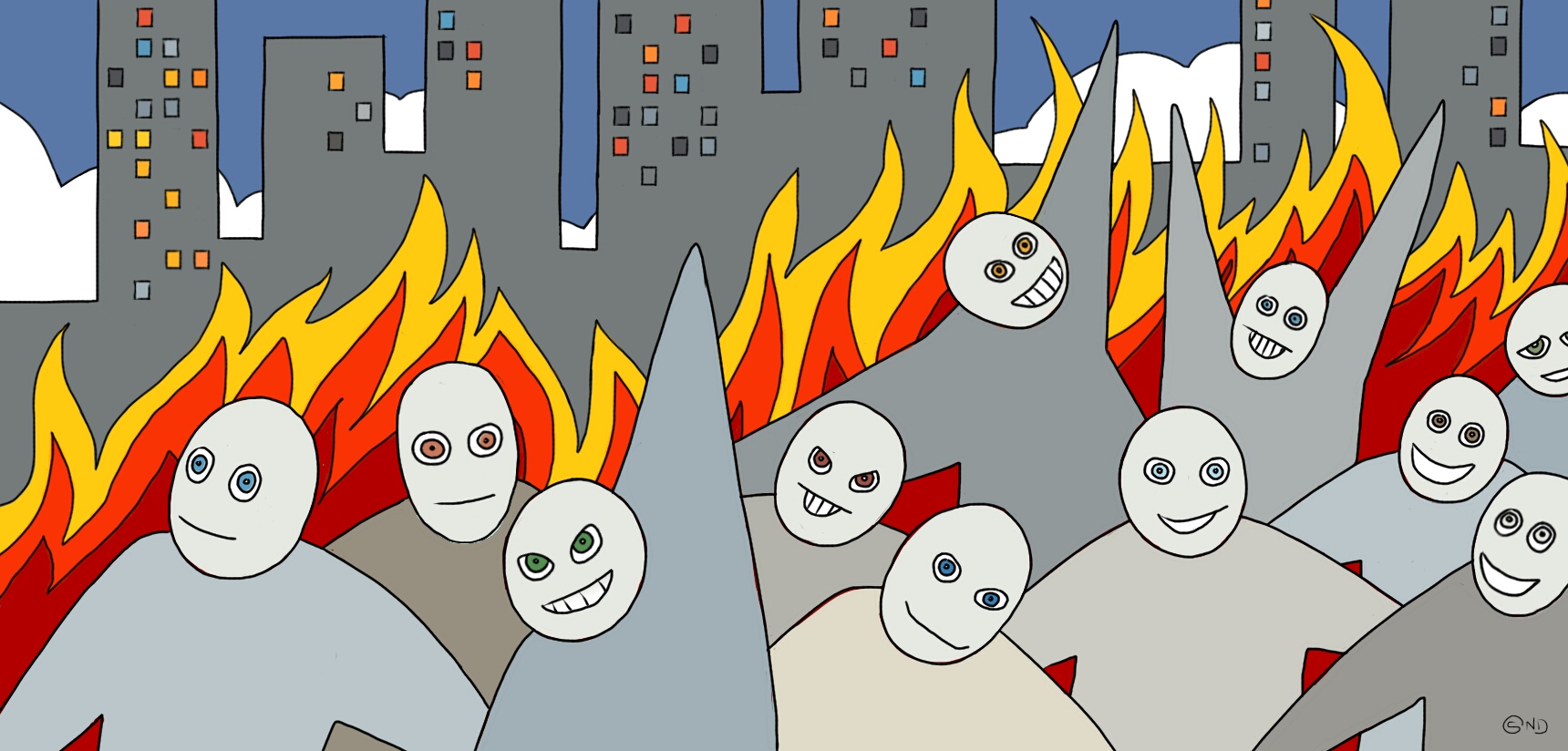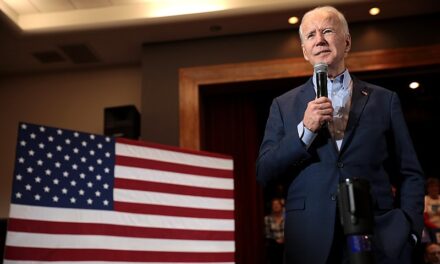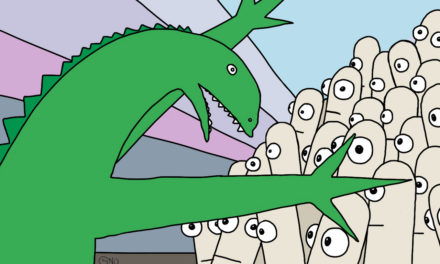di GABRIELE BATTAGLIA (da Pechino).*
«All’epoca dei miei genitori ci si fidanzava così: uno dei due scriveva all’altro una lettera in cui citava quella frase del presidente Mao in cui dice “siamo distanti, ma il nostro scopo è comune” e l’altro capiva. Dopo di che le famiglie verificavano la reciproca correttezza di classe. Se una famiglia era rossa, ovviamente non si abbassava a mischiarsi con una famiglia nera, capitalista, dei nemici del popolo».
Quali sono i confini di classe, in Cina? Un tempo era tutto più semplice. La storia raccontata dall’amica cinese ci rivela che all’epoca di Mao, appartenere a questa o quella classe sociale era quasi una faccenda ereditaria che poco aveva a che fare con la propria collocazione nei rapporti sociali.
Il Partito definiva la classe, ma era una definizione in continuo movimento. In un Paese dove il proletariato era residuale e la stragrande maggioranza della popolazione continuava a essere contadina, erano stati infatti la guerra antimperialista (contro i giapponesi) e civile (contro il Guomindang), il Soviet del Jiangxi e poi l’epica esperienza della Lunga Marcia, a fare della classe un soggetto politico attivo che si ridefiniva continuamente nel rapporto dialettico con il Partito. Il quale, a sua volta, si emancipava dalla sua originaria natura di organizzazione composta da intellettuali piccolo-borghesi delle città.
«Era necessario che i membri del Partito si immergessero tra le masse e imparassero dalle masse», dice Wang Hui, noto intellettuale della “nuova sinistra” cinese, nel paper La crisi della rappresentatività e la politica post-Partito. «Senza organizzazione, la soggettività delle masse non avrebbe potuto esprimersi. Ma senza diventare tutt’uno con le masse, imparando da loro, l’organizzazione avrebbe perso la propria energia e sarebbe diventata una mera struttura di dominio sulle masse. Il Soviet era la forma attraverso la quale le masse prendevano forma e il Pcc era l’organizzazione politica attraverso la quale il proletariato poteva esprimersi.»
Una volta conquistato il potere e tramontata l’epoca dei Soviet, nel 1949, il Partito prende via via a identificarsi sempre più con lo Stato. Solo le continue “campagne di massa” indotte dall’alto, cioè da Mao in persona, permettono di mantenere quel “movimento” che ridefinisce la classe di continuo. E che impedisce la burocratizzazione del Partito.
In questa continua ridefinizione, che spesso spiazza (e affligge) i cinesi qualunque, la “classe” viene interpretata piuttosto flessibilmente nella vita quotidiana.
«Le famiglia di mio padre e di mia madre erano di altissimo livello. I primi erano latifondisti, i secondi avevano una fabbrica che produceva baijiu (grappa cinese) e un’altra di vestiti», racconta ancora l’amica cinese. «Dalla parte di mio padre, uno zio era un potentissimo funzionario del Partito a Shanghai e andava in giro perfino con la pistola, cosa che a quei tempi dava ulteriore status. Ma quello zio comprese che stava per cambiare il clima e quindi pensò bene di regalare una montagna intera, che era della nostra famiglia, al governo, che poi era il Partito. Così da famiglia “nera” – latifondista e nemica di classe – scesero automaticamente al livello di famiglia “rossa”, proletaria. Il che significa che in realtà salirono di status un secondo prima che cominciasse la Rivoluzione Culturale. Dalla parte di mia madre invece si incaponirono a restare “neri” e quindi poi ci furono dei problemi a far sposare i miei due genitori, che non appartenevano più alla stessa classe sociale. Alla fine ci riuscirono grazie al guanxi [la rete relazionale, ndr] delle due famiglie.»
Ma la Rivoluzione culturale è l’ultimo momento in cui la classe conta. Poi c’è la Cina di Deng Xiaoping, quella in cui “arricchirsi è glorioso” e dove “qualcuno si arricchirà prima di altri”. Il Partito si fonde completamente con lo Stato e si depoliticizza, si svuota del concetto di classe. I funzionari politici si trasformano in manager e cominciano a macinare punti di Pil e ad accumulare privatissime ricchezze. La forbice sociale si amplia, così come la divisione di classe. Ma si fa finta che non ci sia.
Ricompare la proprietà privata (ma non per i contadini). Nella testa della gente prima ancora che per legge: «Sono tornata sulla nostra montagna con i miei fratelli. C’erano delle persone che pregavano in quello che era stato il nostro tempio di famiglia. Non ho resistito e ho gridato loro: “Cosa ci fate qui? Questo è il nostro tempio!»
Nostro, nostro e nostro.
A sancire la fine del Partito di classe arriva la teoria delle “tre rappresentanze” di Jiang Zemin: le “forze produttive avanzate”, cioè la neo-borghesia, si uniscono a intellettuali (la “cultura avanzata”) e popolo (“interessi della vasta maggioranza”) – tutti insieme appassionatamente – per costruire quella ricchezza che, sola, potrà emancipare l’intera Cina dalla sua secolare subordinazione all’Occidente.
Il Paese deve essere “armonioso” (slogan poi lanciato dal successore di Jiang, Hu Jintao). Si parla ancora di classe, sì, ma non è più una categoria politica, in movimento: è un concetto positivista, da scienza borghese, incasella la popolazione come in un database. Chiamiamoli “strati sociali”, che è forse meglio. Ognuno avrà la sua quota all’interno dell’Assemblea Nazionale del Popolo: contadini, operai, businessmen, così come le 56 etnie che compongono l’immensa Cina.
A questo punto, si verifica però un paradosso: il Partito che vuole rappresentare tutti, perde rappresentatività. Fenomeno che si manifesta, secondo Wang Hui, nella «sua crescente distanza dalle persone, specialmente quelle provenienti dagli strati sociali inferiori. Sì, ci sono delle politiche volte alla protezione dei lavoratori; tuttavia, è dura trovare qualche collegamento organico tra la politica del Partito e una politica degli operai e dei contadini.»
Così la lotta di classe sfugge da tutte la parti. La Cina definita “turbocapitalista” da un’ampia pubblicistica vede definirsi nuovi confini. Li percorriamo quotidianamente osservando il grande gap tra città e campagna e il conflitto etnico semisommerso che ogni tanto esplode.
In questo contesto, il Partito depoliticizzato non riesce più a contenere il conflitto: Ong, comitati di villaggio, avvocati per i diritti civili, sono tutte forme di organizzazione fuori dal Partito-Stato. Il quale, da parte sua, cerca di ricomporre le contraddizioni di una società sempre più complessa con la ricetta positivista del progresso: se porteremo più investimenti, più infrastrutture, più qualità della vita nei luoghi che sono rimasti indietro sulla via del “moderato benessere”, ogni problema si risolverà.
È questa la nuova “linea di massa” nell’epoca della post-politica.
Ma può bastare? Di fronte al progetto di una nuova ecocity in Xinjiang – un agglomerato da 60mila abitanti – un giovane architetto della locale minoranza uigura ci ha detto: «C’è il rischio enorme che questo sia un mianzi gongcheng – un progetto “della faccia” (o di facciata) – mentre una crescita sostenibile dello Xinjiang significa recuperare e ristrutturare le vecchie città, dare opportunità alla popolazione locale. Questo deve venire prima o in parallelo alla costruzione di nuove grandi opere. Ma non se ne vede l’ombra».
Wang Hui, in un’intervista che gli abbiamo fatto la primavera scorsa, ci ha detto che il problema più urgente della Cina contemporanea è quello di produrre più eguaglianza nella diversità: «È perfettamente legittimo voler migliorare la situazione economica nei luoghi di frontiera, ma abbiamo anche una crisi ecologica che va di pari passo con una crisi culturale, perché lo stile di vita di quella gente sta cambiando e così abbiamo i conflitti in Xinjiang e Tibet.
Tutto questo significa che abbiamo bisogno di una nuova idea di uguaglianza che incorpori l’idea di diversità: non possiamo semplicemente equiparare tutto e tutti , ma cercare di rispettare la singolarità, la diversità, le differenze, senza rifiutare l’idea di base di uguaglianza. Questa è la sfida, perché l’uguaglianza moderna era basata sull’idea di cittadini che sono uguali. Ma ora come possiamo confrontarci con diversi stili di vita, religioni, con la la biodiversità e l’ambiente?»
Dunque, il Partito ha perso il suo contatto con le masse? Nel suo indicare un obiettivo generale – la ricchezza moderata e condivisa – i comunisti cinesi agiscono da nuova classe burocratica al potere oppure da avanguardia costantemente alle prese con l’immenso compito di emancipare il popolo cinese?
Novembre 2013. Il Terzo Plenum del Partito comunista lancia un grande programma di riforme che segnerà i destini della Cina da oggi al 2020.
Prese insieme, le nuove misure possono essere così riassunte: rappresentano il tentativo di trasferire ricchezza dai poteri costituiti alle famiglie. Il paradosso è che si tratta di una rivoluzione di “mercato”, perché le grandi imprese di Stato vengono messe sullo stesso piano di quelle private, esposte cioè alla concorrenza; perché viene concesso a capitali privati di costituire un sistema bancario indipendente da quello di Stato; perché ai contadini viene finalmente data la terra che coltivano, affinché la mettano sul mercato oppure la coltivino meglio; perché agli stessi contadini viene concessa libertà di movimento attraverso la riforma del sistema di residenza obbligatoria (hukou), che prima li inchiodava alle terre o li gettava in pasto alle città, da migranti, senza diritti e servizi; perché viene creato welfare, con un sistema pensionistico e uno sanitario sul modello delle assicurazioni private Usa, anche se integrate dal supporto pubblico.
Tuttavia, nella Cina contemporanea, dove il settore pubblico è già stato ampiamente ripulito dalla sua componente operaia (60 milioni di licenziati nelle ristrutturazioni degli anni Novanta) e dove le grandi Soe sono l’ecosistema dove si creano grandi ricchezze private e interessi costituiti, “privatizzare” e “liberalizzare” oggi non significano necessariamente applicare ricette neoliberiste a vantaggio delle elite. Specialmente perché i beneficiari di nuove linee di credito bancario, di un rinnovato welfare più efficiente, della libertà di movimento (“libera” in quanto tutelata da pari diritti in città e in campagna) sono potenzialmente i ceti medio-bassi. L’ambiguità continua.
Il Partito rivela la sua profonda natura socialista e punta a concludere il percorso iniziato nel 1921? Oppure la classe burocratico-borghese al comando sta semplicemente concedendo un po’ per avere in cambio molto di più? O ancora, stiamo assistendo a un conflitto interno tra due diverse elite di Partito, con i neoliberisti che attaccano i boiardi di Stato?
Suscitò grande scandalo Han Han, noto rallysta, scrittore, pop star, blogger da milioni di pageviews, quando nel 2011 disse che quando si ha a che fare con un entità così grande come il Partito-Stato-comunista-cinese, non ha senso essere “contro”, perché al suo interno ci sono tante e tali contraddizioni che è proprio lì che si gioca la partita. Esso stesso è percorso dal conflitto di classe.
Forse è proprio così. E il significato delle odierne riforme, nella storia del conflitto di classe in Cina, lo sapremo solo con il senno di poi. Cioè, a occhio e croce, nel 2020 o giù di lì.
*Articolo pubblicato sul primo numero di Asia Magazine, novembre 2013