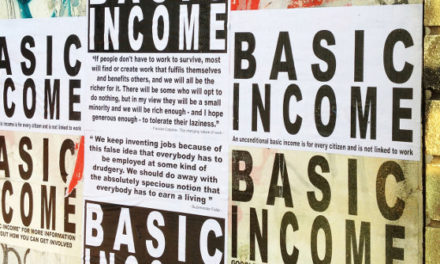Di VIVIANA VACCA
Con Tano D’Amico, l’immagine diventa fare una foto. E fare una foto non significa, in questo caso, costruire un prodotto per la vendita, ma il modo per sentire il mondo e gli altri. Un nuovo racconto, una nuova storia e, dunque, una nuova estetica dell’immagine con il marchio singolare del bianco e nero: lo stile seppiato e icastico del bianco e nero. Le immagini che vivono sono altrettante fotografie mute: smettono di parlare perché si capovolge la relazione con chi le guarda, sono loro a pretendere qualcosa da noi, un cambiamento di sguardo. La violenza come cifra costitutiva dell’immagine nell’atto dell’esposizione – immagine che non vive nella polarità separata tra forma e contenuto – ribalta domande quali c’è un tipo di fotografia che devo fare? Come posso con un’immagine non contribuire alla costruzione di una falsa informazione visiva? Quale rapporto esiste tra le immagini e la memoria storica?
È una battaglia, quella contro la lingua, che procede dall’interno della lingua stessa, attraverso opportuni sviamenti. E poiché il linguaggio umano è il terreno in cui cresce il potere, diventa doppiamente difficile non solo non esserne sottomessi ma anche astenersi dall’usarlo a scopo intimidatorio. La lezione del grande fotografo dei movimenti – intendendo quelli della vita, dell’emergenza delle masse come divenire minoritario degli esclusi, degli insoddisfatti che fanno nascere le immagini – è contenuta in questo Fotografia e destino. Appunti sull’immagine (Mimesis, 2020) cristallizzandosi nella domanda posta in esergo: può l’immagine amare così tanto la vita da cambiarne il destino?. Il destino che ci rincorre fin dal titolo ci riporta al Benjamin del saggio del 1921 in cui ad essere decisivo è il fatto che si manifesti attraverso segni di rottura continui, in opposizione ad ogni forma di carattere inalterabile; non è casuale, infatti, che nella sua Piccola storia della fotografia del 1931, Benjamin ricordasse, agli albori della fotografia, che fosse giudicata quasi blasfema la fissazione chimica su una placca di ciò che è per definizione effimero, sfuggente. La tecnica, infatti, permette di conoscere in quale frazione di secondo c’è una modifica del movimento, di separare oggetto e aura in un intreccio di spazio-tempo che sopprime però ogni distanza e fa del fotografo l’erede privilegiato degli antichi indovini, in grado di scoprire e rivelare colpe e colpevoli. Ogni immagine, dunque, quando è un’immagine che vive è in grado di far saltare il continuum della storia alla maniera di una scheggia, di un lampo di luce. E il fotografo, ci dice Tano D’Amico, ha piuttosto gli occhi del mendicante che non sa giudicare, valutare, separare analiticamente ma piuttosto formula alle immagini nel loro stesso accadere una richiesta d’aiuto, di riconoscimento della bellezza e della dignità della realtà. Le riflessioni di Tano sono un taccuino prezioso in cui emerge come ogni fotografia, ogni immagine debba essere quel dettaglio non svilito e in cui la forza visiva non è mai messa in ombra da una massa omogenea e uniforme che ingloba in sé, oscurandola, ogni singolarità. Visto che le emozioni sono storiche e niente affatto universali, l’immagine fotografica può essere usata con funzione epica, allegorica e lirica, superando la sua vocazione documentale attraverso un montaggio, cioè una presa di posizione, che ricusi ogni dogma o dottrina estetica. Le immagini, quindi, rompono con le vecchie rappresentazioni, legate a loro volta all’immaginario ideologico con maggior potere. In Italia, sono le immagini della questione meridionale – vedere la brutalità di vivere in una casa in otto con la mancanza di servizi o di cibo, vedere come sopravvivono i poveri – e del cambiamento delle città con le donne, gli spazi, gli operai della fabbrica, le periferie che diventano l’altra città.

La fotografia in copertina degli operai sardi a Porto Torres è la loro voce, l’atto politico che crea la lingua in quanto lingua minore, esuli senza permesso di soggiorno dei territori estranei delle pratiche linguistiche maggioritarie. Nasce una relazione stretta tra le immagini e i protagonisti della storia e il fotografico, un assembramento nuovo la cui legittimità non viene rivendicata. La macchina fotografica smette di essere un apparecchio per mezzo del quale rappresentare la realtà, protesi tecnica di addiziona mento documentaristico per divenire essa stessa il reale, la punta di incidenza nel contemporaneo in partecipazione con chi fotografa. Tano ricorda, a ragione, come la storia delle immagini sia stata caratterizzata dalle macchine fotografiche progettate e costruite nei giorni di sangue della Repubblica di Weimar a riprova della guerra intorno alle immagini, tra chi le voleva distruggere perché non controllabili e chi non voleva perderle: immagini insepolte, alla maniera di Warburg. Una presa di posizione è indispensabile per sapere, e per sapere bisogna trovarsi tra due «spazio-tempi», scansarsi dal troppo vicino come dal troppo lontano, movimento che è a un tempo approccio con desiderio e scarto con riserva. Tale fu la presa di posizione di Brecht negli anni della guerra: l’esilio lo costrinse a uno stato di precarietà che si riverbera nei suoi scritti di quel periodo, ridotti ai brevi epigrammi di pochi versi raccolti nel suo Abicì della guerra. Brecht teneva allo stesso tempo un diario, più di un diario intimo di foggia tradizionale, somigliante a un «atelier disordinato o a una sala di montaggio». È la condizione dell’esilio a far sì che lo scrittore si sentisse autorizzato ad attraversare le frontiere dei generi letterari, e rendeva labili le barriere tra il privato e la storia.
La situazione dell’Europa in guerra, da questo punto di vista, gli suggerì l’idea che il soggetto dell’arte fosse il disordine del mondo: i processi di pace, secondo Brecht, sono fatti dall’arte nel momento in cui il mondo è in guerra. Il suo diario di lavoro raccoglie riproduzioni di opere d’arte, foto di guerra aerea, ritagli di giornale, volti dei suoi cari, tabelle scientifiche, cadaveri di soldati, ritratti di politici, statistiche, città distrutte, quadri di maniera, nature morte, grafici economici, paesaggi, oggetti artistici vandalizzati dalla barbarie militare»: questa «eterogeneità ben calcolata» fa del suo Diario di lavoro un autentico fotomontaggio in forma di libro, o di atlante, o di dossier, dove la fotografia si vede investita di una potenza epica secondo quanto scritto da Georges Didi-Huberman.
Questo nuovo tipo di lirismo documentario, che intende dar voce ai senza voce, all’inascoltato della storia, si traduce in una presa di parola polifonica, in un tentativo di nominare l’inimmaginabile attraverso la dimensione dell’immagine, con montaggi iconici e poetici, nei quali nominare e mettere sotto gli occhi sono un unico gesto poetico, secondo il Brecht dell’Abicì della guerra.

Proprio della poesia è il non lasciare nel silenzio precisamente quel che più di tutto fa ammutolire. E la poesia epica è in grado di dominare i segni più di qualunque logica, grazie all’impiego del tempo aoristo, un tempo che riflette l’azione passata sotto forma di azione che sta ancora accadendo, in continuo avvolgimento intorno a un presente enigmatico, intorno all’occhio del ciclone della storia. L’immagine in quanto parola sarebbe allora simile a un verbo aoristo, a sua volta sensibilmente, esteticamente, simile alla reminiscenza della cosa. Il modo in cui si legge un atlante non è lo stesso in cui si legge un libro, dunque, ma procede secondo quel che Benjamin chiamava leggibilità originaria, antecedente a quel linguaggio maturo che sostiene il senso del discorso propriamente detto. È, secondo Benjamin, una lettura per immagini, o una lettura di ciò che ancora non è scrittura; corrisponde infatti a una lettura infantile, guidata dalla curiosità e dal gioco dell’esplorazione, quale si adopera per esempio negli abachi o abbecedari, libri illustrati.
Se il gesto di leggere un dizionario è caratterizzato da un senso denotativo in cerca di messaggi, quello di sfogliare un atlante si realizza in un senso connotativo in cerca di montaggi. Viene capovolta quindi l’analisi di Barthes de la Camera Chiara – un presente che, nell’atto di tuffarsi nel passato per catturarlo ce lo restituisce come un effetto di superficie – a favore dell’immagine della storia benjaminiana così cara a Tano: un’onda che spinge il presente alle spalle, come ne l’Angelus Novus di Klee. Le belle immagini, quelle che vivono, sono per Tano D’Amico, immagini astratte che hanno ricusato la funzione ancillare nei confronti del testo scritto, della parola in affermazione gioiosa della loro autonomia: immagini fatte della stessa materia della rivolta degli operai che non hanno bisogno della didascalia testuale. Accanto e, non più alle spalle, lo studio degli antichi maestri: Leonardo, Caravaggio, Giorgione e la pedagogia della visione in grado di vedere le posture, i gesti, la stanchezza che, in un ritrovato Cenacolo o nel teatro greco, mette in luce la disposizione delle donne e degli uomini nello spazio. Altrettante tessere di quella che, per Tano, è la bellezza dell’universo in questo nuovo e lunghissimo racconto poetico.
LE TRE FOTOGRAFIE SONO DI TANO D’AMICO – “PENDOLARI DI PORTO TORRES” (1972); “IRPINIA” (1980); “LE SORELLE DI GIORGIANA MASI” (1977)
Questo articolo è stato pubblicato su DinamoPress il 12 novembre 2020.