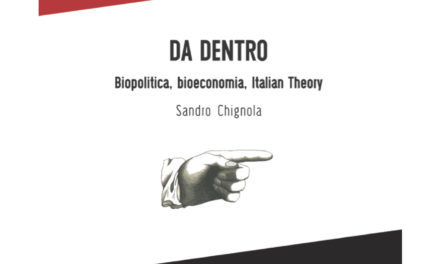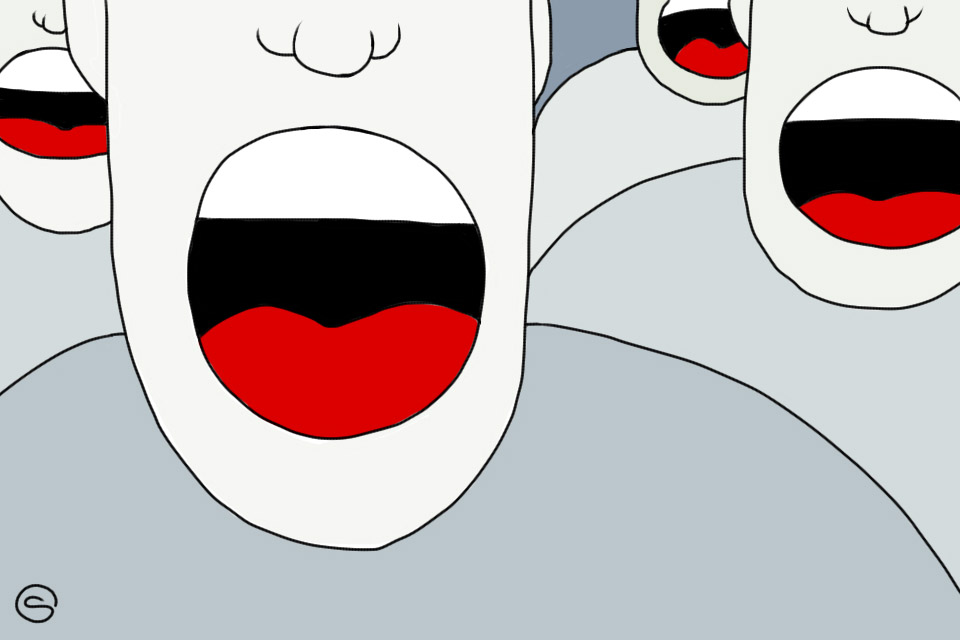Riprendiamo qui tre recensioni di Benedetto Vecchi di “Realismo capitalista”, “The Weird and the Eeire” e “Spettri della mia vita” di Mark Fisher.
Lo scippo del tempo che verrà – 24 gennaio 2018
La più grande rapina si è consumata tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta. A essere stato rubato non è un patrimonio quantificabile precisamente, bensì la capacità umana di immaginare e di dare forma a un futuro che non sia la riproposizione di un presente sempre uguale a se stesso.
È QUESTO IL PUNTO di avvio di due testi che inaugurano una nuova casa editrice, la Nero editions (www.neroeditions.com). Il primo è di Mark Fisher, l’altro, complementare, che riprende il discorso là dove si interrompe il primo, è a firma di Nick Srnicek e Alex Williams. Sono testi di una nuova sinistra inglese che ha preso definitivamente congedo dal marxismo anglosassone e ha rivolto le sue attenzioni a quanto di nuovo e inedito è stato prodotto dal capitalismo contemporaneo.
ENTRAMBI I VOLUMI muovono dalla convinzione che la sinistra politica sia stata espropriata dalla capacità di immaginare il futuro da parte del neoliberismo. Sono stati i neoliberisti ad essere utopici, mentre la sinistra socialdemocratica e laburista ha spesso svolto il ruolo di cane da guardia del passato.
Senza approfondire la genealogia di questa tesi, compiutamente sviluppata da Nick Srnicek e Alex Williams, va comunque segnalato che il neoliberismo ha proposto una vera e propria vision della realtà dove l’enfasi sulle libertà personali si è unita a un conservatorismo di fondo.
Il neoliberismo ha cioè lavorato a un ritorno al passato nei rapporti sociali, facendo leva sulla terra promessa di un futuro grondante di benessere generalizzato.
Mark Fisher, morto suicida lo scorso anno, è stato una figura importante nella network culture. Ha saputo, nella sua breve vita, unire una scanzonata e acuta analisi critica della cultura popolare, partendo dalla capacità di vivisezionare i manufatti culturali messi sul mercato, sia che fossero film, brani musicali, libri. Usando con disincanto le tesi di autori (Slavoj Zizek, Alain Badiou, Frederic Jameson e successivamente Franco Berardi Bifo) tra loro differenti e a tratti dissonanti, ha messo a fuoco questo saggio, finalmente tradotto: il Realismo capitalista (pp. 152, euro 13).
Per Mark Fisher, siamo nel 2009, «il realismo capitalista» fa il verso a quel realismo socialista che nella parte centrale del Novecento ha tenuto banco nel pensiero politico della sinistra inglese, con poche differenze tra la componente, maggioritaria, laburista e quella comunista.
Fisher tuttavia aveva fatto tesoro dell’eredità del Sessantotto: considerava il realismo socialista e il socialismo reale residui passivi da relegare alla «critica dissacrante dei topi». La sua attenzione è qui concentrata sullo svelamento del carattere totalitario del realismo capitalista, che muove da un assunto propagandato da Margaret Thatcher: non è possibile nessuna alternativa all’economia di mercato.
Con acido sarcasmo, l’autore parla, inoltre, dei think thank neoliberisti che hanno sempre propagandato il capitalismo come migliore dei mondi possibili, come cenacoli di «comunisti liberali», intendendo con questa espressione la tendenza ortodossa, autoritaria del neoliberismo.
IL ROMANZO di formazione politica di Fisher non si è però nutrito di nostalgia. È stato protagonista, assieme ad altri, della breve, ma intensa e fertile stagione di un gruppo di ricerca (il Cybernetic Culture Research Unit dell’Università di Warwick) che si proponeva di studiare quel fenomeno riassunto dall’espressione «rivoluzione del silicio», ossia la diffusione di massa dei personal computer e la formazione di una rete globale telematica (l’attuale Internet). I riferimenti teorici sono qui lo statunitense Jameson, ma anche teoriche femministe come Sadie Plant e, meno citata, Donna Haraway. Ma un ruolo di tutto rispetto era conferito alla traduzione di alcuni quaderni dal carcere di Antonio Gramsci, utili per cartografare il farsi egemonia del realismo capitalista, nonché scrittori cyberpunk come William Gibson e Bruce Sterling, e anche i loro fratelli e sorelle maggiori, quali Philip K. Dick e Ursula Le Guin.
Fisher ha avuto la capacità di miscelare il tutto con una passione che dovrebbe essere ripresa ancora oggi, quando la possibilità di un futuro diverso sembra cancellata del tutto. Prendere i manufatti culturali, destrutturarli, facendo emergere sia il loro ruolo nella costruzione del consenso al regime capitalista ma anche gli elementi di critica corrosiva che celano tra le pieghe di un fotogramma o di un brano musicale. E se quando viene dato alle stampe Realismo capitalista la traiettoria cyberpunk ha esaurito la sua spinta propulsiva, il consumo culturale vede il successo della seconda serie di Guerre Stellari, dei vari vampiri e ammazzavampiri, nonché della saga degli Hunger Games: tutti esempi della centralità della figura del ribelle nell’immaginario collettivo, divenuta, ironia della sorte, parte integrante proprio del realismo capitalista.
Fisher ne è stato consapevole, ma l’invito a riprendersi il futuro, e dunque il presente, lo ha portato a misurarsi con la produzione seriale di scarti umani tipica del regime di accumulazione dominante. E come talvolta accade, è rimasto lui stesso stritolato da quella depressione, disagio psichico di un mondo che nega qualsiasi futuro che non sia la riproduzione di un arido presente sempre uguale a se stesso.
CHI PRENDE L’EREDITÀ di Fisher sono sicuramente Nick Srnicek e Alex Williams. Con questo Inventare il futuro. Per un mondo senza lavoro (pp. 359, euro 20) continuano il discorso proprio dove finisce l’altro saggio. Lo stile non è quello cut&paste, frammentario, spesso usato da Fisher. È misurato, quasi didascalico, ma comunque netto nel chiedere una cesura netta, meglio una discontinuità radicale con le culture politiche del movimento operaio e dei movimenti sociali. I due autori sostengono che occorre disfarsi della convinzione che sia il lavoro la fonte dell’identità sociale. Inoltre, il lavoro diventerà sempre più una risorsa scarsa a causa dei processi di automazione che, dopo quello manuale sta riguardando anche il lavoro intellettuale, cognitivo.
La realtà attuale è già una frenetica sliding door tra lavoro e disoccupazione, tenuto conto che il lavoro è precario, intermittente e pagato poco. Il paradosso è che viene chiesto di lavorare gratuitamente con la promessa di una regolarizzazione futura. I due autori non hanno dubbi: l’automazione non si può fermare; la sinistra non può dunque che accelerare la sostituzione degli umani con robot e computer. Agli uomini e alle donne va garantito un reddito di cittadinanza. E se questo serve per evidenziare la critica al «lavorismo» della sinistra, non meno caustica e tagliente è la critica alla folks politics dei movimenti sociali.
Il loro localismo, l’enfasi sul piccolo è bello, la rinuncia a pensare in grande una trasformazione radicale dei rapporti sociali sia a livello locale che nazionale e globale alimentano, secondo Srnicek e Williams, la subalternità e irrilevanza politica dei movimenti sociali.
ANALISI IMPIETOSA, la loro e condivisibile solo quando i due autori fanno riferimento alla rinuncia di molti movimenti sociali a fare i conti con il Politico, motivata dalla convinzione che il mondo si possa cambiare senza prendere il potere. E importante è il diktat politico che occorre riprendersi il futuro dopo lo scippo compiuto dal neoliberismo. E se le loro «riforme senza riformismo» sono funzionali ad attraversare l’interregno nel quale viviamo, ossia in un mondo dove il passato non è del tutto passato e il nuovo fa fatica ad affermarsi, discutibile è il riferimento a fare leva sul cambiamento del senso comune come elemento propedeutico riguardo l’affermazione di una egemonia della sinistra radicale postlavorista.
È innegabile il riferimento alla ricezione di Antonio Gramsci veicolata dal filosofo Ernesto Laclau nel suo Critica della ragion populista. La concezione dell’universale come sussunzione e superamento dei particolari nonché come traduzione delle differenze a una lingua comprensibile a tutti apre le porte a una volontà generale che si vorrebbe relegare a ideologia della borghesia. Inoltre, questo Inventare il futuro assegna al Politico una autonomia dai rapporti sociali e dalla stessa composizione sociale del lavoro vivo che ricorda l’autonomia del politico di un declinante movimento operaio. È prigioniero dell’apocalisse culturale da cui occorre prendere le distanze. Più che discontinuità, il saggio di Srnicek e Williams cede dunque il passo a una circolarità della prassi teorica che rischia nuovamente la paralisi politica.
C’è però da dire che la riconquista del futuro è un obiettivo politico prioritario, proprio ora che la crisi del 2008 ha mostrato che il futuro vagheggiato dal realismo capitalista è un vero e proprio inferno invece che un’utopia pratica che orienta l’azione nel presente. Per questo va compiuto quel passaggio che punti ad espropriare i contemporanei espropriatori del futuro.
Questo testo è stato pubblicato sul manifesto il 24 gennaio 2018.
Elogio interessato del perturbante – 1 settembre 2018
Weird e Eeire, due termini difficilmente traducibili in italiano per il significato molteplice, inafferrabile che hanno anche in inglese. Indicano l’ossessione per ciò che è strano, ma anche per le cose fuori posto, fuori dalla norma. Possono indicare inoltre un sentimento di straniamento cresciuto all’interno di una condizione familiare o di codici relazionali condivisi seppur insoddisfacenti per chi si sente costretto a farli propri. È attorno a questo grumo di significati e di esperienze che si dipana l’ultimo scritto di Mark Fisher, figura intellettuale inglese diventato adulto durante il lungo inverno di Margaret Thatcher e che ha avuto la sua educazione sentimentale alla politica radicale durante il new labour di Tony Blair.
Fisher si laurea all’università di Warwick, dove fa gruppo con intellettuali che cominciano a studiare la teoria cibernetica considerata uno degli architrave di quella network culture che vede il personal computer come una macchina universale che può trasformare il capitalismo, aprendo così possibilità inedite di una liberazione dalla necessità. Fisher è tuttavia convinto che l’angolo prospettico dal quale analizzare tale mutamento sono i prodotti della cultura di massa e popolare – la fantascienza, l’horror, i talk show televisivi, i programmi di intrattenimento oppure la scena musicale underground. Comincia così a scrivere su riviste radicali saggi dedicati ai rave, considerati «zone temporaneamente autonome» dal potere costituito. Oppure passa al setaccio, fotogramma per fotogramma, film inglesi di fantascienza di successo degli anni ’60 e ’70, senza però dimenticare che la saga di Guerre Stellari continua a restituire quell’ambivalenza tra entertainment (film di evasione, dunque) e allegoria di un sistema di potere globale abilmente occultata attraverso l’uso massiccio degli effetti speciali quasi del tutto assenti nei film dei decenni precedenti. Facilita inoltre la diffusione nel Regno Unito delle tesi di Pierre Levy sull’intelligenza collettiva che prende forma nella nascente Internet.
Come Levy, anche Fisher crede che la tecnologia digitale può essere il mezzo per sovvertire le regole plumbee della società di massa. E quando il filosofo francese fa sua l’ideologia dell’individuo proprietario, Fisher prende le distanze da Levy senza tuttavia rinnegare l’interesse per la controcultura digitale. Legge freneticamente le opere di Alain Badiou, Frederic Jameson, Jacques Derrida e Gilles Deleuze. Si addentra nel laboratorio marxiano della critica dell’economia politica, mostrando interesse per i testi tradotti del marxismo autonomo italiano (Renato Panzieri, Mario Tronti, Toni Negri, Franco Berardi Bifo). È uno dei primi intellettuali europei – l’altro è sicuramente Bifo – che invita ad analizzare l’infelicità e la depressione dei militanti come nodo politico da sciogliere e non solo come manifestazioni del potere coercitivo del neoliberismo.
Mark Fisher morirà suicida nel 2017. La sua morte passa quasi inosservata. Solo nella scena radical europea il gesto di porre fine alla propria vita pesa come un macigno, quasi che quel suicidio sia la conferma della massima thatcheriana There is no alternative che Fisher aveva considerato come il problema teorico da risolvere per cercare il punto di fuga da un mondo che, appunto, non prevedeva un «fuori» dal capitalismo. Lo studente promettente che aveva girato le spalle a una sicura carriera accademica aveva mandato alle stampe tanti saggi brevi e un libro che aveva suscitato discussioni anche aspre ma anche notevoli consensi. Realismo capitalista, questo il titolo (il libro è stato tradotto da Nero edition), era tuttavia considerato uno dei pochi testi che aveva provato in Inghilterra a fare i conti con l’egemonia culturale del neoliberismo.
Per Fisher, il neoliberismo era, meglio è, un ordine del discorso che incontra il consenso di massa non perché la sinistra è stata attratta dal canto delle sirene del capitale, ma perché è anche un dispositivo filosofico che ha avuto la capacità di presentare i balbettii di questo o quel teorico critico o l’azione dei movimenti sociali come materiali per sviluppare innovazioni tecnologie, organizzative, sociali. Il neoliberismo non nega il conflitto sociale e di classe, considerandolo l’humus indispensabile per l’innovazione. Alcuni anni dopo, due «allievi» di Mark Fisher, Nick Srnicek e Alex Williams, riprenderanno idealmente il libro Realismo capitalista là dove aveva finito per invitare i movimenti sociali a Inventare il futuro proprio alla luce di alcune tendenze del capitalismo contemporaneo: l’automazione che coinvolge sia il lavoro manuale che quello cognitivo e la possibilità di relegare a dimensione marginale del vivere in società proprio il lavoro, assegnando al reddito di cittadinanza l’unica politica realistica per gestire la transizione a un mondo senza lavoro. Al di là comunque delle conclusioni «pessimiste» del Realismo capitalista, le riflessioni di Fisher meritano attenzione per il metodo che propongono, ad esempio, in questo The Weird and the Eeire (minimun fax, pp. 172, € 17).
Il perturbante, lo straniamento, il fuori posto sono le costanti nella formazione dell’opinione pubblica, cioè nella costruzione dell’egemonia culturale in una società capitalistica matura. Da qui la constatazione della scomparsa delle distinzioni tra cultura alta e cultura bassa, tra riflessione erudita e semplificazione mediatica. Tutto ciò rappresenta delle variazioni nella proliferante tassonomia dei generi e dei sottogeneri dell’industria culturale.
Il Weird e l’Eeire sono dunque il perturbante, il fuori posto, lo straniamento, l’«extraordinario» che l’industria dell’entertainment veicola per innovare i manufatti, cioè le merci culturali prodotte indipendentemente dal medium utilizzato. Può essere un libro, un film, un brano musicale consumato attraverso la carta, un computer, uno smartphone o la tv, ma in ogni caso sono manufatti che servono a costruire il proprio mercato, perdendo così il potere trasformativo che la cultura dovrebbe avere. In altri termini, tutto ciò è un colpo mortale inflitto alla visione illuminista che vedeva nella cultura il viatico di un «buon vivere» affrancato dall’oppressione e dal potere costituito.
Le parti più avvincenti del libro sono quelle dedicate ai romanzi di Lovercraft, di H. G. Wells, di Philip K. Dick, di Margaret Atwood; o quando si analizzano i film della serie di Quatermass, di Lynch, di Fassbinder, di Kubrik, di Nolan. Scrittori e registi che hanno cercato di fare i conti con il Weird e l’Eeire, che diventano rispettivamente il «fuori posto» o la «calma inquietante» del vivere in società, ma che l’industria culturale presenta come variazioni del sempre eguale indispensabili per soddisfare nicchie di mercato sempre in divenire. La fantascienza, l’horror, il fantasy sono così tasselli di una logica culturale del capitalismo che ha fatto propria l’idea di fine della storia e del progresso. Il neoliberismo sussume come sua componente la fine della concezione lineare e progressiva dello sviluppo. Dunque svelare qual è la logica culturale del capitalismo, vedere nella proliferazione dei generi la manifestazione della morte di un’opinione pubblica univoca e massificata. Più o meno le stesse dinamiche e tendenze presenti in Rete, che si basano sulla costituzione e scomposizione di «comunità di simili». La discussione pubblica tramonta per lasciare il posto all’incontro di chi la pensa alla tessa maniera. I social media, i social network e l’industria culturale non fanno che favorire e radicalizzare questa tendenza.
C’è sempre un però rispetto a ciò: la frammentazione andrebbe accolta come il limite da violare per dare forma a un’inedita possibilità di trasformazione radicale dei rapporti sociali. In fondo è ciò che accade ai protagonisti di Interstellar, il film diretto da Christopher Nolan. Nella compresenza di passato, presente e futuro non c’è la nichilistica fine della storia esemplificata dall’apocalisse ambientale della Terra, né l’impossibilità di trasformare la realtà dopo averla interpretata, rifugiandosi in simulacri di zone temporaneamente autonome, bensì il principio di realtà indispensabile per avviare quel movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti.
Questo testo è stato pubblicato sul manifesto il 1 settembre 2018 e su EuroNomade.
Il rifiuto ostinato di darsi per vinti – 20 giugno 2018
Alcune volte per capire la logica combinatoria di un libro frammentario occorre partire dalla fine, cioè dagli ultimi scritti che lo compongono. Già, perché Mark Fisher aveva uno stile enunciativo frammentario e sincopato, al pari della musica – dall’ambient alla techno, al Britpop, all’elettronica, ma questo è un campo infido perché sconosciuto per chi scrive – che amava e che costituisce la colonna sonora della sua produzione teorica. E i testi dai quali bisogna prendere le mosse per comprendere la tensione filosofica, politica che anima questo Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti (minimum fax, pp. 315, € 18, traduzione di Vincenzo Perna) riguardano la presentazione di un video girato da un collettivo di videomaker all blacks durante alcuni tumulti, nel lontano 1986. Presentazione avvenuta quando a Londra e in altre città inglese bruciavano ancora le carcasse delle automobili e i negozi dati alle fiamme durante i riots del 2011.
Mark Fisher si domanda quali siano gli elementi di continuità e discontinuità che intervengono tra le due rivolte separate da più di trent’anni di distanza. Sottolinea come le dichiarazioni degli esponenti politici siano simili e in un accorto cut and paste emerge il fatto che le parole usate nel 1986 sono più o meno le stesse di quelle che i parlamentari tory (ma anche qualche laburista) recitano come un rosario esorcizzante le rivolte nel 2011. Lo stesso riguarda l’atteggiamento dei media, che giudicano, in entrambi i casi, inizialmente i rivoltosi come feccia, quasi animali per le distruzioni di automobili e negozi. Con una mossa a suo modo geniale Fisher trova la via d’uscita da questo déjà vu mediatico e argomentativo nelle parole di Paul Gilroy, studioso postcoloniale, anch’egli una delle voci più interessanti della new left inglese.
La Generazione di trent’anni prima che si era scagliata contro l’Inghilterra di Margaret Thatcher è stata cooptata da corporation e establishment culturale come un piccolo esercito di consulenti complici di una radicale e liberistica privatizzazione del discorso pubblico. Sono diventati complici dell’ordine sociale e politico che contestavano in gioventù. Le rivolte del 2011 non vedono, infatti, nessuna discesa in campo dell’intellettualità diffusa inglese. Esplodono e non lasciano traccia se non carcasse di automobili incendiate. Questa la vera differenza, afferma Paul Gilroy. Per Mark Fisher è la conferma non solo dell’egemonia del «realismo capitalista», il testo pubblicato da Nero Edizioni in Italia e che ha fatto conoscere a suo tempo questo intellettuale radical fuori dall’Inghilterra [⇒ qui], ma anche di un passato che incombe sul presente, negando ogni possibilità di futuro.
Spettri della mia vita è un collage sui fantasmi del passato e la nostalgia – gli anni Sessanta, Settanta sovversivi e culturalmente creativi, insieme al rimpianto per la sicurezza sociale garantita dal welfare state è rimpianta; ma è anche un volume su come tale nostalgia possa costituire un blocco nella riflessione teorica nonché politica sul presente.
Gli anni Sessanta, Settanta e il welfare rappresentano un’epoca di esperienze scandite da razzismo istituzionale, grigie forme di vita e un uso dei diritti sociali di cittadinanza per scongiurare la rivoluzione. Meglio di niente, però, ricordando che prima dell’edonismo liberista quel mondo era stato scalzato via da quella rivoluzione mondiale che era stato il Sessantotto.
Come nel precedente The Weird and the Eerie [⇒ qui] Fisher lavora sull’ambivalenza di alcuni sentimenti collettivi. Lì era il perturbante, qui la nostalgia per un passato mitizzato, «inventato» e presentato come una sorta di età dell’oro, rimuovendo così le sue asperità e la violenza esercita dal potere costituito. L’autore lo scrive chiaramente: la nostalgia è un sentimento reazionario. Lo fa chiamando a raccolta alcuni autori molto amati, Friederic Jameson e Jacques Derrida, in particolar modo le analisi sulla modalità nostalgica del marxista e critico del postmoderno statunitense e il mimetismo del filosofo francese emergente nella tematica dell’hauntology, qui miscela di ontologia e constatazione dell’irreversibile tempo spezzato della postmodernità, dove il «non più» e il «non ancora» vengono entrambi sacrificati sull’altare di un eterno presente.
Già, il tempo. Fisher lo considera categoria colonizzata dal potere. Nella successione passato-presente-futuro quello che viene negato è il futuro, proiettando così all’infinito, citando un saggio di Franco Berardi Bifo, il presente neoliberista. Dunque occorre riprendersi il futuro, la possibilità di immaginare una rottura dell’ordine costituito. Non viviamo però in un interregno à la Gramsci, dove il vecchio muore e il nuovo non riesce a nascere. Ciò che viene esperito è la ripetizione del sempre uguale e delle oasi di sosta, zone temporaneamente autonome dove i nostalgici evocano un passato tuttavia mai esistito.
Il passato e il futuro sono dunque gli spettri del pensiero critico inglese. Il marxismo, così come il comunismo sono stati certo sconfitti, ma i loro spettri continuano ad aggirarsi nelle vite, alludendo sempre a un nuovo assalto al cielo che non costruisca, a differenza di quanto accaduto nel Novecento, prigioni a cielo aperto, come sono state molte delle società del socialismo reale. Prospettiva assente in questo libro.
Attorno a tali nodi si dipanano e si sono aggrovigliati gli ultimi anni della vita di Fisher. Lucidamente amare sono le pagine dedicata alla nostalgia, dimensione sì reazionaria, ma anche sentimento che può essere dirottato in una direzione ostinatamente contraria al governo neoliberista della vita. C’è, infatti, dentro la nostalgia e nel rimpianto del passato un ambivalente rifiuto di darsi per vinti. Ciò che dovrebbe ossessionarci non è il «non più» della socialdemocrazia, ma il «non ancora» del futuro che ci aspetta. Qui si dà dunque politica, qui si dà conflitto. Chissà cosa ne avrebbe pensato Mark Fisher di questo approdo teorico.
C’è anche un’altra chiave di lettura possibile del libro. Quella che lo vede composto come fosse una cronaca della scena culturale, cinematografica, televisiva e musicale inglese. Vi è anche questo, è indubbio. Fisher ricostruisce la produzione musicale, l’intreccio tra underground e industria discografica, dove i primi sono stati sempre la leva senza la quale non ci sarebbe stata né innovazione culturale né sociale. Così come sono godibili le pagine dedicate alla serie inglese del Doctor Who o le serie tratte da noir decisamente politici come quelli della serie Red Riding Quartet di David Peace.
Belle sono le pagine sui film di fantascienza ingenui dal punto di vista degli effetti speciali – e comunque sottilmente caustici e critici verso la cultura imperiale del vecchio e giustamente scomparso impero del Regno Unito – della serie del dottor Quatermass; o quelli ben più recenti e a budget e casting internazionale di Christopher Nolan Memento e Inception, pellicole che hanno ognuna a suo modo indagato gli effetti stranianti e socialmente darwiniani del tempo spezzato nel neoliberismo.
Mark Fisher ha un altro merito che va ricordato. Non ha mai sottaciuto alcuni elementi ricorrenti nella contemporanea vita associata, spesso ignorati nel pensiero critico. La depressione, l’assunzione di psicofarmaci come se fossero coca-cola per tenere a bada il male di vivere. Il suo è stato un implicito invito a riflettere sul fatto che la politica – compresa quella radicale e sovversiva – non fornisca risposte esaustive al male di vivere divenuto fattore costitutivo, dopo lo scippo del futuro, di una società dove la precarietà non è solo lavorativa ma anche esistenziale. La precarietà è allora un dispositivo psicopolitico che inibisce ogni desiderio di cambiare la propria vita. Un tema che merita essere ripreso e articolato per scongiurare che il comunismo e la rivoluzione siano ridotti a misera teologia politica metafisica. Fisher ha documentato, scritto, con lucidità e rigore la depressione. Lo ha fatto fino alla sua fine, quando ha deciso di suicidarsi. La sua morte è stata una perdita indubitabilmente per tutti coloro che pensano, lavorano, agiscono, scrivono per dare forma e sostanza a quel necessario e rinnovato assalto al cielo, senza il quale c’è solo l’eterno ritorno del sempre eguale.
Questo testo è stato pubblicato sul manifesto del 20 giugno 2019 e su EuroNomade.