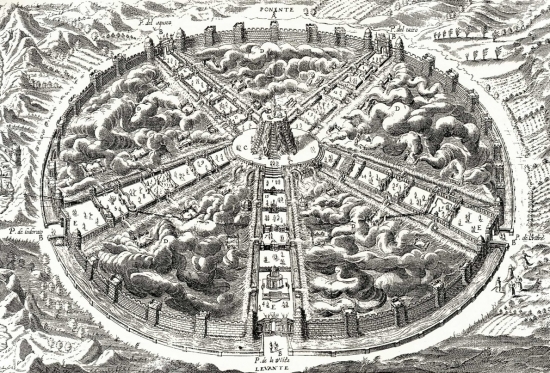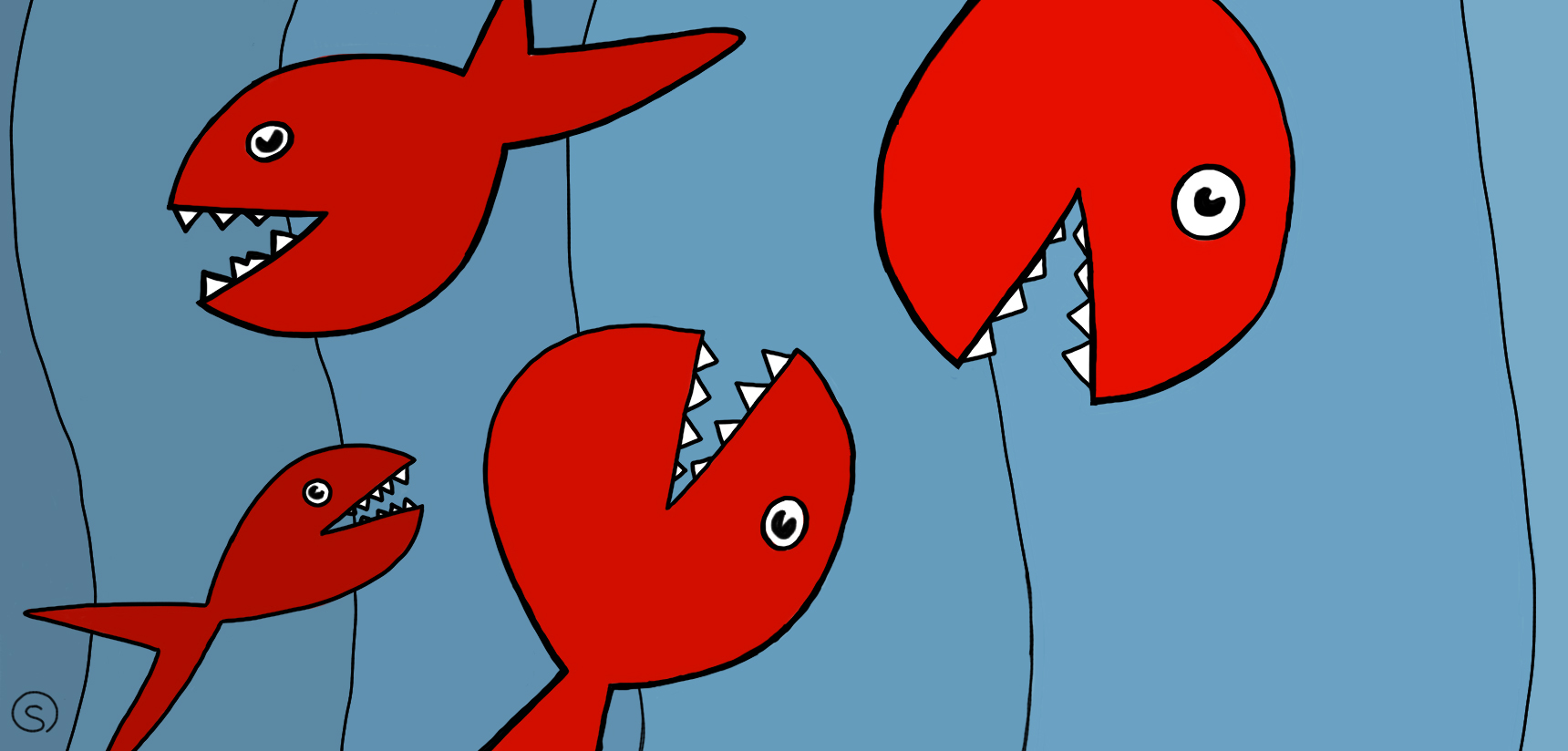di COSTANZA MARGIOTTA [Français]
Il Belgio e altri Stati entrano in “Guerra” contro il diritto dei cittadini europei a risiedere liberamente nel territorio dell’Unione Europea.
1. Il nome di Silvia Guerra è fra quelli destinati a rimanere celebri per gli studi e le pratiche relativi alla cittadinanza europea. Più di un quarantennio fa un’altra cittadina italiana – portava anch’ella il cognome Guerra – aveva dato il nome all’intestazione di una delle prime sentenze della Corte di giustizia europea (C-6/67) che ad oggetto avevano la libera circolazione dei lavoratori dei paesi membri dell’allora Comunità Economica Europea e il loro diritto alla non discriminazione in base alla nazionalità in materia di “vantaggi sociali”. Agli esordi delle Comunità Europee l’abolizione delle discriminazioni in materia economico-sociale è stata opera soprattutto dei lavoratori migranti. Non è un caso che le intestazioni delle prime sentenze della Corte di Giustizia europea in materia di discriminazione in virtù della nazionalità riportino cognomi italiani, a dimostrazione del ruolo dell’emigrazione italiana nella storia della rivendicazione dei diritti connessi alla libertà di movimento nei primi anni di vita della CEE. A distanza di circa mezzo secolo dai primi passi mossi in forma embrionale dalla cittadinanza europea (istituita poi nel 1992 con il Trattato di Maastricht), i profili di questo istituto sembravano ormai riguardare solo in minima parte i cittadini degli Stati membri: i ricorrenti oggetto delle ultime pronunce sul rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea erano principalmente cittadini provenienti da Stati non europei.
Dovrebbe risultare non comune allora la storia di Silvia Guerra, cittadina italiana, e quindi europea, espulsa a metà dicembre dal Belgio perché considerata “un peso indebito” per lo Stato sociale belga: siamo ormai abituati, nello spazio europeo, ad associare le espulsioni a immigrati non comunitari. Storie simili a quelle della Guerra accadono ogni giorno in Belgio come altrove, senza far rumore, a migranti provenienti da paesi extra-comunitari.
A meno di non prendere definitivamente atto che le lotte per i diritti possono e si devono muovere sul terreno della cittadinanza europea, la storia dell’italiana in Belgio rischia di non rimanere un caso isolato, ma anzi di diventare la norma(lità) per chi non dimostri di avere un reddito sufficiente al sostentamento proprio e della eventuale famiglia.
Perché la cittadinanza europea, e il caso Guerra in particolare, iniziano a guadagnare l’attenzione della stampa mainstream italiana? Cosa stupisce dell’espulsione della Guerra dal Belgio (ma nel corso del 2013 sono stati circa 2500 i cittadini europei espulsi dal Belgio perché “economicamente non indipendenti”)? La risposta è a prima vista semplice: la messa in discussione del progetto di integrazione europea da parte dei suoi stessi fondatori. In più ciò che deve avere richiamato l’attenzione della nostra stampa è il termine espulsione associato a quello di una cittadina italiana: sicuramente fa paura che sia una cittadina europea occidentale la persona espulsa da uno Stato membro dell’UE e per di più da chi è percepito come simile a lei, altri cittadini europei occidentali. Preoccupa perché è qualcosa che sentiamo vicino, che potrebbe succedere a chiunque abbia già esercitato il diritto di, o stia per, circolare liberamente nello spazio europeo: precario, disoccupato o semplicemente mosso dal desiderio di muoversi sfruttando quelle che sino a ieri erano le opportunità che la cittadinanza europea sembrava offrire.
Sta di fatto che grazie alla storia di Silvia Guerra siamo venuti a conoscenza dei passi indietro che rischia di fare il giovane istituto della cittadinanza europea per gli stessi cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea “occidentale”.
Non solo il Belgio si sta attrezzando per dare un giro di vite all’erogazione di servizi di welfare per i cittadini comunitari, ma lo stesso Cameron in Gran Bretagna tenta di tutelare le prestazioni sociali da “eventuali abusi” da parte dei cittadini comunitari. Londra, Parigi, Bruxelles e Berlino tentano di allinearsi nel ri-chiudere i confini intraeuropei, affermando che la libertà di movimento non deve più essere considerata un principio assoluto da associare alla cittadinanza europea, sebbene sia basilare. L’idea è quella di tornare a una cittadinanza basata sul reddito, permettendo la circolazione solo a chi dichiara un reddito vicino a quello medio europeo e sia in grado di mantenersi.
In un contesto in cui – visti gli effetti della crisi – sta cambiando radicalmente la composizione, la scala e il significato dei flussi migratori interni allo spazio europeo, le prime espulsioni di cittadini europei occidentali, al di là delle ripercussioni immediate sui singoli individui, configurano un dispositivo di governo differenziale dei migranti comunitari che non può non avere riflessi sull’insieme dei migranti che attraversano lo spazio europeo. In altre parole, pratiche di governo, che istituzionalizzano nei fatti una cittadinanza differenziale fra gli stessi cittadini dell’Ue, contribuiscono ad accrescere il più generale quadro di precarizzazione della vita e del lavoro, confermando nella loro condizione di subordinazione dei migranti nella loro complessità.
L’Europa tornerebbe a essere uno spazio di libertà per i capitali, le multinazionali, le merci, i servizi, i ricchi ma non più per quei soggetti che spaventano: i lavoratori precari, i disoccupati, i migranti comunitari tout court o i migranti extraeuropei. Di fronte ai numeri delle migrazioni intraeuropee (nel 2013 i cittadini europei residenti in uno Stato membro diverso dal proprio sono quasi 14 milioni; solo in Gran Bretagna gli italiani sono mezzo milione e l’Ambasciata italiana si è vista costretta ad aprire uno sportello “Primo approdo” per i nuovi arrivi) che crescono ogni giorno – visti gli sviluppi della crisi economica in alcuni Stati dell’Unione e la fine (fissata legalmente all’inizio del 2014) del periodo transitorio durante il quale i cittadini di Bulgaria e Romania hanno subito una serie di restrizioni all’esercizio del diritto di libera circolazione –, alcuni Stati europei stanno adottando una serie di provvedimenti “anti-europeisti”. Nel proclamato “Anno europeo dei cittadini”, il 2013, i governi di Germania, Austria, Gran Bretagna e Olanda hanno proposto, con una richiesta formale a Bruxelles, che fossero modificate le norme in materia di libera circolazione e di accesso al welfare per i cittadini europei. Malgrado non sia in atto nessuna “aggressione” ai sistemi sociali di tali Stati da parte di cittadini comunitari alla ricerca di un migliore welfare, questi Stati stanno facendo pressione sull’Unione Europea affinché vengano ristabiliti i tradizionali confini per proteggere “i diritti e gli interessi dei nativi”.
Si tratta di una presa di posizione – come quella recentissima di Germania e Gran Bretagna che vogliono porre “nuove” restrizioni alla libera circolazione dei cittadini romeni e bulgari che invece, dal primo gennaio, avrebbero finalmente potuto esercitare anche loro, come il resto dei cittadini europei, il diritto alla libera circolazione – che snatura radicalmente la cittadinanza europea, nella misura in cui storicamente, fino ad ora, essa ha fatto sentire i suoi effetti essenzialmente nell’ambito di ordinamenti diversi da quello di provenienza, parificando il cittadino europeo ai nativi nel godimento dei diritti sociali ed economici (e civili).
Ora, invece, si va in direzione contraria: nel timore di un, ancora ipotetico e non verificato, “turismo sociale”, si reintroducono discriminazioni su base nazionale.
Lo spettro di “scansafatiche” interessati al godimento dei benefici sociali degli Stati ricchi sta avendo forti ricadute sulle decisioni governative in materia di flussi migratori intraeuropei. Va comunque considerato che non è la prima volta che viene indebolito il concetto di cittadinanza europea e messo un freno al suo eventuale sviluppo verso l’autonomia, solo che ora ci stupisce e attira l’attenzione perché riguarda i cittadini provenienti dai paesi occidentali dell’UE: italiani, spagnoli, portoghesi, greci, ovvero i cittadini provenienti dalle nazioni più colpite dalla crisi dell’eurozona. “Pigs here” ha titolato per l’appunto il quotidiano britannico Sun che suona come in Inghilterra “sono arrivati i maiali”: a dimostrazione, fra l’altro e se ce ne fosse bisogno, che il razzismo cambia continuamente forma, contorni, impatto, in base ai cambiamenti politici ed economici.
Non è la prima volta, si è detto: già in occasione degli ultimi allargamenti dell’Unione verso l’Europa centrale e orientale (2004, 2007 e 2013), infatti, era stato previsto un “periodo di transizione” (da due a sette anni) in cui per i cittadini dei nuovi Stati membri era stata sospesa l’applicazione del contenuto più rilevante e significativo della cittadinanza europea, cioè la libertà di circolazione. In sostanza, all’atto di adesione ai “vecchi” Stati membri non è stato imposto l’obbligo di accettare le conseguenze dell’automatica estensione della cittadinanza europea ai cittadini dei “nuovi” Stati membri: libertà di circolazione e di soggiorno per i nuovi cittadini in tutta l’UE. Ciò ha avuto gravi conseguenze dirette sul concetto di cittadinanza europea: i “migranti” dai nuovi Paesi membri, pur essendo cittadini europei a tutti gli effetti (con relativo diritto di voto alle elezioni europee) sono stati trattati a lungo (e ciò sembra valere ancora appunto per i romeni, i bulgari e i croati) come extracomunitari dai meccanismi di controllo delle migrazioni in essere negli Stati membri. Temendo la destabilizzazione dei mercati del lavoro nei “vecchi” Stati con l’arrivo dei “nuovi” migranti, si è invocata la clausola limitativa dell’articolo del Trattato sul diritto di libera circolazione e soggiorno, sancendo, per la prima volta, la stratificazione e la gerarchizzazione dei diritti all’interno dello status di cittadino europeo. In questo modo si è posta una significativa ipoteca sulla prospettiva di un’autonoma cittadinanza europea: se la libertà di movimento è il primo tra i diritti che discendono dal nuovo status, le scelte politiche fatte in occasione degli ultimi allargamenti hanno seriamente messo in crisi la forza e la coerenza del progetto. Infatti, le diverse situazioni soggettive scompongono continuamente l’unità della cittadinanza e finiscono per conferire a quella europea forme a geometria variabile che segnano gradi diversi di inclusione, distruggendo l’unificazione del soggetto di diritto faticosamente realizzata.
Le recenti scelte politiche di alcuni Stati europei, che riguardano oggi non più solo la libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini degli ultimi Stati entrati a far parte dell’Unione, stanno tentando di modificare la direzione che aveva preso il processo di autonomizzazione della cittadinanza europea dalle cittadinanze nazionali.
A questi rischi che il sorgere di politiche squisitamente sovraniste pongono al processo di giuridificazione della cittadinanza europea, si potrebbero aggiungere anche conflitti (o comunque processi di “sconnessione”) tra gli stessi poteri europei, con particolare riferimento a quello giudiziario, visto sia la fragilità dell’integrazione attraverso il diritto in questo momento, sia il ruolo costituente che su questa materia ha esercitato negli anni passati la Corte di Giustizia europea.
A meno di non voler intendere che lo scontro si gioca tutto sul terreno europeo, è necessario allora provare a capire i punti di impasse di questo processo per immaginare nuovi contenuti e direzioni per la cittadinanza europea affinché retoriche di ritorno alle cittadinanze nazionali non abbiano “cittadinanza”.
2. A oggi credo si possa affermare che, nel caso in cui venisse bocciato il ricorso fatto alle autorità belghe competenti relativamente al decreto di espulsione dal Belgio, Silvia Guerra avrebbe comunque delle chance di far valere i suoi diritti con un nuovo ricorso che faccia riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che, come è noto, ha svolto un ruolo che può essere definito, in questa materia, costituente. È a questa giurisprudenza che bisogna fare, infatti, riferimento per capire, nonostante le passate e recenti scelte conservatrici delle istituzioni politiche europee, a che punto è il processo europeo di istituzionalizzazione della cittadinanza.
È vero che il paventato pericolo di forme di “turismo sociale” indusse, a Maastricht, a evitare il riconoscimento di un “incondizionato” diritto di libera circolazione e di soggiorno per tutti i cittadini europei. Inizialmente, il riconoscimento del diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri sulla base del solo presupposto della cittadinanza non fu, infatti, considerato norma dotata di effetto diretto, e come tale invocabile di fronte ai giudici nazionali, perché tale diritto non era formulato in termini assoluti ma “fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso”. In effetti nel Trattato di Maastricht la libertà di circolazione e di soggiorno per i cittadini europei non prescindeva ancora completamente da qualsivoglia profilo economico, cioè dalla connessione con lo svolgimento di un’attività lavorativa o, per i cosiddetti inattivi, dall’assicurazione che la loro presenza non sarebbe diventata un onere per le finanze dello Stato ospitante.
La Corte, invece, ha svincolato lentamente il diritto di libera circolazione e di soggiorno, spettante al solo cittadino europeo “economicamente indipendente” – che disponga cioè di risorse sufficienti e di un’assicurazione medica –, dai riferimenti di ordine economico, elevando tale diritto a categoria inerente allo status di cittadino europeo in quanto tale e facendo sì che il lavoro salariato stabile non restasse la principale modalità di accesso alla circolazione nello spazio europeo.
Secondo la Corte aver riconosciuto il diritto a muoversi liberamente nel territorio dell’UE in un’unica disposizione relativa ai diritti dei cittadini europei e non più dei cittadini degli Stati membri a vario titolo considerati (lavoratori, prestatori di servizi, familiari, studenti, pensionati, ecc.) ha fatto acquisire a tale diritto una valenza nuova, non più strettamente economica ma politica, perché non è più rilevante il motivo per cui un cittadino decide di avvalersi della libertà di circolazione a parte il suo nuovo status giuridico. La ratio del nuovo statuto non può più, quindi, venir “mortificata in logiche di bilancio”, degne di tutela ma che non devono più prevalere sui diritti del cittadino. La subordinazione dell’esercizio del diritto di soggiorno dei cittadini europei agli interessi (economici) degli Stati membri deve, infatti, rispettare il principio di ragionevolezza e di proporzionalità, altrimenti si può dare lesione dei diritti di cittadinanza europea. Secondo la Corte può pure essere illegittimo imporre a uno Stato ospitante un “onore eccessivo” per le sue finanze pubbliche, ma questo non può valere sempre, e non certo “un mero onere” (Grzelcyzyk C-184/99 del 2001). In altre parole, fermo restando la legittimità di salvaguardare le finanze pubbliche degli Stati, per la Corte rendere efficace uno dei principi fondamentali della Comunità, la libera circolazione delle persone, significava ritenere accettabili degli oneri ragionevoli.
La Corte ha precisato che è necessario verificare, di volta in volta, tenendo conto delle situazioni personali, la legittimità del criterio che uno Stato adotta per escludere dei “cittadini europei” dalla parità di trattamento (sussidi o benefici sociali: prestazioni di assistenza sociale, sussidi agli studenti, benefici di disoccupazione ecc.). Essa ha anche ammesso (Grzelczyk C-184/99) che l’esistenza di un minimo di “solidarietà finanziaria” transnazionale tra gli Stati membri, necessaria al processo di integrazione europea, fa sì che uno Stato ospitante non possa negare sulla sola base della nazionalità una prestazione sociale al cittadino straniero legittimamente residente.
Per riassumere: dall’istituzionalizzazione della cittadinanza europea non deriva, almeno negli ultimi dieci anni (2002-2012), un diritto “incondizionato” di soggiorno e di parità di trattamento per tutti, a causa del divieto di pretendere dagli Stati ospitanti oneri non ragionevoli per garantire assistenza sociale ai cittadini comunitari. Ma gli Stati membri, proprio a causa dell’istituzionalizzazione della cittadinanza europea, sono costretti a giustificare le misure discriminatorie che adottano nei confronti dei cittadini europei.
Non a caso con un’altra pronuncia in materia di cittadinanza la Corte ha stabilito il principio secondo cui un cittadino europeo, qualsiasi siano le sue risorse economiche, “durante il suo soggiorno lecito” (Trojani C-456/02 del 2004), “non può non fruire del principio fondamentale relativo alla parità di trattamento”. Il “potere di allontanamento” di uno Stato, “al di fuori delle decisioni fondate sull’ordine, sulla sicurezza e sulla sanità pubbliche” – che senz’altro restano domini riservati non da poco –, è condizionato, perché spetta al cittadino dell’Unione il diritto di contestare l’allontanamento in quanto la libertà di circolazione e di soggiorno non può essere limitata da disposizioni nazionali che condizionino il soggiorno all’accertamento dell’indipendenza economica.
Perciò giuridicamente appare illecito l’allontanamento dal Belgio di Silvia Guerra, che è residente legalmente in Belgio dal 2010 e dal 2012 ha un contratto chiamato “articolo 60” che, più che un vero e proprio aiuto sociale, è un contratto di re-inserzione nel mondo del lavoro, erogato in parte dal CPAS (Centro pubblico di azione sociale) e in parte dal servizio a cui è “prestato” il contrattualizzato CPAS, perché difficilmente, alla luce di quanto appena detto, l’”Articolo 60” può essere considerato, tenendo conto del caso specifico, un onere irragionevole per lo Stato sociale belga.
3. Nonostante la sorte, ci auguriamo felice, della Guerra la questione è se la tenuta dei sistemi nazionali di welfare possa restare il limite invalicabile alla liberalizzazione totale della circolazione e del soggiorno per tutti i cittadini europei. L’estensione dei beneficiari di tali libertà, dovuta al riconoscimento della cittadinanza europea, ha certamente determinato la “de-nazionalizzazione” della cittadinanza sociale, ma non ha comportato la cosiddetta “europeizzazione” della stessa. Questo anche perché il processo di de-nazionalizzazione della cittadinanza sociale si è esaurito proprio nel momento in cui il carattere sociale della cittadinanza in Europa è entrato definitivamente in crisi. Se a metà del secolo scorso nelle democrazie europee la platea dei cittadini dovette necessariamente allargarsi per includere i lavoratori, con l’istituzionalizzazione della cittadinanza europea i diritti comunitari, che erano collegati allo status di lavoratore dal 1957, devono necessariamente essere estesi anche al cittadino tout court.
Bisogna allora e innanzitutto ripensare il soggetto su cui è stata disegnata la cittadinanza europea. Il progetto di cittadinanza europea (così come le cittadinanze nazionali europee del secondo dopoguerra), infatti, è ancora imperniato sull’individuo maschio, bianco, lavoratore salariato a tempo indeterminato. Quella figura appare ormai inattuale e sarebbe inutile riproporre la ridefinizione dei sistemi di diritti e di welfare, a livello europeo, secondo questo modello. La crisi del capitalismo contemporaneo, la precarizzazione del lavoro, le soggettività emergenti da quella che può essere definita una nuova generazione europea “mobile”, i cambiamenti delle caratteristiche delle migrazioni, le trasformazioni delle strutture familiari e dei rapporti fra i generi impongono di avviare in Europa, già culla dello Stato sociale tradizionale, un progetto di nuovo welfare per l’affermazione dei diritti sociali che vadano oltre quelli pensati sulla figura del lavoratore tradizionale. Ma questo può avvenire solo legittimando definitivamente l’accesso transfrontaliero a tali diritti per i soggetti economicamente inattivi, delegittimando di conseguenza la portata limitativa della condizione di “autosufficienza economica”. Si deve, in poche parole, riconoscere un diritto incondizionato di circolare e soggiornare sul territorio dell’Unione (le caratteristiche fondamentali della cittadinanza europea) per chiunque sia titolare dello status di cittadino europeo. Potranno così essere pensate e create ex novo istituzioni in grado di riconoscere e di implementare i diritti anche per quei soggetti oggi temuti, quali i lavoratori precari, i disoccupati o i migranti extraeuropei.
Tuttavia l’attuale atteggiamento di alcuni Stati membri dell’UE va esattamente in direzione opposta, così che, di fronte all’odierna profonda e generale crisi economica, sono i fondamenti stessi dell’Unione a diventare incerti: la solidarietà fra gli Stati vacilla e questo rischia di privare la cittadinanza e il progetto europei di ogni significato.
La questione da porsi è se, nell’attuale situazione, ci si possa aspettare un rilancio dell’Unione da parte delle istituzioni esistenti (e in tal caso, da quali) o se il progetto di Europa non debba invece nutrirsi anche di un’azione dal basso. Quest’ultima prospettiva è allo stato attuale l’unica interessante, specie considerando che il lavoro della Corte di giustizia europea ha sempre risentito del clima e degli orientamenti sociali e politici in cui sviluppa la sua azione.
Agli occhi della maggioranza della popolazione europea, e in particolare dei cittadini dei paesi maggiormente colpiti dalla crisi economica, l’Europa, infatti, sta finendo per essere identificata solo con le politiche di austerity, che stanno determinando lo smantellamento sistematico dei diritti sociali e un loro livellamento verso il basso. In tale contesto la cittadinanza assume un carattere “punitivo” più che di emancipazione. Al contrario, la difesa e la rivendicazione dei diritti dei cittadini devono essere promosse a livello europeo: la dimensione europea è, infatti, il limite contro il quale si infrange qualsiasi battaglia, intrapresa a livello nazionale, per i diritti fondamentali e contro la gestione (catastrofica) della crisi. A fronte di una cabina di regia europea, retoriche, mobilitazioni e politiche di rivendicazioni dei diritti che si muovono su scala nazionale hanno poco senso, perché i poteri di decisione che influiscono sui diritti individuali e sulle relazioni sociali agiscono a livello comunitario. In questo senso, appare indispensabile porsi sullo stesso livello di questi dispositivi decisionali costruendo (contro)dispositivi politici capaci, anzitutto, di farsi carico della eterogeneità delle condizioni socio-economiche e, in secondo luogo, di promuovere un progetto mirante a produrre un linguaggio comune, capace di mettere al centro proprio il paradigma della cittadinanza europea
Sta ora a noi divenire cittadini europei. Il destino della cittadinanza europea non è ancora scritto, dobbiamo dimostrare di sapere costruire una cittadinanza comune e autonoma che trascenda i confini per attingere all’universale. Se il futuro è ancora incerto, solo assumendo tale istituto come azione, come pratica di soggettivazione, è possibile mettere in discussione la cittadinanza europea come status, contestandone sia il carattere di esclusione sia quello di “inclusività differenziata”, non cadendo nella falsa alternativa fra l’Europa com’è e i populismi che la rifiutano.