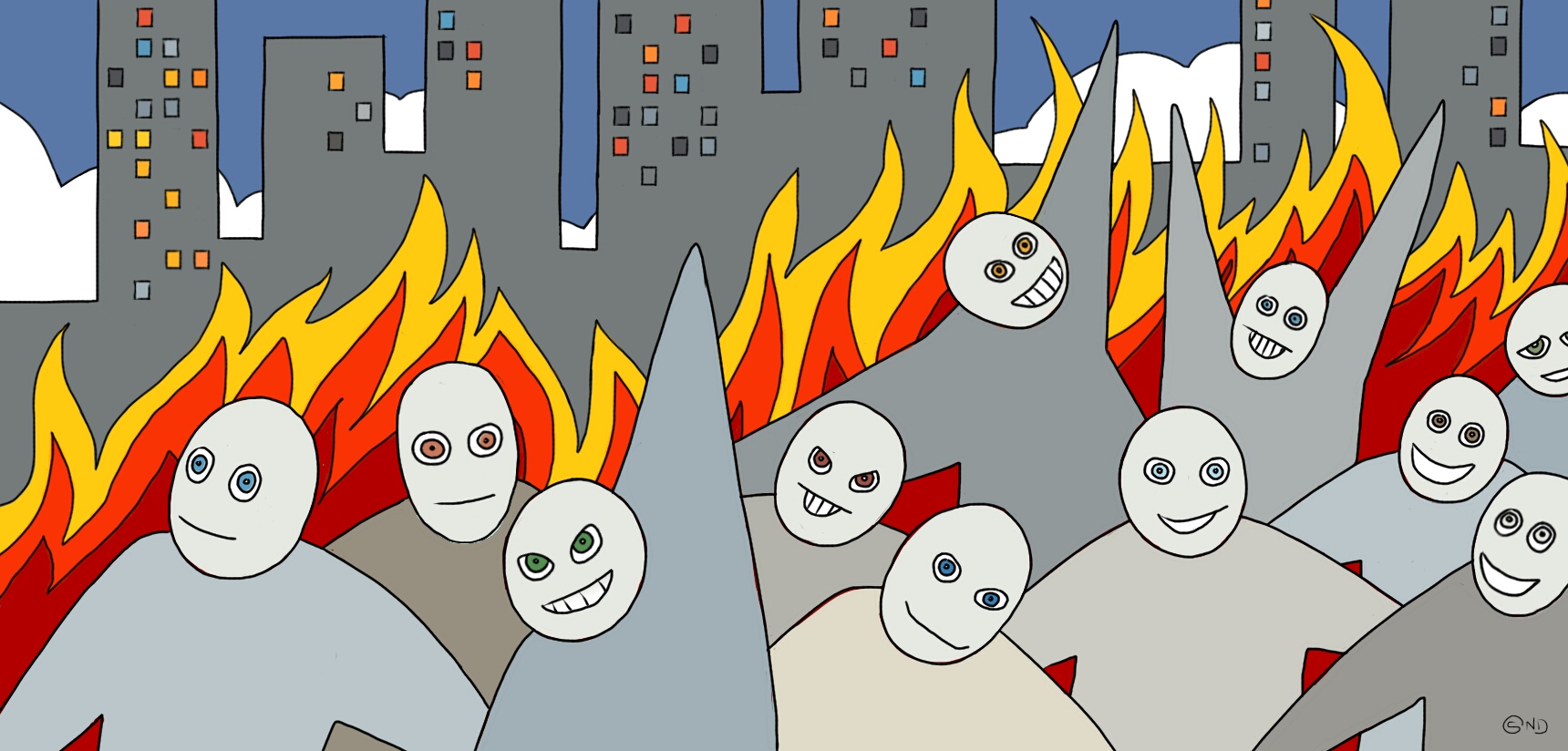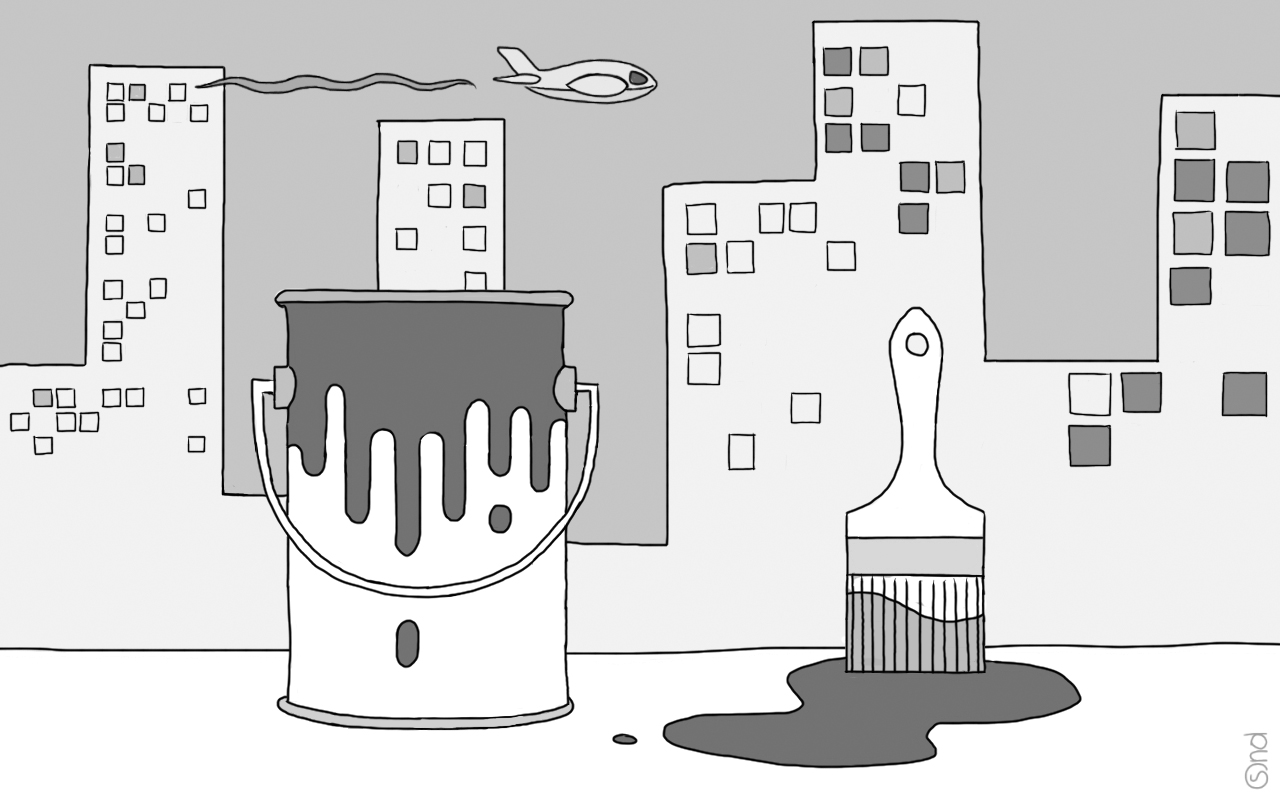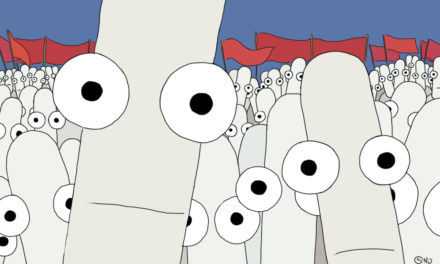Di MARCO BASCETTA
Viviamo oggi in un mondo ben diverso, a tutti gli effetti un «altro mondo», da quello in cui prese corpo e si sviluppò il grande movimento che dal 1999 al 2003 scese nelle piazze di molti paesi contro la globalizzazione neoliberista e le sue filiazioni belliche.
Ma di certo non si tratta di quell’«altro mondo possibile» che fu coralmente evocato dal «movimento dei movimenti» in quegli anni, bensì di un nuovo assetto, più articolato e meno afferrabile, del «mondo impossibile» centrato sull’accumulazione del capitale e sullo sfondamento sistematico di qualsiasi ostacolo si opponga al suo pieno dispiegarsi. Inutile elencare, molti lo hanno già fatto, i passaggi e le molte profonde fratture che hanno segnato la storia del pianeta dal 2001 a oggi, (dall’11 settembre alla crisi economica e a quella dei debiti sovrani), e che misurano la grande distanza che ormai ci separa dalle giornate di Genova. Cosa resta, nonostante la lontananza, e cosa può ancora insegnarci quella straordinaria esperienza di mobilitazione?
Forse se ne è conservata, purtroppo, molto più la retorica che la sostanza. In primo luogo quello che potremmo definire una sorta di feticismo dei numeri, che condusse a una lettura ingenua dei reali rapporti di forze. Quel «voi siete 8 e noi miliardi» fino alla «marea» delle attuali mobilitazioni contro il G20 che vorrebbero l’immediata conversione della sproporzione numerica in un dato di potenza.
Non si dimentichi la sciagurata esaltazione mediatica della «seconda potenza mondiale» con cui fu battezzato (e ben presto sepolto) l’imponente e sconfitto movimento del 2003 contro la guerra. Questa idea che l’enorme numero degli sfruttati (simboleggiato dai cortei oceanici) finirà naturalmente per travolgere l’esiguo numero degli sfruttatori, che lo scandalo della crescente diseguaglianza imporrà necessariamente un’inversione di rotta nel modello economico e sociale, sta alla base di una narrazione che rifiuta di fare i conti con la relazione di violenza (difensiva e offensiva) nella quale il movimento tra Seattle e Genova si trovò profondamente e consapevolmente immerso.
Considerarlo ora esclusivamente nella veste di una vittima inerme della violenza di stato non è certo il modo migliore di rendergli giustizia. Bolzaneto e la Diaz furono una cosa infame e inaudita, ma non possono occupare l’intero campo della memoria e oscurare così la sfida radicale e lo scontro che i movimenti portarono con decisione nelle strade di Genova, come già era accaduto a Seattle e a Napoli. Non sarebbe questo un messaggio incoraggiante per i movimenti che occupano oggi la scena globale e che si trovano alle prese con analoghe relazioni di violenza.
A quella stagione di movimenti cui nonostante l’etichetta impropria e poi variamente corretta di «no global» non può imputarsi neanche la più vaga ombra di nazionalismo, va invece riconosciuto il merito di un felice superamento del vecchio schema internazionalista (che presupponeva quando non una dottrina e un’avanguardia, l’imperativo etico della solidarietà) a favore di un faticoso assemblearismo planetario e di una convergenza di temi e di forze, fragile e accidentato per la sua stessa complessità, ma dotato di una prospettiva di «rete» che da allora non si sarebbe più sostanzialmente persa.
Il perimetro globale dei movimenti fu tracciato in quel frangente e continua ad alimentare un tessuto di relazioni e di scambi, di intersezioni e contaminazioni che hanno profondamente trasformato la natura e l’autorappresentazione dei movimenti in tutto il mondo. A differenza delle stagioni di mobilitazione cui abbiamo assistito nell’ultimo ventennio, (dagli Usa alla Spagna, alla Turchia, all’America latina) il ciclo di lotte a cavallo del millennio tentò di produrre una sua originale forma politica; il social forum. Una convincente storia ragionata di questa «istituzione» non è stata ancora scritta.
Si trattò, per dirla con una formula, di travasare il «movimento dei movimenti» in una «assemblea delle assemblee». Ma dopo l’entusiasmo e l’azzardo degli esordi i social forum si trasformarono progressivamente in marginali tribune lottizzate da un ceto politico, più o meno informale, in rappresentanza di organizzazioni della cosiddetta «società civile». E, sul piano dell’efficacia politica, nella rappresentazione dell’«agire comunicativo», nel suo più splendido isolamento. Esito che comunque nulla toglie alla passione sperimentale che animò quel tentativo di organizzazione. «Filo rosso» è un’espressione spesso usata per indicare una sotterranea linea di continuità tra insorgenze rivoluzionarie.
Ma la sua origine è ben altra. Si trattava infatti di una sagola rossa intrecciata nei cordami della marina britannica onde individuare, a colpo sicuro, i relitti dei vascelli di sua maestà. In questa accezione non vi è dubbio che il filo rosso attraversi le giornate di Genova a indicare che quel relitto fa parte della nostra flotta. Ma anche i relitti non sono muti e appartengono a una storia di battaglie combattute. Quel che è certo, però, è che non ci si può più navigare.
Questo articolo è stato pubblicato su il manifesto il 20 luglio 2021. L’immagine di copertina è tratta da WikiCommons.