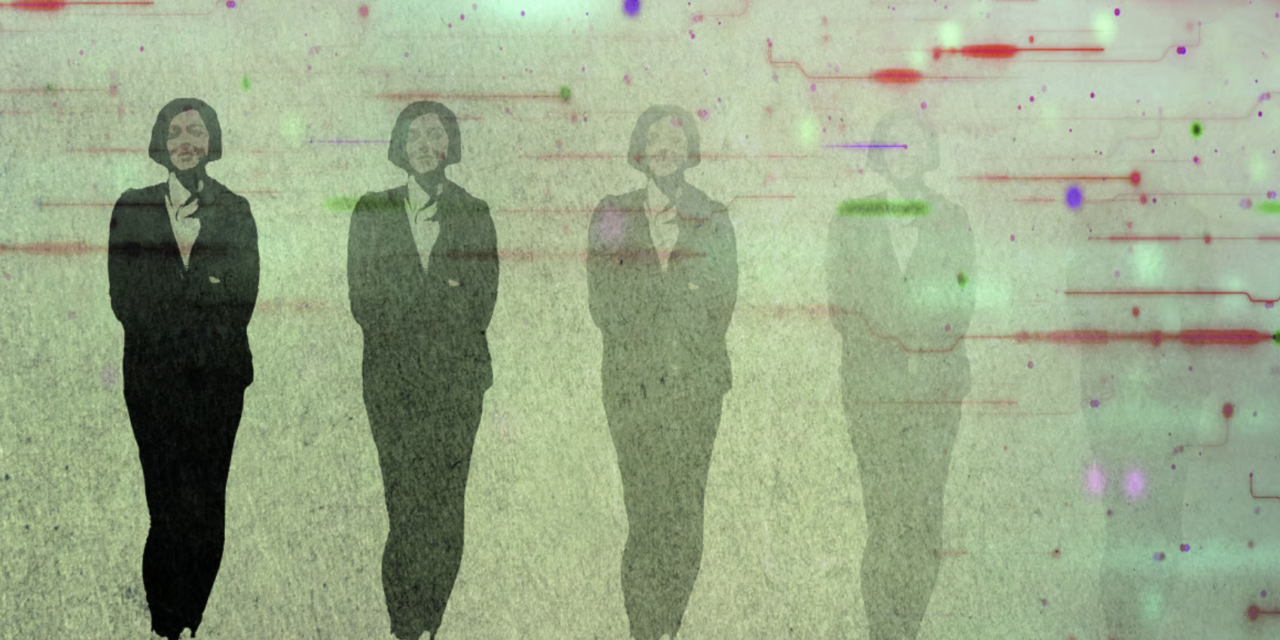Di ALISA DEL RE
Negli anni Settanta una larga parte del femminismo materialista aveva come parola d’ordine internazionale il «salario per il lavoro domestico» (diventato in seguito «contro il lavoro domestico»). Veniva svelato e messo in primo piano un lavoro gratuito attribuito essenzialmente alle donne e mistificato come lavoro d’amore. Quando questo slogan si materializzava in rivendicazioni precise, come la campagna per gli assegni famigliari o quella per una ridefinizione dei servizi sociali, assumeva i contorni di un attacco rivoluzionario alla spesa pubblica, chiedendone riqualificazioni in funzione del riconoscimento dello sfruttamento del lavoro riproduttivo. Non si parlava ancora di reddito, le richieste si articolavano attorno all’obiettivo operaista del «salario sociale».
In quegli anni in Italia, l’onda montante del femminismo ha dato impulso a forme di lotta atipiche, come l’entrata massiccia delle donne nel lavoro salariato, le battaglie per il divorzio, per la contraccezione sicura, per l’aborto, contemporaneamente a un rifiuto della domesticità del lavoro. Tutto ciò ha comportato un allargamento del processo di esternalizzazione di questo lavoro, sia con l’immissione nelle case di lavoro salariato preso dal mercato, sia con il costante aumento di lavoro – anche se non sufficiente rispetto alle aspettative – nei settori socializzati del lavoro riproduttivo. Il processo di socializzazione di parti di questo lavoro con la costituzione di servizi in quello che abbiamo chiamato Welfare State è stato tradotto in un mercato del lavoro con tutele scarsissime, come se il trasferimento dal privato delle case al pubblico (che nei due casi coinvolge in larga misura una popolazione femminile) comportasse il mantenimento della svalorizzazione di questo lavoro.
Dal punto di vista del rifiuto del lavoro domestico, oggi vediamo un aumento continuo di donne divorziate e separate che segna una rottura della sicurezza del patto riproduttivo. Il 41% delle nascite non avviene in regime matrimoniale e possiamo attribuire solo 1,24 figli a ogni donna cosa che, ovviamente, non garantisce il ricambio generazionale. La famiglia è cambiata perché le donne non hanno più visto in essa un’utilità per sé e con essa la percezione dell’importanza del lavoro riproduttivo gratuito e necessario alla vita.
Contemporaneamente, è iniziato un cammino irreversibile nell’emersione e nella visibilizzazione di lavori poco pagati, gratuiti, precari, con caratteristiche anomale rispetto al lavoro di fabbrica. Verificabili nella lettura delle trasformazioni del capitale che, partendo dal modo di sfruttamento arcaico del lavoro riproduttivo, lo allarga e allargherà a moltissime forme di fare lavoro (e fornire profitto) fino a quelle attuali – più inconsapevoli – degli stili di vita “moderni” quotidiani, molto ben descritti in molte pubblicazioni di Cristina Morini. Tutto ciò assieme all’emergere della consapevolezza, resa più acuta dalla recente pandemia, dell’importanza dei lavori essenziali e della necessità vitale del lavoro riproduttivo. Le analisi sulla complessità del lavoro riproduttivo hanno portato al ridimensionamento dell’obiettivo del salario, mentre si verificava di fatto, sul terreno delle lotte, la sua necessità incomprimibile come hanno provato a dimostrare gli scioperi transnazionali organizzati in questi anni da Non una di Meno.
Ma il lavoro riproduttivo non può essere preso in considerazione come un problema da risolvere solo per le donne. Se venisse caricato, per non so quale magia, sulle spalle degli uomini oppure equamente suddiviso tra i sessi, non cambierebbe nulla della sua funzione necessaria. La riproduzione della vita nella sua interezza e nella sua fragilità è il nucleo centrale della produzione di valore, che non si ha senza lavoro vivo e quindi senza lavoratori vivi, che non si può e non si deve avere con lavoratori interscambiabili, stanchi, irritati, denutriti, ecc.
Anche se pensiamo che la produzione del vivere sia lavoro, esso non può essere salariato proprio perché il salario è misura, mentre il lavoro riproduttivo è incommensurabile in quanto ha a che fare con la vita. È un lavoro necessario che implica relazione, uscita dalla solitudine, riconoscimento: è imprescindibile e irriducibile, anche se invisibilizzato. D’altronde è necessario segnalare che la riproduzione di sé (costituzione di capitale umano) è diventata l’obiettivo del capitale, come ci dimostra l’importanza percentuale del lavoro riproduttivo salariato nei servizi, in particolare in quelli alla persona, rispetto ai lavori produttivi di merci; e infine come il processo di estrazione di plusvalore nell’odierna organizzazione del lavoro si stia spostando dalla fabbrica direttamente nella vita quotidiana delle persone. La sussunzione dei requisiti del lavoro riproduttivo in una specie di femminilizzazione del lavoro fino ad arrivare alla produzione di valore all’interno della vita stessa giustificherebbe di per sé un reddito di base incondizionato, ma non basta: è necessaria un’organizzazione sociale della sopravvivenza, facendo uscire i servizi sociali dalla dipendenza dal lavoro salariato (Workfare) e incentivando servizi di qualità.
La valorizzazione del lavoro riproduttivo vuol dire concretamente costituire un reddito per vivere, un reddito individuale (non famigliare) incondizionato di autodeterminazione, organizzando una vita libera sia dalla gratuità della fatica sia dalla prestazione salariale. Ma perché questo abbia un senso concreto di liberazione è necessario provvedere all’ampliamento delle pratiche sociali di cura tornando al lavoro riproduttivo come centrale fondamento genetico della vita individuale e sociale, senza il quale non ci sarebbe sviluppo o produzione economica.
Questo articolo è stato pubblicato per il manifesto il 4 novembre 2023.