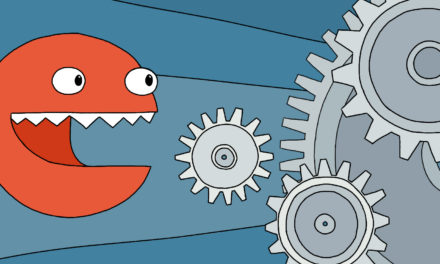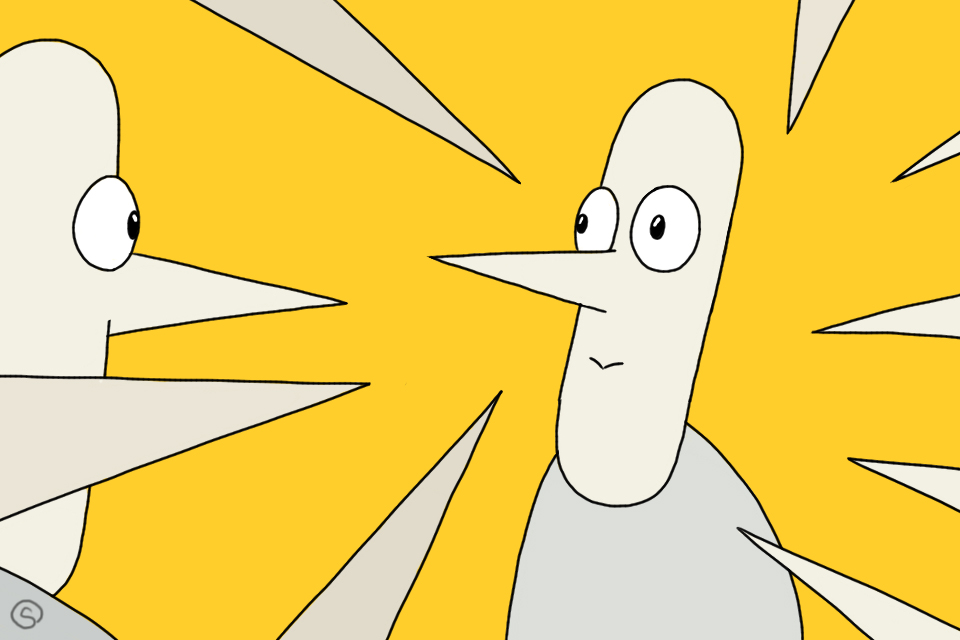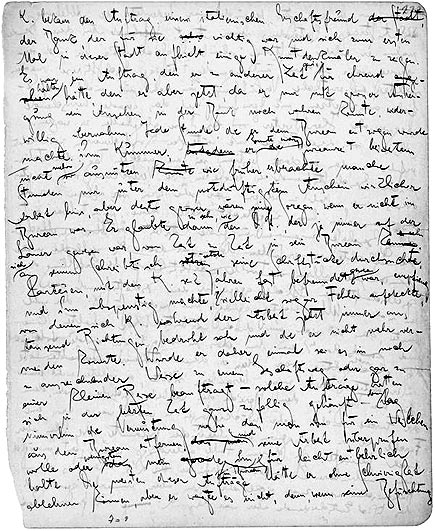Di FRANCESCO FERRI e SANDRO MEZZADRA
Pubblichiamo qui insieme a DinamoPress l’intervista del 21 giugno 2024 di Francesco Ferri a Sandro Mezzadra. Immagine di copertina da Flickr.
L’approvazione del Patto europeo sulle migrazioni ristruttura, in maniera gravemente peggiorativa, il sistema d’asilo e la gestione dei confini in Europa. È possibile leggere la riforma degli strumenti giuridici di governo delle migrazioni alla luce dell’attuale congiuntura politica, segnata dall’affermazione del regime di guerra e da radicali trasformazioni negli assetti di potere su scala globale. In questo contesto inquieto, quale funzione strategica hanno le politiche migratorie? In che termini è possibile immaginare il rinnovarsi di conflitti e lotte nell’attuale congiuntura? Ne abbiamo parlato con Sandro Mezzadra, professore di filosofia politica e attivista per la libertà di movimento.
Le politiche migratorie europee attraversano una fase di profonda ristrutturazione: poco prima della fine della precedente legislatura, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il Patto europeo sulle migrazioni. In questo nuovo scenario, i processi di differenziazione, selezione e isolamento in frontiera saranno ancora più accentuati. L’approvazione di questo patto è arrivata poche settimane prima dalle elezioni del nuovo Parlamento europeo. Ti sembra che, con le lenti delle politiche migratorie, la convergenza tra l’estrema destra europea – nelle molteplici declinazioni – e il centro popolare sia particolarmente visibile?
Le politiche migratorie sono state il motore principale di questa convergenza; il Rassemblement National si è opposto al Patto più che altro per strategia politica. Tra i due poli c’è un gioco al continuo rilancio. La spinta molto violenta da parte delle destre ha condotto il centro popolare a spostarsi sempre più chiaramente su posizioni compatibili con quelle delle destre stesse. Questa dimensione può, a seconda delle circostanze, assumere la forma di un accordo politico a livello europeo oppure no. Questi due piani possiamo tenerli distinti, ma se guardiamo alle migrazioni con uno sguardo di medio periodo, possiamo cogliere quanto siano state il terreno privilegiato di questa convergenza.
Molti commentatori, organizzazioni e movimenti hanno sottolineato quanto i nuovi regolamenti contribuiscano alla messa in crisi definitiva del diritto d’asilo. L’annuncio della morte del diritto d’asilo non è una novità. Eppure all’interno del Patto si configura effettivamente un salto di qualità in relazione alla messa in crisi del diritto d’asilo. Qual è il tuo punto di vista?
Sono d’accordo sul fatto che il Patto determina in Europa un punto di svolta qualitativo dentro un processo di lungo periodo segnato dal progressivo svuotamento del diritto d’asilo.
È una tendenza iniziata all’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso in Germania con l’introduzione delle riforme restrittive del diritto d’asilo. Anche in quelle circostanze si discuteva della sua fine. È un concetto più utile nella polemica politica che dal punto di vista analitico. Credo che si debba essere un po’ più sfumati.
Inoltre, a proposito del Patto a me colpisce particolarmente il nome con cui è presentato: Patto sulle migrazioni e asilo. In realtà di migrazioni non si parla. Credo che sia un punto cruciale. Per quanto riguarda la condizione delle persone richiedenti asilo, sono tendenzialmente sussunte all’interno delle nuove procedure sotto la figura del migrante “illegale” o “clandestino”, con tutte le virgolette del caso, naturalmente. Questo determina l’indebolimento strutturale delle garanzie collegate al sistema dell’asilo. Per anni ci siamo sentiti ripetere che era fondamentale tracciare il confine tra migrazione forzata e migrazione economica. Ora questa distinzione in qualche modo scompare, perlomeno in riferimento alla migrazione nelle sue forme “non ordinate”, per parlare con il linguaggio della governance delle migrazioni.
Questa configurazione solleva molte domande. C’è in particolare un aspetto che mi sembra importante. Come sappiamo, le società europee sono soggette a processi di rapido invecchiamento della popolazione. Questa tendenza ha ritmi differenti nei diversi paesi, ma è di portata generale. Per questa ragione, c’è un bisogno strutturale di migranti. A fronte di questa condizione, se osserviamo le dinamiche in buona parte dei paesi europei – dalla Danimarca alla Grecia – scopriamo che c’è un lavoro febbrile dal punto di vista delle policy per reclutare lavoratori e lavoratrici migranti, secondo una razionalità che possiamo ricondurre alla formula logistica della migrazione just in time e to the point.
Da questo punto di vista, assume per esempio un valore sintomatico il fatto che da due anni l’Ungheria di Orbán sta reclutando migranti dall’Asia. I dati sono rilevanti: si parla di circa 500.000 migranti reclutati in due anni. Si tratta, com’è noto, di un paese che si è distinto per le retoriche contro la migrazione. Ripensando al Patto da questa prospettiva, mi pare che si concluda un processo che abbiamo analizzato in questi anni: a livello europeo si combatte la migrazione disordinata; a livello nazionale si reclutano i lavoratori e le lavoratrici migranti di cui l’Europa ha disperatamente bisogno. Per quanto riguarda l’Italia, mi sembra che l’ultimo decreto flussi possa essere interpretato in questo senso, al di là di tutte le sue evidenti contraddizioni.
Questa dimensione mi sembra esemplificativa di un processo che io, insieme ad altri e ad altre, ho definito di torsione in senso “confederale” della costituzione materiale dell’Unione europea. È vero che queste competenze sono sempre state nazionali, ma negli scorsi anni ci sono stati tentativi di coordinamento, di sincronizzazione di queste politiche a livello europeo. Mi sembra che oggi si abdichi esattamente a questo, dentro un processo di riorganizzazione dell’Unione europea, che attribuisce un peso sempre crescente agli Stati nazionali. È l’ipoteca della destra e della destra estrema nelle sue diverse declinazioni sul processo di integrazione in Europa.
Mi sembra che nel dibattito critico sulle migrazioni, tanto a livello politico quanto forse soprattutto a livello accademico, queste due tendenze vengano tenute troppo separate. Il rischio è di perdere la dimensione complessiva di quello che in altri anni abbiamo chiamato regime di mobilità: bisogna provare a leggere insieme quello che succede nel Mediterraneo e quello che accade in Ungheria.
All’interno del Patto, uno dei profili che ha suscitato maggior dibattito è la cosiddetta “finzione di non ingresso”, per la quale nei luoghi di frontiera sarà possibile non applicare i diritti vigenti negli stati membri, come se le frontiere fossero zone non effettivamente all’interno del territorio statale. Questa novità segna un salto di qualità nella capacità inventiva da parte della governance europea, a cui spesso si contrappongono posture difensive che invocano il “rispetto dei diritti” o auspicano il ritorno delle misure in vigore prima del Patto. È possibile cogliere la sfida di questa capacità inventiva da parte della governance, ribaltarla di segno e sviluppare la capacità di rompere col diritto consolidato da una posizione critica?
Sicuramente nella governance dei confini c’è una tensione all’inventiva e alla creatività, che però non nasce dal nulla. C’è un precedente che ha fatto scuola nel mondo: la cosiddetta Pacific solution in Australia, all’inizio degli anni 2000, caratterizzata dalla “escissione” di alcune isole dal territorio nazionale, utilizzate, secondo il linguaggio della governance europea, come grandi hotspot.
È un precedente estremamente importante, che ha fatto scuola in diverse parti del mondo. Ricordo, nei primi anni Duemila, l’organizzazione da parte della Commissione europea di questi forum sulla gestione dei confini e delle migrazioni nel Mediterraneo, ai quali erano invitati i rappresentanti dei paesi del Mediterraneo e, immancabilmente, gli australiani.
È un doppio processo che compone un paradosso: da una parte ci sono le dinamiche di fortificazione dei confini, la costruzione di muri, anche metaforici, con l’immagine della Fortezza Europa. Dall’altra parte, è riscontrabile l’estrema mobilità della geografia di controllo dei confini per cui, alla luce dei processi di esternalizzazione, il migrante che viene dall’Africa subsahariana incontra il confine europeo migliaia di chilometri prima del Mediterraneo. Più in generale, è in corso una scomposizione dello stesso confine nel momento in cui questo è fortificato: è una tendenza che in molti e molte descriviamo da tempo, ma oggi assume forme inedite.
Per questo motivo la finzione giuridica del non ingresso è senz’altro frutto di inventiva solidamente impiantata in processi ormai di medio di medio periodo. Come ribaltare questa inventiva? È una domanda che all’interno dei movimenti e delle lotte di confine ci siamo posti a lungo in questi anni, cercando di immaginare delle geografie della migrazione attorno a cui costruire un progetto prima di tutto di solidarietà e di costituzione di uno spazio politico diverso. Faccio un esempio: il progetto Allarme Phone cerca di fare esattamente questo.
Adesso bisognerebbe essere in grado di ragionare su scenari più allargati che nella congiuntura attuale sono segnati dall’irrigidimento delle politiche di controllo a cui bisogna trovare risposte efficaci. Seguendo la logica della tua domanda, usando un registro spaziale e geografico, credo che sia importante sottolineare che le migrazioni costruiscono spazi: non c’è soltanto lo spazio delle politiche di controllo. Questo è un tema che, per esempio, nella letteratura è stato particolarmente sottolineato dagli studi sul transnazionalismo migrante.
Mi ha colpito, sempre parlando di letteratura, quello che Achille Mbembe ha scritto alcuni anni fa nell’articolo Les Africains doivent se purger du désir d’Europe [“Le Monde”, 10 febbraio 2019] in relazione alle modalità con cui la migrazione riconfigura lo spazio africano, potenzialmente aprendolo al mondo, in continuità con l’eredità del panafricanismo. Mbembe arriva a dire che il corpo di ogni migrante africano è diventato il confine dell’Europa e che al tempo stesso contribuisce ad aprire, costruire, innovare gli spazi. Questa è un’ipotesi di “controcreatività” da esercitare e consolidare.
Rispetto al percorso di medio periodo che ci ha portato al Patto, l’approccio hotspot, in Italia e in Grecia, ha anticipato molte delle tendenze che ora sono cristallizzate nella nuova normativa. Ad esempio, negli hotspot italiani la limitazione della libertà personale finora è stata configurata soprattutto attraverso strumenti extragiuridici. Più in generale, la sperimentazione di prassi illegittime in seguito integrate all’interno del diritto codificato non è una novità nel campo delle politiche migratorie. Come si può immaginare di rompere questo meccanismo?
L’articolo più interessante che ho letto sul Patto è Crisis as (Asylum) Governance: The Evolving Normalisation of Non-Access to Protection in the EU di Violeta Moreno-Lax. L’autrice mette in evidenza la continuità del Patto con l’approccio hotspot. Violeta Moreno-Lax utilizza un neologismo – crisification – per indicare che la crisi diventa il criterio fondamentale di governo. Questo mi sembra estremamente interessante anche pensando al regime di guerra: la crisi si fa interna ai processi di governo. Mi vengono in mente i lavori di Stuard Hall negli anni ‘70 e il concetto di Stato crisi che Toni Negri ha introdotto nel dibattito marxista sullo Stato nella seconda metà degli anni ‘70. Non è un’idea del tutto nuova dal punto di vista teorico, però è applicata in maniera molto interessante da Violeta Moreno-Lax in relazione al Patto.
L’elemento fondamentale che deriva da questa interpretazione è un’assoluta flessibilizzazione degli strumenti giuridici e l’indeterminazione del confine tra ciò che è prassi legittima e ciò è illegittimo. La migrazione è uno dei terreni di sperimentazione di questi processi di flessibilizzazione del diritto e della politica. Termini come governance e management sono paradigmatici.
Come si lotta contro questi processi? È difficile dare una risposta che non rischi di essere generica. Ci vuole un doppio piano di lotta, con una doppia razionalità. Questi processi di flessibilizzazione vanno combattuti sul terreno, per come si manifestano. Allo stesso tempo, va prodotto un discorso che richiami i principi generali, soprattutto nel discorso pubblico. Questi principi di carattere generale possono e devono essere anche di tipo nuovo: non è necessario richiamare quelli che hanno governato per alcuni decenni il sistema dell’asilo. Ad esempio, cosa significa “libertà di movimento” nella congiuntura attuale? Mi rendo conto che l’indicazione è generale, spero non del tutto generica, ma dal mio punto di vista è necessario questo doppio piano.
Il Patto sulle migrazioni e l’asilo è stato presentato a settembre del 2020, prima che il regime globale di guerra assumesse le attuali caratteristiche con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e la guerra a Gaza. L’iter di approvazione dei nuovi regolamenti ha avuto un’accelerazione decisiva all’interno dell’attuale congiuntura. Qual è la relazione dal tuo punto di vista tra l’attuale regime globale di guerra e l’approvazione del patto?
La congiuntura della pandemia da COVID-19, che di per sé ha avuto delle ricadute violentissime sulle migrazioni, ha fatto da sfondo alla presentazione del Patto da parte della Commissione. E c’è un nesso profondo tra la congiuntura pandemica e la congiuntura di guerra attuale.
Inoltre, “congiuntura di guerra” non significa necessariamente “guerra permanente”. L’intensità della guerra all’interno della congiuntura può variare a seconda dei tempi e dei luoghi: ha molteplici modalità di manifestazione. In via generale, è evidente il nesso tra guerra e migrazioni, prima di tutto per quel che riguarda gli spostamenti forzati di popolazione che la guerra determina e l’individuazione dei “nemici interni”. Faccio un unico esempio: i nippoamericani internati in veri e propri campi durante la seconda guerra mondiale. Nel nostro presente, queste dinamiche assumono in particolare la forma dell’islamofobia.
È utile allargare l’analisi e guardare al rapporto tra migrazioni e regime di guerra dal punto di vista della riorganizzazione, nella fase che stiamo vivendo, di quelli che la letteratura sociologica sulle migrazioni chiama “sistemi migratori”. Io credo che questo sia un tema assolutamente centrale. Tornando al Patto, mi sembra che la flessibilizzazione sia lo strumento principale del governo della mobilità umana, in una congiuntura di guerra come quella che stiamo vivendo.
Propongo un’immagine che mi ha colpito molto, tratta dal film Green border di Agnieszka Holland. Il film, secondo me, racconta in maniera straordinaria la crisi al confine tra Polonia e Bielorussia, nell’autunno del 2021. Mostra la brutalità senza alcuna mediazione delle forze di sicurezza polacche in questi boschi tra i due paesi – ecco perché il green nel titolo. Il film termina con le immagini dei polacchi che accolgono con le bandiere e i sorrisi i profughi dall’Ucraina.
È un’immagine che non va generalizzata perché anche la crisi al confine tra Polonia e Bielorussia ha la sua assoluta specificità, così come il movimento dei profughi dall’Ucraina dopo il 22 febbraio del 2022. È però sintomatica di quello che può accadere in questa congiuntura. Il profugo può essere il nemico assoluto se viene da un certo paese e diventare assolutamente benvenuto se arriva da un altro contesto, dentro un processo di riorganizzazione dei sistemi migratori.
Le esigenze di un regime di guerra non sono soltanto strettamente belliche, tanto più in un momento come questo in cui il mondo sta vivendo, per dirla rapidamente, una tumultuosa transizione dentro la riorganizzazione degli spazi globali. I movimenti migratori giocano un ruolo fondamentale, tanto più in un continente come quello europeo caratterizzato da questi processi di invecchiamento della popolazione che rendono indispensabile il reclutamento di lavoratori e lavoratrici e migranti. La flessibilizzazione degli strumenti, prevista nel Patto, si iscrive in questo scenario.
In questo contesto, che spazio ha il concetto analitico di inclusione differenziale che hai declinato molto efficacemente nel corso della tua ricerca e che è stato fatto proprio e utilizzato in maniera produttiva da attiviste e attivisti in tantissimi luoghi e tempi diversi? È utilizzabile, con le dovute specifiche, per immaginare e costruire nuove dimensioni di lotte all’interno dell’attuale congiuntura di guerra?
È un concetto che ho utilizzato in particolare in un libro scritto con Brett Neilson, Border as Method [Confini e frontiere, Il Mulino 2014], in cui abbiamo fatto interagire tra loro esperienze di migrazione, lotte dei migranti, esperienze politiche e modalità di controllo dei confini in diverse parti del mondo. È un concetto di cui mi guardo bene dal rivendicare la paternità, perché lo abbiamo costruito in un dialogo con la teoria femminista e con la teoria antirazzista. Ricordo che in particolare che nei primi anni 2000 Nicholas de Genova, amico e compagno statunitense, utilizzava in riferimento al confine tra Stati Uniti e Messico la categoria di “inclusione attraverso l’illegalizzazione”.
Questa intuizione mi colpì molto: mi sembrava di trovare un riscontro molto preciso nei paesi dell’Europa meridionale, quelli di nuova migrazione: Grecia, Italia, Spagna. Credo che effettivamente per molto tempo i confini abbiano funzionato anche così in Europa, producendo inclusione attraverso l’illegalizzazione, favorendo l’ingresso dei migranti poi sfruttati nelle campagne, nei cantieri, nei lavori di cura, e così via. Questa dinamica è ancora attuale, ma forse non nel modo massiccio in cui si è data in passato. Rispetto alla situazione tra gli anni ‘90 e i primi anni 2000, ci sono state delle cesure storiche. In particolare la crisi finanziaria tra il 2007 e il 2008, con il suo impatto in Europa e in particolare in Italia, con la crisi dei debiti sovrani, ha cambiato molte cose, anche rispetto all’assorbimento della manodopera migrante.
C’è un tema che per me continua a essere molto importante. Tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio degli anni 2000 in Italia questi processi di “inclusione differenziale” venivano generalmente letti attraverso la categoria di “esclusione”. È una categoria che paradossalmente rischia di rafforzare la dimensione della vulnerabilità. Parlare di inclusione differenziale significa, secondo me, continuare a guardare alla violenza del confine, alle immagini intollerabili che ogni giorno arrivano dal Mediterraneo, dal punto di vista del modo in cui cambiano i codici dell’inclusione. Come dicevo prima, ho l’impressione che nel dibattito attuale ci si soffermi molto sui dispositivi di chiusura e meno sugli schemi di reclutamento della forza lavoro migrante. Dal punto di vista analitico e poi, auspicabilmente, anche dal punto di vista politico, bisogna cercare di tenere insieme questi due livelli. La categoria di inclusione differenziale può essere uno degli strumenti, non certo l’unico, che ci permette di farlo.
Quali scenari di lotta possiamo prefigurare all’interno di questa congiuntura di guerra? Qual è lo spazio per il movimento antirazzista all’interno di un nuovo auspicabile internazionalismo?
Comincerei col dire che oggi non c’è un movimento antirazzista europeo. Ci sono in tutta Europa movimenti antirazzisti e lotte contro il razzismo. Ho vissuto per qualche mese in Francia: qui, in generale, e nella regione metropolitana di Parigi in particolare, il tema del razzismo è fondamentale e ineludibile all’interno delle lotte sociali, anche al di là delle persone e delle organizzazioni che si occupano in maniera specifica dell’argomento.
Ti dico qual è la mia impressione: mi pare che rispetto a vent’anni fa – al tempo della rivolta nelle banlieues del 2005 – ci sono stati degli avanzamenti significativi. Nel 2006 avevamo un grande movimento fondamentalmente studentesco contro il reddito di inserimento, senza che allo stesso partecipassero strutturalmente le ragazze e i ragazzi delle banlieues (se non per sottrarre qualche cellulare a studenti “bianchi”). Oggi la situazione è molto diversa: la rivolta delle banlieues dello scorso anno ha generato un dibattito all’interno della sinistra, all’interno dei movimenti e ha favorito ampi processi di politicizzazione.
Nelle banlieues a nord e nord-est di Parigi ci sono le condizioni per un rapporto politico completamente diverso. Ad esempio le manifestazioni di queste settimane contro l’estrema destra vedono il protagonismo di molti ragazzi e molte ragazze provenienti da quei contesti. Lo slogan “Paris-banlieue-antifa” registra una dinamica di partecipazione effettiva. Allo stesso tempo, il risultato elettorale dell’estrema destra fotografa una situazione ovviamente difficile: su questi temi essa ha costruito le sue fortune elettorali.
Come accennavo in precedenza non esiste un movimento antirazzista europeo. Esistono sicuramente delle esperienze di convergenza molto importanti, ad esempio sulla questione del salvataggio in mare: sono reti europee da cui viene quotidianamente un contributo fondamentale alla reinvenzione dell’antirazzismo. In questa nuova congiuntura, il razzismo acquisisce caratteristiche peculiari: i movimenti antirazzisti devono essere in grado non solo di lottare contro queste caratteristiche nuove, ma anche in qualche modo di anticiparle, di superarle. Ad esempio, mi sembra che, non solo in Europa, si affermi una forma di razzismo collegata al concetto di civiltà. Non è un’assoluta novità, ma assume un significato diverso in questa congiuntura. Il continuo riferimento ai valori europei può diventare un’arma che restringe violentemente gli spazi di espressione e di vita per i milioni di cittadine e cittadini europee e europei di origine migrante e le milioni di donne e uomini che non hanno la cittadinanza europea, ma che si trovano in Europa o sono in movimento verso l’Europa.
Come si lotta contro un razzismo di questo genere? È una domanda che bisogna porsi, possibilmente trovando risposte, in situazioni molto concrete, nella quotidianità delle lotte. D’altro canto, è utile riflettere in termini generali, costruendo una diversa Europa, costruendo un diverso modo di stare dentro lo spazio europeo. Non credo che possa essere abbandonato lo spazio europeo come alcuni propongono. Va reinventato, anche se in questa fase appare difficile farlo. Serve una nuova immaginazione: bisogna reinventare la posizione che l’Europa ha nel mondo. Non c’è reinvenzione dello spazio europeo senza reinvenzione dell’internazionalismo, e viceversa.