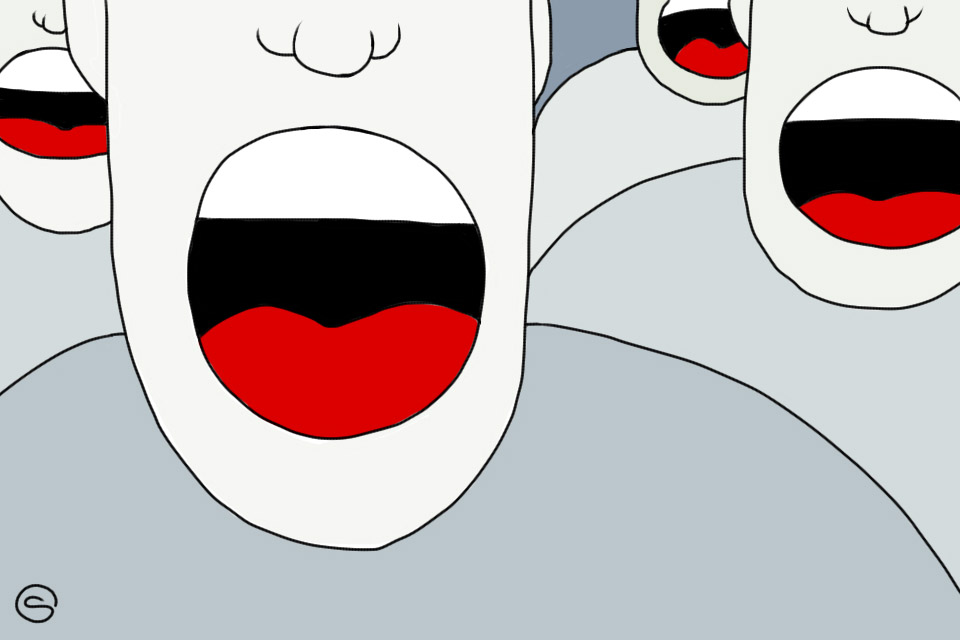di TONI NEGRI
A proposito di Italian Theory. Note sullo stato della filosofia italiana – 5
Intervento al Colloque International: “L’Italian Theory existe-t-elle?”, Paris, 24-25 janvier 2014
Se di quel groviglio di prospettive teoriche, di progetti filosofici, di iniziative e di nuove pratiche politiche, sorto e sviluppatosi fra il ’60 e la fine secolo in Italia, se dunque di questo groviglio qualcuno non facesse un insieme, magari plurale o dialettico, chiamandolo Italian Theory – non ci sarebbe nulla da replicare. Come gli americani hanno fatto mettendo assieme, nella French Theory, Derrida e Deleuze, Bataille e Foucault, Althusser e Lyotard, senza pretendere matrici comuni e solo invece costruendo un ambito, un territorio, un’epoca. In Italia, oltre ad essere difficilmente identificabile un ambito ricopribile da una sigla unitaria, la situazione è complicata dal fatto che quel territorio e quel tratto temporale, più che da un pensiero, furono riempiti da un conflitto politico assai drammatico. La filosofia nacque e si dispose dentro quel conflitto. L’origine di un’eventuale Italian Theory ha dunque caratteristiche difficilmente riconducibili ad una qualsiasi comune condizione storica e teoretica. Se il mondo accademico gli è totalmente estraneo, quello sociale è scisso da conflitti di classe e politici prossimi alla guerra civile. All’origine di quel groviglio non si può certo narrare una teoria politica; al massimo, nei suoi anfratti, si potranno riconoscere degli strumenti di lotta politica. La cassetta degli attrezzi precede tutto il resto.
Alle origini c’è la critica del gramscismo e della sua interpretazione togliattiana. Quest’interpretazione si pretendeva come tradizione filosofica che si voleva egemone, fondata su supposti caratteri nazional-popolari della storia italiana, ma non sdegnando di raccogliere, assieme alle bandiere che la borghesia aveva lasciato cadere nel fango, anche il sapere politico dell’agire sovrano e della mediazione sociale, proprio delle classi dirigenti d’antan. Nello storicismo si confondevano continuità dello Stato ed innovazione socialista: un gigantesco Tocqueville troneggiava sul togliattismo. Lo sfondo su cui si articola lo storicismo del PCI è vasto e profondo. Esso tende ad investire lo sviluppo capitalistico con una critica che non è alternativa progressista – l’alternativa è rinviata a quando lo sviluppo avrà ricoperto completamente la società, i dualismi della storia italica saranno tolti, la corruzione interna al sistema sarà evacuata e la bella società nazional-popolare sarà matura al socialismo. A questa dolciastra ideologia si cominciano ad opporre alcune critiche diffuse a partire dalla seconda metà degli anni 50. Una figura centrale è quella di Franco Fortini. Con ascendenti brechtiani e benjaminiani, ma soprattutto giovin-luckacsiani egli propone una critica feroce del “nazional-popolare” e dello storicismo crociano cui il gramscismo aveva finito per essere identificato. In questa critica confluiscono anche strati della cultura della sinistra cattolica del tempo, di Felice Baibo e di tanti altri e di un certo radicalismo liberale di origine gobettiana. Ma soprattutto è fondamentale il fatto che dall’interno di questo insorgere critico, nasce e si diffonde una nuova figura di militante di base, che fa rinascere il marxismo dall’indagine di fabbrica e dalla sua estensione sociale – esso porta la richiesta di un’alterità radicale sin dall’inizio. È una sorta di sociologia militante, assai selvaggia in Montaldi e Alquati, che coinvolge tuttavia al suo interno intellettuali del rango di Pizzorno e Momigliano, si estende al di là della ricerca sociologica fino alle pratiche mediche e psichiatriche di Basaglia, Terzian, Maccacaro, etc. Una politica nuova si fa combattendo contro il potere, una filosofia nuova militando con gli sfruttati.
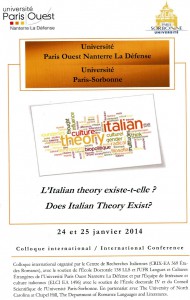 Raniero Panzieri è il prodotto di questa cultura alternativa, pur provenendo da una lunga militanza culturale comunista. Traduce il Secondo libro de Il Capitale sulla circolazione. Su questa base si lega all’interpretazione francofortese del capitalismo maturo proposta da Pollock. Comincia ad indagare il “capitalismo sociale” – cioè ad attaccare l’immagine profondamente pessimista di un mondo compatto, formattato univocamente dal potere capitalista, che la teoria della scuola di Francoforte ci aveva, nei suoi episodi finali, regalato. All’incantesimo del metodo (il capitale che investe l’intera società, la produzione che si estende nella circolazione, l’uomo che diventa macchina) segue – nota Panzieri – un blocco della ricerca. Ma soprattutto un blocco dei movimenti, della lotta, dei processi di emancipazione. Fin dal principio la reazione dei Quaderni Rossi a quest’immagine di una società capitalista bloccata, di cui i massimi sacerdoti sono identificati a torto o a ragione in una linea di pensiero che va da Max Weber alla Dialettica dell’Illuminismo di Adorno e Horkeimer, investe la fabbrica e la società, la vita operaia e quella della città – come territori della lotta di classe e come realtà politica. È a partire da questa percezione biopolitica che la cassetta degli attrezzi si organizza.
Raniero Panzieri è il prodotto di questa cultura alternativa, pur provenendo da una lunga militanza culturale comunista. Traduce il Secondo libro de Il Capitale sulla circolazione. Su questa base si lega all’interpretazione francofortese del capitalismo maturo proposta da Pollock. Comincia ad indagare il “capitalismo sociale” – cioè ad attaccare l’immagine profondamente pessimista di un mondo compatto, formattato univocamente dal potere capitalista, che la teoria della scuola di Francoforte ci aveva, nei suoi episodi finali, regalato. All’incantesimo del metodo (il capitale che investe l’intera società, la produzione che si estende nella circolazione, l’uomo che diventa macchina) segue – nota Panzieri – un blocco della ricerca. Ma soprattutto un blocco dei movimenti, della lotta, dei processi di emancipazione. Fin dal principio la reazione dei Quaderni Rossi a quest’immagine di una società capitalista bloccata, di cui i massimi sacerdoti sono identificati a torto o a ragione in una linea di pensiero che va da Max Weber alla Dialettica dell’Illuminismo di Adorno e Horkeimer, investe la fabbrica e la società, la vita operaia e quella della città – come territori della lotta di classe e come realtà politica. È a partire da questa percezione biopolitica che la cassetta degli attrezzi si organizza.
Si può aggiungere qui che Panzieri e i suoi amici non erano soli. Anche in taluni ambienti accademici la reazione alla duplice influenza del gramscismo togliattiano e del pessimismo francofortese era emersa. Sia sul terreno della fenomenologia (Paci e Semerari), sia sul terreno di una filosofia pragmatica e neo-positivista, Preti e il proto-linguista Rossi-Landi, insistevano sull’importanza della “relazione” fenomenologica e riattaccandosi all’ultimo Husserl o al secondo Wittgenstein esigevano una radicale rottura con ogni forma di hegelismo residuo. Personalmente penso che questo sfondo teoretico sia stato molto più importante, nell’elaborazione di un pensiero dell’alternativa, di quello che la storiografia accademica insiste esser stata la critica dellavolpiana. Non era sulla base di un logicismo protervo ed irrazionalista (di cui l’ultimo prodotto fu Colletti) che si poteva reinventare il quadro filosofico di una critica che investiva la vita. L’eresia fenomenologica italiana fu a questo scopo molto più efficace.
Con Mario Tronti la rottura con l’interpretazione francofortese del capitalismo maturo giunge al suo apice. Non si nega qui che il capitale abbia colonizzato interamente la società, si nega semplicemente che questo sia un fenomeno economico, necessario – che il concetto stesso di capitale sia unitario, trascendente, fondazione del politico e della vita. No – la valorizzazione capitalista si fa sulla/contro la resistenza operaia. Alla soggettività indubbia dell’iniziativa capitalista, del “capitale costante”, del capitale-padrone risponde la soggettività del “capitale variabile”, del capitale-operaio – al potere risponde la vita. Insomma, Tronti ci offre un Marx riadattato alla lotta politica nel presente, riproponendo adeguate caratteristiche soggettive del capitale variabile. La soggettivazione è radicale: essa si pone in rottura con tutte le linee dell’hegelismo presenti sul mercato del sapere italiano – riscopre il carattere antagonista del rapporto di capitale, e quindi la durezza del capitale variabile, dentro il concetto generale di capitale. Il recupero dell’originaria intuizione marxiana si ha allora compiutamente nell’affermazione che sono le lotte che producono lo sviluppo capitalistico, che è la forza-lavoro organizzata che costruisce la storia. La soggettivazione si approfondisce fino al punto di considerare, contro l’intera tradizione leninista, che la strategia della distruzione storica della società borghese appartiene direttamente alla classe operaia, mentre al partito, all’intellettualità dirigente, appartiene solamente la possibilità di elaborare una tattica, un modo di gestione del rapporto fra lotte e Stato. La meccanica social-democratica che vedeva la tendenza capitalista dello sviluppo produrre le condizioni della rivoluzione socialista, viene dissacrata e l’elaborazione della tendenza ricondotta alla soggettivazione della classe operaia. L’elemento teorico nasce all’interno di una politica che investe la vita e che scopre in ciò i dispositivi di distruzione del dominio capitalista.
La soggettivazione della rottura politica si svolge dunque all’interno delle lotte. Qui c’è, nella rottura, il risalto di un’etica. Essa si rivela nel rovesciamento immediato della funzione intellettuale, in una Beruf weberiana completamente rovesciata, antagonista piuttosto che funzionale, partecipe del destino operaio piuttosto che produttrice, dall’alto, di ideologia. È il rovesciamento della teoria nella pratica. L’etica è riconoscimento e difesa di una resistenza che non può essere riassunta in una qualsiasi dialettica, del capitale, dello Stato o del partito. L’etica è piuttosto il fondamento di una dialettica negativa, dove l’antagonismo soggettivo di classe riconosce la rottura, meglio, l’impossibilità di ogni mediazione capitalistica in termini strategici. Di qui, tuttavia, proprio in questa rottura, si dà la capacità di vivere e di definire una tendenza che nelle lotte si afferma, una produzione di soggettività che si dispone nella lunga temporalità. Il concetto di tendenza qualifica una vera e propria gnoseologia ed epistemologia dell’agire. Una sorta di approccio biopolitico si dipana non semplicemente come potenza conoscitiva del capitale e del suo sviluppo ma come politica nella vita e della vita. Ci sono tre punti, almeno, che qui risaltano. Il primo consiste in un’analisi dei regimi salariali che dalla fabbrica trascorrono nella società, la investono nella sua generalità, definiscono lo stato sociale presente e la sua continua crisi. In questo trascorrere dalla fabbrica alla società l’analisi del salario riarticola il rapporto fra bisogni e produzione sociale, fra consumi e comportamenti collettivi, fra organizzazione della fabbrica ed organizzazione della famiglia e della “società civile”. Un secondo terreno di analisi è quello che riguarda la composizione politica del “salariato”. Qui la storia dei modi di produzione riprende il grande affresco marxiano dall’accumulazione originaria fino alla società industriale, dalla sussunzione formale alla sussunzione reale, e dentro questo nesso storico definisce le linee di lettura delle forme e figure istituzionali. La storia dei modi di produzione è storia dei modi di dominazione. È qui che la teoria operaista si collega direttamente, alla sua nascita, con le teorie della regolazione francesi e con la fenomenologia economica dello sviluppo dei neo-marxisti tedeschi (Hirsch, Offe, etc.). La soggettivazione capitalista e la soggettivazione proletaria vivono dentro un’articolazione comune, rotta dalle lotte, riprodotta in un continuo configurarsi istituzionale del processo. Su un terzo terreno si sviluppa l’analisi, ed è quello sul quale la composizione tecnica del lavoro, della classe operaia, giunge ad approfondirsi nell’analisi del rapporto uomo-macchina in tutta la ricchezza delle trasformazioni che questo rapporto implica. È soprattutto su questo terreno che la sociologia e l’antropologia tedesche vengono riprese ed immediatamente trasformate in utensile nell’organizzazione delle lotte.
C’è dunque un intero orizzonte generico nel quale e sul quale si scontrano la vita e il biopotere. Questa opposizione sta alla base dello sviluppo della filosofia politica nuova negli anni 60, contro ogni storicismo ed ogni permanenza o reviviscenza di un hegelismo dialettico. Si tratta allora di un’atmosfera diffusa nel pensiero europeo. Questa rottura dell’onto-teleologia occidentale trovava allora anche in Habermas un riconoscimento. I primi passi di Habermas, nella sua rottura con l’orizzonte di impotenze che era il lascito della Scuola di Francoforte, consiste nella riscoperta dello Hegel jenese e quindi di un meccanismo aperto dell’interrelazione sociale. Quella frattura va drammatizzata, secondo il primo Habermas, e risolta dalla mediazione comunicativa. È una sorta di ultimo, flaccido neo-kantismo, quello che ci viene proposto. È esattamente quello che quell’origine italiana di un pensiero delle lotte nega. La fenomenologia non più semplicemente del capitale ma di un capitalismo che ha investito la vita, il quadro francofortese cioè, è anche qui assunto ma piegato ad una definizione antagonista del biopotere: essa non trova soluzione intellettuale. Il senso di questa crisi può essere recuperato solamente attraverso un’immersione etica, una rottura epistemologica ed un nuovo orientamento politico. L’analisi si sposta dall’alto al basso, è condotta dall’interno, non ammette cesure, assume la soggettivazione come terreno imprescindibile di ogni ragionamento filosofico.
Il nesso antagonista fra rapporti di produzione e forze produttive, tra soggettivazione del dominio capitalista e soggettivazione prodotta dai comportamenti della forza-lavoro sociale si accentua ed è man mano resa drammatica dalla trasformazione dei rapporti di forza dentro questa polarità antagonista. D’altra parte, il capitalismo investe sempre più la vita in termini “estrattivi” di plus-valore quando la società intera, la vita intera, sono diventate produttive – ma su questo medesimo terreno si scorge la tendenza della società produttiva a riappropriarsi di un’autonomia sempre più significativa ed importante. Al contesto biopolitico si oppone così in maniera sempre più evidente un biopotere – e la resistenza si configura, nella tendenza, in termini sempre più autonomi, costituenti ed istituenti.
 Ma la tendenza è presto sotto attacco. La si accusa di proporre sostituti teleologici e contesti storicisti alla critica di ogni Aufhebung possibile. Ma questa accusa non tocca il suo obiettivo: la sola teleologia possibile è infatti, nella filosofia nuova, quella del punto di vista dell’azione e il solo storicismo ammesso è quello del riconoscimento della sua storicità. Di contro, si vuole che l’assunzione di una dialettica negativa non abbia soluzioni – la fenomenologia della Krisis diviene mistica. È questo il punto centrale di rottura del pensiero alternativo italiano alla fine degli anni ’60: all’uscita pragmatica e tendenziale dalla Krisis ed alla sua determinazione radicalmente immanentista ed umanista, alla fissazione del biopolitico come tessuto produttivo si oppone una sorta di esorcismo – non più quello debole, trascendentale, del neo-kantismo e delle filosofie linguistiche e comunicative (è quello il momento della polemica Habermas-Apel) ma escatologico, misteriosamente trascendente. Alle lotte, mai come allora prepotenti, si oppone teoricamente la cosiddetta “autonomia del politico”, praticamente l’effettività della “ragion di Stato”. La crisi di paradigma della filosofia moderna che la filosofia nuova aveva interpretato in termini politici, anticipando nei dialetti italici e nelle lotte, quell’orizzonte di pensiero che il post-strutturalismo francese della seconda metà del secolo XX presenta in maniera aperta (e sviluppa attraverso varie e molteplici prospettive), viene qui ricondotta all’ontologia nichilista e all’impotenza etica del Nietzsche interpretato da Heidegger, peggio, ad una Waste land hartmanniana. Il risultato effettivo di questa critica/critica è quello di consolidare un biopotere senza possibile alternativa laddove è proprio in questa fase che la nuova filosofia comincia dall’interno della dialettica spezzata, a costituire un’ontologia produttiva del comune, a riempire cioè la critica della sussunzione reale della società nel capitale con la scoperta e la costituzione di un potere costituente del comune. È qui che questo potere costituente, ricondotto all’ontologia, si allarga a costituire una vera e propria base materialista critica dello sviluppo capitalista. Hardt e Virno già allora, all’inizio degli anni ’90, sottolinearono quanto la critica pratica che il pensiero italiano delle lotte aveva sviluppato fosse stata tradotta positivamente nella filosofia post-strutturale francese. Non fu un caso quindi che la critica neo-heideggeriana e il misticismo del pensiero della Krisis risultassero totalmente estranei a quel medesimo pensiero post-strutturalista – ma soprattutto alieni da ogni visione della biopolitica e della produzione di soggettività.
Ma la tendenza è presto sotto attacco. La si accusa di proporre sostituti teleologici e contesti storicisti alla critica di ogni Aufhebung possibile. Ma questa accusa non tocca il suo obiettivo: la sola teleologia possibile è infatti, nella filosofia nuova, quella del punto di vista dell’azione e il solo storicismo ammesso è quello del riconoscimento della sua storicità. Di contro, si vuole che l’assunzione di una dialettica negativa non abbia soluzioni – la fenomenologia della Krisis diviene mistica. È questo il punto centrale di rottura del pensiero alternativo italiano alla fine degli anni ’60: all’uscita pragmatica e tendenziale dalla Krisis ed alla sua determinazione radicalmente immanentista ed umanista, alla fissazione del biopolitico come tessuto produttivo si oppone una sorta di esorcismo – non più quello debole, trascendentale, del neo-kantismo e delle filosofie linguistiche e comunicative (è quello il momento della polemica Habermas-Apel) ma escatologico, misteriosamente trascendente. Alle lotte, mai come allora prepotenti, si oppone teoricamente la cosiddetta “autonomia del politico”, praticamente l’effettività della “ragion di Stato”. La crisi di paradigma della filosofia moderna che la filosofia nuova aveva interpretato in termini politici, anticipando nei dialetti italici e nelle lotte, quell’orizzonte di pensiero che il post-strutturalismo francese della seconda metà del secolo XX presenta in maniera aperta (e sviluppa attraverso varie e molteplici prospettive), viene qui ricondotta all’ontologia nichilista e all’impotenza etica del Nietzsche interpretato da Heidegger, peggio, ad una Waste land hartmanniana. Il risultato effettivo di questa critica/critica è quello di consolidare un biopotere senza possibile alternativa laddove è proprio in questa fase che la nuova filosofia comincia dall’interno della dialettica spezzata, a costituire un’ontologia produttiva del comune, a riempire cioè la critica della sussunzione reale della società nel capitale con la scoperta e la costituzione di un potere costituente del comune. È qui che questo potere costituente, ricondotto all’ontologia, si allarga a costituire una vera e propria base materialista critica dello sviluppo capitalista. Hardt e Virno già allora, all’inizio degli anni ’90, sottolinearono quanto la critica pratica che il pensiero italiano delle lotte aveva sviluppato fosse stata tradotta positivamente nella filosofia post-strutturale francese. Non fu un caso quindi che la critica neo-heideggeriana e il misticismo del pensiero della Krisis risultassero totalmente estranei a quel medesimo pensiero post-strutturalista – ma soprattutto alieni da ogni visione della biopolitica e della produzione di soggettività.
Ci fermiamo qui. Brutalmente, quanto avviene dopo, ci sembra semplicemente un riporto ed un’enfasi di quanto avvenuto fin qui. A fronte di quel groviglio di problemi e di contraddizioni la Italian Theory si presenta come l’ennesimo schema storiografico “debole” che coglie vagamente le determinazioni temporali e locali del processo storico per condurle ad una pacificazione imbelle. Con alcune conseguenze estremamente pesanti. In primo luogo, quella di distogliere l’attenzione del ricercatore dalla fenomenologia contraddittoria del biopotere mantenendo una confusione fra categorie dell’immanenza e della trascendenza. È qui che il teologico politico fa ancora le sue prove. È qui che per esempio la critica teologico-politica, dopo aver intravisto utopicamente una comunità che viene, rifiuta la soggettivazione non tanto come resistenza ed antagonismo ma come materialità, istituzione, storicità. La biopolitica verrà qui configurata dunque come luogo che si esaurisce in un vuoto di potere, in una nudità che è parola sostitutiva di un vuoto di tempo e di storia. In secondo luogo, l’Italian Theory finisce per intimare l’evacuazione di ogni punto di vista storicamente determinato, eticamente situato e politicamente orientato nella conoscenza e nell’agire nell’orizzonte politico. Anche da questo punto di vista la storicità delle lotte, le soglie di produzione di soggettività, le tendenze costruite vengono sistematicamente ridotte e censurate. In terzo luogo, nell’Italian Theory, nelle pacificazioni che essa pretende registrare, si esclude la possibilità di assumere qualsiasi rottura del rapporto biopolitico come emersione/insorgenza di nuove potenze autonome. La biopolitica è qui presentata come terreno che non si colloca nella dialettica negativa ma la sopprime, che non pone il rapporto ontologico come polarità, ma ne toglie la potenza, e nega l’intransitività dell’antagonismo che comprende. In quarto luogo, e di conseguenza, la crisi finale dell’onto-teleologia occidentale ci lascerebbe nell’impossibilità di determinare uno spazio, di riabilitare una temporalità e di costruire un soggetto che ritrovi nella storia un comune orizzonte costituente. È invece per compiere questo lavoro che la nuova critica è nata praticamente negli anni ’60 e si è riorganizzata filosoficamente più tardi – per togliere a chiunque la possibilità di rinnegare il soggetto.
Ma soggetto è soggettivazione. C’è stato qualcuno che ha pensato si potesse, dentro le lotte, dentro le dinamiche dello scontro fra biopotere e soggetti biopolitici, dentro la trasformazione del concetto di classe operaia in quello di soggetto cognitivo e precario, meglio, in quello di moltitudine – c’è stato forse qualcuno che ha pensato si potessero di nuovo presentare sulla scena soggetti – chiamati identità, sostanze o individui – pur collettivi? Certo : neppure questa diffamazione è mancata nei confronti della nuova filosofia. Essa, tuttavia, tanto più si è confermata quanto più, sul terreno ontologico, le emergenze soggettive e determinate (Spinoza le avrebbe definite infiniti modi dell’essere) venivano qualificate come singolarità. Ed anche il concetto di produzione non poteva esser colto che in termini di cooperazione di singolarità, come assemblaggio di singolarità, altrimenti improduttive. Singolarità definite tanto dalla forza-invenzione della loro natura cognitiva quanto dalla potenza degli affetti messi in produzione, ma soprattutto definite dal loro mettere in comune cooperando le potenze biopolitiche di cui esprimono la tendenza. La loro esistenza è comune, e non può esserci esistenza fuori dal comune. Sono moltitudine produttiva. La solitudine è una favola nera. Solo il comune è produttivo ma lo è perché è composto da infinite singolarità che si associano in maniera continua. Di contro, le ragioni dell’individualismo cercano ancora spazio riemergendo in maniera equivoca, rispetto alla nuova filosofia, in altre versioni della Italian Theory – sia la zoé che l’immunitas mantengono il riferimento individualista come principale. Per non parlare degli autori che della paura – oggi denominata katechon – hanno fatto il movente hobbesiano dell’individualità nel ricorso alla sicurezza nello Stato.
Certo, la soggettivazione è produttiva quanto è prodotta. Ma questo rapporto antagonista è “estrattivo”, nei due sensi di quella insolubile dualità che la dialettica negativa propone. Da un lato, il biopotere estrae dall’insieme degli individui la sua ricchezza e la sua legittimità; dall’altro le singolarità, promuovendosi come potenza comune nella cooperazione produttiva, espropriano il biopotere della sua capacità di governo. Qui, dopo cinquant’anni, la filosofia nuova ritorna (oltre ogni orpello della Italian Theory) a chiedersi quale sociologia e quale economia politica possano essere “cassette di attrezzi” per ricostruire – in queste nuove condizioni – una militanza del comune che recuperi e sviluppi la forza sovversiva delle origini – nella formazione del comune.
E, nei riguardi dell’Italian Theory, nessun risentimento: omnia munda mundis.
Sul Povero Yorick: Note sullo stato della filosofia italiana:
Marco Assennato, → Giocare il gioco dell’Italian Theory?
Antonio Negri, → Vana ricerca del buon governo
Girolamo De Michele, → La pop filosofia spiegata a un accademico (e non solo a lui)
Girolamo De Michele, → Oltre l’accademia: le strade