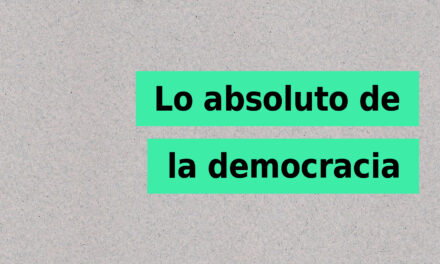di ALESSANDRO TAGARIELLO.
Tra il cervello e l’epistola una lista incorporea di incontri sembra far filare una magnifica ossessione: farla finita con le immagini rappresentative. Proviamo a partire da qui per cercare di cogliere la radicalità di pensiero che scorre tra le pieghe delle lettere nelle quali Toni Negri in qualche modo intercetta questa iconoclastia. Il limite carcerario entro cui prendono sostanza questi a-solo ne costituisce al contempo il contesto e il salto verso l’impensato.
Naturalmente stiamo parlando di Arte e multitudo (Toni Negri, Arte e multitudo, a cura di Nicolas Martino, Roma, DeriveApprodi 2014, 176 pp.), la cui recensione è stata riportata in questo spazio.
Pur non comparendo negli scritti, Deleuze ci può fornire alcune utili indicazioni per far luce – via Spinoza – sull’incrinatura negriana ai bordi della quale si produce una ateologia immanente che strappa l’arte dal suo torpore categoriale e la pone in relazione alle singolarità del comune a-venire. E leggiamo subito, sin dalla prima lettera – proprio quella indirizzata all’amico artista Gian Marco – quanta necessaria prudenza, sofferenza e innanzitutto forza occorrano nella costruzione di un ragionamento e di una prassi affetti dall’idea di moltitudine mentre si è circondati ovunque dai “fabbricatori di tristezza” (gli operatori del mercato). Incipit, il post-moderno e la sua immanente staticità funeraria, sul cui piano nodi di resistenza impattano la complessità del moderno staccato dalla modernizzazione. Non si tratta di tempo e spazio; c’è poco da contemplarne il limite da oltrepassare, alla maniera di un trip alla Caspar D. Friedrich che incontrerebbe Damien Hirst stando sul suo bel dirupo (occhio al mare di nebbia!). Sublime è già ben oltre la forma-uomo e dunque oltre la natura, ci ricorda Negri; ma questo passaggio, indissolubilmente potente e gioioso, nondimeno è tutto interno al divenire-mondo dell’astrazione.
Già, ma questo è ciò che emergerebbe con un cannocchiale capovolto sul frame di veridizione economica che nel frattempo produce controindicazioni lisergiche: si hanno delle idee creative, si è produttori seriali e insieme consumatori di immagini nei quotidiani istantanei amplessi visivi della comunicazione, laddove il comando capitalistico è letteralmente deserto. Perché il capitale è tanto più astratto quanto più permette che di esso si “abbiano” delle immagini sempre più parcellizzate ed ipertrofiche. Insomma, Horror vacui senza un fuori. Così accade che gli operatori del movimento d’estetizzazione dell’immaginario – politico-istituzionale, già nelle analisi di Benjamin, spettacolare poi in Debord – si con-fondano e distendano sull’intero corpo sociale, nel momento stesso in cui – oggi definitivamente, secondo Negri – l’unità di misura del valore abbraccia la dismisura (leggi eccedenza) della vita (lavoro vivo). Ed ecco che l’intensità dell’atto percettivo-visuale, l’intensità del sensibile – per natura, sperimentale, vitale, puro bios – rischia di girare a vuoto, laddove viene atomizzato e sussunto dalla valorizzazione economicistica: merce ideativa diffusa piuttosto che pura attività liberata.
Questo, naturalmente, è effetto di un cattivo comune creativo, la tendenza dentro e contro la quale è necessario rivolgere potenze affermative molteplici capaci di accordo (cooperazione).
 Ora, proprio in relazione alla costituzione di un piano di composizione che superi dall’interno questa tendenza, è interessante notare che dalla raccolta delle lettere negriane (postuma e ri-editata con integrazioni), emerga non già una qualche elaborazione strutturata, data come un a priori, una volta per tutte; e questo non per via della frammentarietà del corpus epistolare. Tutt’altro: si ha la netta sensazione dell’articolazione di una doppia metamorfosi, di un divenire pienamente immerso nell’evento intempestivo del presente e nondimeno – e dunque proprio per questo – capace di coglierne non solo le trappole, le ambiguità (ad esempio, la figura del mostro nella trasformazione macchinica dei soggetti), ma soprattutto le aperture costituenti, le tensioni espressive alla giuntura dei germinali modi di vita di un comune possibile. Da un lato, sotto traccia e in modo nietzschiano – si direbbe – abbiamo una “transavalutazione” biopolitica che travalica l’universo artistico, e dunque le concrezioni egotiche cristallizzate nell’autoreferenzialità delle enclave istituzionali pubblico-private e dei soggetti che vi partecipano a vario titolo; dall’altro, l’affermazione metastabile del motore d’ogni azione etica possibile: l’emozione.
Ora, proprio in relazione alla costituzione di un piano di composizione che superi dall’interno questa tendenza, è interessante notare che dalla raccolta delle lettere negriane (postuma e ri-editata con integrazioni), emerga non già una qualche elaborazione strutturata, data come un a priori, una volta per tutte; e questo non per via della frammentarietà del corpus epistolare. Tutt’altro: si ha la netta sensazione dell’articolazione di una doppia metamorfosi, di un divenire pienamente immerso nell’evento intempestivo del presente e nondimeno – e dunque proprio per questo – capace di coglierne non solo le trappole, le ambiguità (ad esempio, la figura del mostro nella trasformazione macchinica dei soggetti), ma soprattutto le aperture costituenti, le tensioni espressive alla giuntura dei germinali modi di vita di un comune possibile. Da un lato, sotto traccia e in modo nietzschiano – si direbbe – abbiamo una “transavalutazione” biopolitica che travalica l’universo artistico, e dunque le concrezioni egotiche cristallizzate nell’autoreferenzialità delle enclave istituzionali pubblico-private e dei soggetti che vi partecipano a vario titolo; dall’altro, l’affermazione metastabile del motore d’ogni azione etica possibile: l’emozione.
È proprio G. Simondon – altro incontro in filigrana dell’autore – a dirci che “L’emozione è il senso dell’azione; […] struttura topologicamente l’essere; si prolunga nel mondo in forma di azione, così come l’azione si prolunga nel soggetto in forma di emozione. […] L’emozione è al confine tra l’essere individuale e il collettivo”. E ancora che “Il versante dell’azione esprime la spiritualità che nasce dal soggetto e si determina come eternità oggettiva, monumento più duraturo del bronzo, linguaggio, istituzione, arte, opera. Il versante dell’emozione esprime la spiritualità che pervade il soggetto, si riversa in esso e lo colma nell’istante presente, rendendolo simbolico ai suoi stessi occhi, speculare a se stesso, tale da comprendere sé in riferimento a ciò che lo invade”1.
L’emozione dunque come vettore energetico informale che nell’immanenza della vita la estende ricaricandola ogni volta letteralmente, così da aprire i soggetti all’espressività di un processo di composizione il cui esito è per natura aperto e molteplice. Ed è qui che il problematico con la sua costituente positività incontra le formule, piuttosto che le forme, di organizzazione del collettivo.
Ma se il binomio emozione-azione è per natura soggetto a vibrazioni istantanee che si dispiegano sulla membrana dell’essere, come renderlo duraturo, come dargli consistenza? È affare etico, di creazione, di invenzione del comune, ci dice Negri; ed è così che a partire dall’arte la si può eccedere nella sua specificità – cogliendone non già le forme fattizie (gli oggetti-merce), quanto piuttosto i potenziali, i vettori (in senso fisico, meglio micro-fisico), l’aspetto sovversivo – per fare della vita intera un’opera d’arte2.
Questo tema foucaultiano è ripreso in modo cogente nell’ultima lettera indirizzata al curatore del testo, Nicolas Martino, laddove se ne coglie la transizione verso una prassi politica che abbia come dispositivo di senso la costruzione consistente di una moltitudine autodeterminata, senza intermediazione alcuna, causa sui, che possa permettere, pertanto, di superare la vita dei soggetti ripiegati su se stessi e al contempo la dimensione autoriale del fare arte.
E allora se è vero che l’arte non è separabile dalle fasi storiche dei modelli produttivi del capitale nel suo costituente rapporto sociale – avendone talvolta colto le spinte dialettiche3 (dal paleocapitalismo, nel realismo pittorico francese, al postfordismo neoliberale, nella frammentarietà performativa, archeologica delle tracce eteroclite contemporanee), talaltra, ripiegandovisi miseramente (certa produzione Belle Époque o certo iperrealismo ipertrofico post-human) – quale condizione di possibilità interno al suo fare ha mosso l’immaginario collettivo prodotto nel tempo e che ancora oggi, al netto della creazione di un piano d’astrazione, ne identifica il suo limite?
In altre parole, e su un piano geologico, qual è l’invariante carsica che continua a sgocciolare nelle valli del mondo dell’arte tanto da costituire la principale fonte di nutrimento dei soggetti posti ai suoi bordi?
Verrebbe da dire, la metafisica dell’identità con la sua aleturgia celeste, la rappresentazione. E non è affare da poco.
Innanzitutto, c’è un potere nella narrazione dell’arte che ha sempre coinciso con l’immanente ricerca e collezione di identità d’autore. Persino talune magnifiche corali manifestazioni del fare artigiano rischiano di passare al vaglio della lente di ingrandimento messa in atto da quella procedura “botanica” (alla Linneo) che chiamiamo storia dell’arte: ci sarà sempre uno studioso, peggio, un esperto, un acuto curioso o un bizzarro osservatore che scoprirà dietro un monogramma/cifra/segno identificativo – inscritto sul più piccolo supporto-reperto – l’aleturgia della rappresentazione di sé, sdoppiata in quell’immagine rivelata cui si darà paternità.
Terribile storia della veridizione artistica per un pubblico di spettatori-lettori e per vecchi e nuovi artisti, tanto più astratti quanto più identificabili con il loro oggetto-feticcio.
Orbene, grazie alla pelle parrhesiastica di Foucault che incontra Nietzsche sentiamo di dover approfondire quanto su detto nel seguente modo: come dietro alla “forma” della conoscenza incontriamo rapporti di potere4, così accade che nel luogo di intersezione della percezione con l’ideazione, c’è forse qualcosa di artefatto, una pericolosa costruzione metafisica che chiamiamo identità, incardinata nei postulati della rappresentazione; postulati come palafitte del potere dell’Io che su questi s’accresce edificando miraggi. Ed è così che ognuno ha (stricto sensu) le sue visioni. Effetto ottico di potere, appunto.
Eppure qualcosa di potente, di impercettibile, fugge, desiderando e lavorando nella direzione dell’oblio del medesimo.
Le condizioni di una vera critica e di una vera creazione sono le stesse: distruzione dell’immagine di un pensiero che si presuppone a sua volta, genesi dell’atto di pensare nel pensiero – ci ricorda Deleuze; condizioni che il filosofo francese mette in moto scandagliando il fondo melmoso generatore dell’immagine del/nell’identico sul quale si impiantano i postulati platonici: cogitatio natura universalis, concordia facultatum come modelli del riconoscimento, della rappresentazione, del negativo, della proposizione designante (luogo della verità), della modalità, della subordinazione dell’apprendere al modello istituzionale del sapere e della cultura.5.
 Una contro-effettuazione, quella di Deleuze, che ritrova, pertanto, attraverso la differenza senza volto nel pensiero le armi per cercare di avversare le forme di potere dell’identico. È soltanto in questo senso che ogni forma ideativo-visiva è già rappresentazione.
Una contro-effettuazione, quella di Deleuze, che ritrova, pertanto, attraverso la differenza senza volto nel pensiero le armi per cercare di avversare le forme di potere dell’identico. È soltanto in questo senso che ogni forma ideativo-visiva è già rappresentazione.
Sul versante del sensibile, pertanto, risalire dalla percezione6 al percetto comporterà la stessa faticosa avventura, in una sorta di coalescenza con il concetto. Se l’idea è differenza in quanto pura molteplicità, produzione concatenante di formule subrappresentative (nel senso di procedimenti in divenire), energia in quanto liberazione di potenze nel soggetto, il percetto non potrà che riposare sulle forze invisibili della sensazione come modulazione di affetti, pre-individualità fluttuanti.
Ora, è soltanto a queste condizioni e con le cautele del caso che è possibile praticare la differenza nell’idea e le ecceità nella vita sensibile, prese in uno stesso movimento capace di oscurare quel luogo che le aliena – l’identità – e di donare così senso all’azione etica, la quale riuscirebbe a conservarsi avocando a sé la comunanza. Intenso apprendistato di una vita.
Ecco perché è indispensabile superare questo rapporto inscindibile identità-rappresentazione, questa dualità che non è altro che processo di territorialità bloccata, enclosure normativizzante che impedisce al principio di individuazione (Simondon) di confluire nello spazio del comune.
Non ci si meravigli pertanto di incorrere in curiose dichiarazioni d’artista che tentano di tenere insieme rappresentazione e Stato all’interno di una goffa prospettiva democratica. L’immaginazione di Alfredo Pirri arriva a dire che si può parlare di Stato solo se lo “s’intende come la forma maggiormente rappresentativa di quelle identità in gioco che sommate fra loro, assumono i caratteri di una moltitudine e di un popolo e tutti noi sappiamo come sia proprio l’atto artistico, per la sua capacità di inglobare caratteri differenti, quello che maggiormente ne ha caratterizzato (fino a oggi) l’identità e di come questa, grazie all’arte, possa oggi intendersi come apertura democratica e dinamica e non sclerotica difesa di una forma fissata per sempre”. E di seguito aggiungere: “Sono convinto, ad esempio, che l’assonanza dei termini rappresentanza e rappresentazione ci indichi qualcosa in più di un semplice sillogismo. Quest’assonanza ci suggerisce che un’arte fondata sulla mancanza totale e ultimativa di ogni forma di rappresentazione porti a creare un’astrattezza (più che un’astrazione artistica) e una distanza dalle cose che mette radicalmente in crisi la necessità stessa di ogni rappresentanza politica”7.
Si è ahinoi ancora imbrigliati nelle forme, nelle strutture e dunque nelle categorie inerenti la sfera dell’arte, e ha davvero poca importanza distinguere l’astrattezza dall’astrazione, quando la prima in realtà è già all’opera sui nostri corpi separati e la seconda – con tutte le seppur splendide variazioni del caso – è già patrimonializzata nel circolo vizioso dei caveau della proprietà privata e delle istituzioni democratiche.
Naturalmente, non è casuale il fatto che la rappresentazione vada a braccetto con la forma-stato.
Restando al di qua del “recinto” artistico, anche il filosofo Alain Badiou, partendo da sofismi neoplatonici inciampa nella rappresentazione di Stato quando afferma che vi è una profonda implicazione dello Stato nel teatro: “Il teatro, infatti, rappresenta: rappresenta la rappresentazione, non la presentazione. Lo Stato, non l’emergere del suo spazio. È la cerimonia di tutte le cerimonie. Esso non comincia fino a quando la libertà (politica, greca) di giudicare la rappresentazione è immanente alla condizione dell’arte. Autorizza se stesso a rappresentare la rappresentazione – dell’Idea, dunque (in senso platonico). Tutto il teatro è teatro delle Idee. […] Ma impossibilitato a mostrare la rivoluzione, stretto nelle pieghe dello Stato, il teatro non è l’unica arte a stabilire una visibilità dello Stato? La sola arte che mostra lo Stato? Di cosa parla il teatro se non dello stato dello Stato, dello stato della società, dello stato della rivoluzione, dello stato delle coscienze relativamente allo Stato, alla società, alla rivoluzione, alla politica?”8.
Certo, come non dargli ragione se la maggior parte delle pratiche teatrali da tempi immemori, oramai, si son date alla dialettica dialogante, re(s)citante, dello spettattore critico a teatro,9 o alle riedizioni aggiornate del format della tragedia sofoclea (Edipo re), con i suoi effetti di luce aleturgici (potere oracolare e insieme dei soggetti-testimoni)?10.
Forse, però, ci si dimentica di quello spazio “biologico” intermedio (secondo la dynamis aristotelica), tra epos lirico e tragedia, lì dove l’improvvisazione di coloro che davano inizio al ditirambo, accompagnava l’attore/poeta, in virtù di un processo cultuale in onore di Dioniso: un canto a solo (monodia) si muoveva in musica con il coro, le performances erano buffonesche e una danza sfrenata segnava emblematicamente l’ebbrezza del dio.
Ma tutto ciò non ci soddisfa ancora. Evidentemente Badiou sceglie la strada maggioritaria (la rappresentazione allo specchio), salta a piè pari le singolarità minoritarie che hanno eluso lo stigma dello Stato: Marlowe, Meyerhold, Artaud, Living Theatre, Carmelo Bene…
A questo proposito ci viene in mente quanto Deleuze dice del teatro di variazione e sottrazione (minorazione) operati dalla macchina attoriale c.b.: “Il potere proprio al teatro è inscindibile da una rappresentazione del potere nel teatro, anche se è una rappresentazione critica. Quando sceglie di “amputare” gli elementi del potere, egli [Carmelo Bene – NdC] cambia non soltanto la materia teatrale, ma anche la forma del teatro, che cessa d’essere “rappresentazione”, mentre l’attore cessa d’essere attore”. Non basta lo sforzo intellettuale del teatro popolare di Brecht, dove le contraddizioni, le opposizioni sono “comprese” – seguita a chiarirci, perché passeremmo da un polo drammatico della rappresentazione borghese a un polo epico della rappresentazione popolare; perché il teatro resta rappresentativo ogni qualvolta prende come oggetto i conflitti che sono già normalizzati, codificati, istituzionalizzati. Sono dei “prodotti”.
Ed ecco, secondo il filosofo, la necessità di far subire agli elementi teatrali, che incarnano la rappresentazione di Stato (testo a monte e suoi personaggi: i principi, i re, i padroni, il sistema, etc., la regia, l’attore, la scenografia), un trattamento minore o di minorazione, per sprigionare dei divenire contro la Storia, delle vite contro la cultura, dei pensieri contro la dottrina, delle grazie o delle disgrazie contro il dogma11.
Sicché, ciò a cui perviene c.b. è piuttosto una scrittura di scena, più simile ad una partitura musicale, poiesis; tutto il contrario di una forma di rappresentazione, di una manifestazione di verità; il suo è un teatro del buio e dell’oblio di sé che inghiotte qualsiasi regime di visibilità.
Eppure, non ci illudiamo. Materialisticamente sentiamo quanto sia difficile dipanare le relazioni di potere, quanto sia vischioso il terreno sul quale camminiamo; insomma, quante azioni moltitudinarie – ancora rinchiuse nella sfera dell’arte e dell’inventività diffusa – si perderebbero (eteronomia dei fini, suggerisce Negri12), fintantoché si trascuri la forza alienante “dell’immagine di un Io prima dell’Io, di un Io presupposto a se stesso, inafferrabile” – chiosa Paolo Virno, altrove13.
E allora si tratta ancora una volta e con la necessaria prudenza di tracciare linee di invenzione. Lo spinozismo di Negri, a braccetto con amore, ci fa segno mentre traccia il luogo e le possibilità dell’individuo sociale. Questo luogo non può che essere la sfera pubblica non statale, dove le azioni virtuosistiche dell’arte si possano prolungare, diluendovisi, nell’ethos di una più complessa attività-senza-opera qual è la vita collettiva14.
Attraverso la formula epistolare, Negri pertanto costruisce una macchina astratta che fa filare il bello nel comune, dove arte è un altro modo di dire della moltitudine. Le lettere non sono altro che le pieghe, la flessione del suo pensiero mentre traccia il piano di esteriorità: la gioia nella cooperazione, la dynamis del comune come ontologia della liberazione dalle relazioni di potere, dalle sue aleturgie visive, dai suoi buchi neri fabbricatori di identità.
È qui che l’arte sensibile all’evento del comune dimentica davvero la “firma d’autore” in tutte le sue forme di riconoscimento (cristallizzazione dell’identità che si auto-rappresenta), e può fare definitivamente a meno del gesto critico celebrato (catturato) dal sistema dell’arte. Pena le stoccate in odor di paradosso di economisti del capitale umano alla Pierluigi Sacco che, mentre discetta di etichette di transizione tra (post-)duchampiano e (post-)beuysiano, può beffardamente dire: “Stiamo abbandonando le ordinate e rassicuranti collezioni di reliquie disseccate e ben allineate sotto vetro, segno evidente di una concezione esistenziale ritentiva e avara di sentimenti, di una necessità di controllo che neutralizzi ogni reale interferenza, per tornare al rischio di piantare alberi, di doverli (volerli?) curare quotidianamente, di confrontarsi cioè con una dimensione di senso che non si può sterilizzare, classificare, patrimonializzare, e che richiede invece di esporsi in prima persona, di mettere in gioco le proprie ragioni esistenziali, di accettare la scommessa (e la vulnerabilità emotiva) del provare a far vivere le cose, piuttosto che di imparare il mestiere di farle morire con eleganza”. E dopo aver preso a schiaffi l’identità artistoide (bersaglio facile, nevvero?), con una chiusa finale degna di un uomo scafato che sa di poter disporre ancora di parecchi anni di carriera davanti a sé, può candidamente dire: “Ma la mia sensazione è che il nuovo panorama, così diverso, così lontano da tutto questo, sia già davanti ai nostri occhi, anche se facciamo ancora fatica a percepirlo – non fa ancora parte della nostra Gestalt. Riparliamone tra dieci anni”.15.
Nel fra-tempo, a titolo di esempio in progress – e su un piano di intersezione tra arte, critica teorica, tecnologia e attivismo politico forse ancora sdrucciolevole (perché liminare a talune istituzioni culturali) – abbiamo le pratiche del Critical Art Ensemble, collettivo che sfrutta le falle presenti nelle inter-zone della produzione capitalistica, attraverso azioni biologiche dirette come atti di resistenza all’imperio dell’industria biotecnologica. Riportiamo quanto affermano sulle modalità delle loro azioni, che definiscono sabotaggio fuzzy: “Il sabotatore fuzzy sta in equilibrio sulla linea ambigua tra il legale e l’illegale (penale e civile). Da questa posizione un individuo o un gruppo possono innescare una catena di eventi in grado di portare al risultato desiderato. L’azione iniziale, l’unica cioè con cui il sabotatore dovrebbe avere un nesso causale diretto, dovrebbe essere più legale possibile e auspicabilmente rispettosa dei diritti di ogni individuo. Più sono gli anelli della catena, meglio è da un punto di vista legale, anche se aumentare i passaggi causali incrementa la difficoltà di controllare tutte le variabili che, in crescita esponenziale, potrebbero compromettere l’azione. La maggior parte di queste azioni avrà solamente due fasi: l’atto legittimo o fuzzy e il conseguente scombussolamento. Le autorità avranno il difficile compito di dimostrare l’illegalità di un atto indiretto, compito ingrato per i pubblici ministeri. In definitiva, il sabotare fuzzy, al contrario della Dc [Disobbedienza civile – NdC], non richiede né uno scontro fisico con l’autorità né, in molti casi, alcun tipo di infrazione legale”.16.
Vacuolizzazione17 inerziale, anonimia collettiva, variazione intensiva, consonanza delle singolarità, ecco alcune delle illimitate posture di una utopia possibile.
Un non-luogo che è già (in) azione: Non aspetteremo dieci anni!
Dedicato all’invisibile moltitudine che eccede questo scritto.
Gilbert Simondon, L’individuazione psichica e collettiva, DeriveApprodi, 2001. pag. 112. ↩
“Quello che mi colpisce, è il fatto che nella nostra società l’arte sia diventata qualcosa che è in relazione soltanto con gli oggetti, e non con gli individui, o con la vita. E che l’arte sia qualcosa di specializzato, e che sia fatta da questi esperti che sono gli artisti. Ma perché la vita di tutti gli individui non potrebbe diventare un’opera d’arte?”, Michel Foucault, Sulla genealogia dell’etica: compendio di uno work in progress, [À propos de la généalogie de l’ètique: un aperçu du travail en cours, in Dits et écrits, 2 voll. Gallimard, 2001, II, pp. 1428-50], in Dreyfus-Rabinow, La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente, Ponte delle Grazie, 1989, pp. 264-265. ↩
Nella lettera all’artista Manfredo Massironi “Sul lavoro collettivo”, Negri prova a tracciare (pp. 42-43) quella che lui stesso definisce “grossolana corrispondenza fra epoche contemporanee dell’attività artistica e forme dell’organizzazione del lavoro”, partendo proprio dal realismo francese (fase appropriativa della lotta rivoluzionaria dell’operaio di mestiere), per poi passare all’impressionismo (fase analitica e di controllo della produzione capitalistica da parte dell’operaio professionale), al costruttivismo ed espressionismo sovietico (fase dell’astrazione del lavoro), via via fino alle prime ricerche astratte più spinte e sperimentali italiane, francesi e americane degli anni Sessanta-Settanta (fase delle continue crisi del modo di produzione capitalistico), fino all’irruzione della Pop art (fase dell’operaio-massa). Giusto qualche nome: Daniel Buren e il gruppo Support/Surface (Francia), Robert Ryman e poi Barnett Newman, Mark Rothko e Ad Reinhardt (America), i minimalisti italiani Francesco Lo Savio, Giuseppe Uncini, Piero Manzoni, Enrico Castellani, Mario Nigro, Piero Dorazio.
Nella panoramica negriana andrebbe forse aggiunto il momento weimariano del Bauhaus come curiosa fucina che anticipa, di qualche lustro, l’unione tra operaio come unità di impresa (scuola ordoliberale) e investimento in capitale umano (scuola di Chicago).
Va detto, altresì, che su un piano strettamente teorico e con un impianto squisitamente semiotico, il ventennio dell’astrattismo fu accuratamente analizzato dal critico Filiberto Menna, che addirittura individua nella scomposizione “atomica” del gesto pointelliste di Georges Seurat, la filogenesi di ciò che chiama la linea analitica dell’arte moderna (titolo di un suo saggio del 1975). ↩Nella post-fazione a Del governo dei viventi (Feltrinelli, 2014, pp. 340-341), il curatore Michel Senellart ricorda il manoscritto del corso di Foucault intitolato “Teorie e istituzioni penali ” in cui il filosofo, riprendendo un’analisi inaugurata nei primi anni ’70 (Lezioni sulla volontà di sapere), dice: “Dietro alla “forma” della conoscenza, dietro al segreto della conoscenza, al campo aperto di ciò che bisogna conoscere, al corpus delle conoscenze acquisite, dietro a tutto questo ci sono dei rapporti di potere”. ↩
Per l’intera analisi che Deleuze dispiega sui postulati della rappresentazione, vedi il capitolo “L’immagine del pensiero”, in Differenza e ripetizione, Raffaello Cortina, 1997, pp. 169-217. ↩
Secondo G. Simondon, Percepire è mettersi di traverso [relazione tra il soggetto e il mondo]: senza questo gesto attivo, che presuppone l’internità del soggetto al sistema in cui si pone il problema percettivo, la percezione non sarebbe possibile (op. cit., pp. 97-98). ↩
Alain Badiou, Il Teatro, ovvero la dichiarazione dello Stato, in alfabeta2, qui. ↩
Nonostante alcuni studiosi abbiano ravvisato eccessi dionisiaci nell’analisi filologica nietzschiana, ne La nascita della tragedia il filosofo è puntuale: “Ma volendo determinare in tutta brevità, e senza la pretesa di dire con ciò qualcosa di esauriente, quello che Euripide aveva in comune con Menandro e Filomone, e che agiva per questi ultimi in modo così eccitante ed esemplare, è sufficiente dire che lo spettatore fu portato da Euripide sulla scena”: Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia, Adelphi, 2000, pag. 76. ↩
In Del governo dei viventi, Foucault sin dalla seconda lezione analizza il rapporto stretto tra la forma della tragedia greca e le procedure di veridizione, tra i personaggi portatori di gradienti di potere e l’obbligo di manifestazione del vero. Prendendo in esame l’Edipo re, egli ravvisa il circolo stringente di temi che strutturano la tragedia: relazione tra manifestazione di verità ed esercizio del potere, necessità di una verità che si manifesta nella forma della soggettività e effetto di questa manifestazione che va ben al di là dei rapporti utilitaristici della conoscenza. In sintesi, l’oracolo di Delfi, Creonte, Edipo, Tiresia, i due servi (con le loro testimonianze parziali e complementari) partecipano a vario titolo alla produzione aleturgica del potere tirannico. Infine, rispetto a quanto si diceva, ovvero al rapporto tra effetto ottico di potere dell’identità (l’Io) e sua manifestazione nella rappresentazione (forma della tragedia), è interessante notare ciò che Foucault dice all’inizio della lezione del 30 gennaio: “[E] la manifestazione della verità, come dimostra la tragedia di Sofocle, non può essere [completa], il cerchio dell’aleturgia non sarà del tutto chiuso finché non sarà passato per quegli individui che possono dire “io”, per gli occhi, le mani, il ricordo, la testimonianza, l’affermazione di uomini che dicono: ero lì, ho visto…” (op. cit., pp. 81-82). ↩
Carmelo Bene, Opere, Bompiani, 1995: Gilles Deleuze: Il teatro e la sua critica; Il teatro e le sue minoranze, pp. 1431-1436. ↩
Frase tratta dall’ultima lettera al curatore Nicolas Martino, “Sul comune”, nella quale Negri individua, in termini marxiani, i limiti interni alla produzione inventiva del comune fintantoché i soggetti del General Intellect saranno sussunti dalla divisione tecnica della produzione capitalistica. ↩
Estratto da: Leggere Gilbert Simondon, intervista di Jun Fujita Hirose a Paolo Virno pubblicata su sito della rivista multitudes, qui. ↩
Per lo sviluppo di questo periodo che fa filare Marx attraverso la lente tornita spinoziana e le lezioni aristoteliche, ci si è rifatti ai concetti espressi da Paolo Virno in Grammatica della moltitudine – Per una analisi delle forme di vita contemporanee, DeriveApprodi, 2014, pp. 39-42 e 73-74. ↩
Estratto di un articolo pubblicato sulla rivista Flash Art dal titolo: Il paradosso del valore, aprile 2010, n. 282, pp. 76-77. L’economista e professore universitario Pierluigi Sacco ne è uno dei collaboratori. Bocconiano, è figura di spicco nella cerchia dei promotori lombardi dell’economia della conoscenza con le sue strategie di governance del capitale umano. Tanto per aver un’idea del frasario cool adoperato dall’esperto, si riporta quanto egli scrive nel capitolo: La nuova economia della conoscenza pubblicato per i tipi della Meltemi nel testo da lui curato dal titolo Il fundraising per la cultura: “Il successo dei modelli di distretto culturale evoluto si fonda, in ultima analisi, sulla capacità di governance dei processi di accumulazione delle nuove forme di capitale intangibile: il capitale umano e informativo connesso alla produzione di nuove conoscenze e al loro consolidamento individuale e collettivo, il capitale sociale connesso alla sedimentazione di norme di comportamento che permettano alle persone e alle comunità di realizzare forme di mediazione intelligente tra l’interesse proprio e quello di una collettività più ampia, il capitale identitario connesso alla costruzione di un repertorio simbolico e ideale che identifica il sistema locale e che è in grado di trasferirsi credibilmente ed efficacemente nei manufatti, nelle esperienze e negli stili di vita che esso produce”, qui. ↩
Tratto da: Sabotaggio biologico fuzzy, Critical Art Esemble, alfaDisobedience – speciale di Alfabeta2, giugno 2013-n^ 30, pag. 8. ↩
Questo processo legato alla dilatazione del vacuolo durante lo sviluppo delle cellule vegetali lo abbiamo mutuato dall’intervista di Negri a Deleuze Contrôle et devenir, in G. Deluze, Pourparlers, Minuit, 1990, pp. 229-239 (in precedenza in Futur antérieur, printemps 90, leggibile qui). Il vacuolo è una sorta di cisterna a forma di sacca, posta sul limite interno delle cellule, indispensabile nell’interscambio tra ambiente e piante. Ora, sebbene il vacuolo sia più pieno che “vuoto” (è difatti ricco di ioni minerali, acidi, etc. in soluzione acquosa), Deleuze impiega questo termine nel senso etimologico (da vacuum, vuoto), attribuendogli valore di pausa, intermezzo. Per chiarezza, ecco il passo in cui Deleuze risponde: “Vous demandez si les sociétés de contrôle ou de communication ne susciteront pas des formes de résistance capables de redonner des chances à un communisme conçu comme « organisation transversale d’individus libres ». Je ne sais pas, peut-être. Mais ce ne serait pas dans la mesure où les minorités pourraient reprendre la parole. Peut-être la parole, la communication, sont-elles pourries. Elles sont entièrement pénétrées par l’argent: non par accident, mais par nature. Il faut un détournement de la parole. Créer a toujours été autre chose que communiquer. L’important, ce sera peut-être de créer des vacuoles de non-commmunication, des interrupteurs, pour échapper au contrôle”. ↩