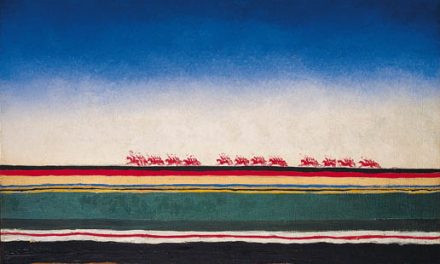di BENEDETTO VECCHI.
La coerenza è un elemento che va sicuramente incoraggiato in un presente opaco e segnato da repentini cambiamenti del punto di vista di chi lo interroga criticamente. Talvolta, però, la coerenza induce a semplificazioni e a riprodurre pregiudizi che poco fanno comprendere l’analisi critica che viene proposta. È questo il caso di Carlo Formenti nel testo pubblicato su alfabeta2 qualche giorno fa relativo all’analisi del libro La Rete. Dall’utopia al mercato di chi scrive, pubblicato da manifestolibri. Esprimo l’imbarazzo che anima questa risposta, perché quando si scrive un testo ci si espone all’analisi di chi lo legge. La critica, anche feroce, fa parte delle modalità di comunicazione dentro la sfera pubblica.
È il rischio e, cosa più importante, funzione propria della discussione pubblica far emergere punti di vista tra loro diversi e conflittuali tra loro. Carlo Formenti manifesta il fatto che il libro lo ha letto con attenzione. Di questo non posso che essere contento, indipendentemente dalla critiche dure espresse senza le odiose e talvolta ipocrite cerimonie del bon ton: i suoi argomenti vanno al di là del libro e investono il tema, caro ad entrambi, dello sviluppo di un punto di vista adeguato alla critica del capitalismo contemporaneo, dopo il lungo inverno della controrivoluzione neoliberista e della crisi radicale che ha investito i rapporti sociali emersi da quella controrivoluzione. Per questo penso che una risposta alla sue critiche possa essere espressa.
Seguendo il filo della sua riflessione, sono due i temi che emergono con forza: lo stato dell’arte del cosiddetto postoperaismo, la Rete come esemplificazione dei rapporti sociali contemporanei. Infine, Carlo Formenti ripropone l’antico quesito del “che fare?” e dei soggetti sociali trainanti una possibile ricomposizione delle pratiche politiche di movimento. Tre campi tematici intrecciati. Parto dal primo, che nell’economia del testo di Carlo Formenti occupa molto spazio. Su questo elemento il dissenso è radicale, a partire dalla convinzione che il postoperaismo non esiste, è una semplificazione usata come una clava per stigmatizzare prassi teoriche tra loro divergenti e talvolta incompatibili.
L’operaismo, a scanso di equivoci, si può dire concluso alla fine degli anni Sessanta, quando intellettuali e militanti protagonisti dell’esperienza di alcune riviste si sono divisi, intraprendendo strade diverse. Dell’operaismo è rimasto un metodo di analisi e un’attitudine ad andare oltre le culture politiche del movimento operaio, sia nella sua componente comunista che in quella socialista. Diverso è il caso – ma qui servirebbe una rivisitazione storica, genealogica direbbero i foucaultiani – di chi ha indagato tra gli anni Ottanta e Novanta le trasformazioni del capitalismo e del lavoro vivo, mettendo al centro dell’analisi la categoria del general intellect.
Non ho remore a dire che con questa esperienza ho a che vedere e non ho difficoltà ad ammettere che ho usato come elementi della cassetta degli attrezzi categorie come, appunto, general intellect, moltitudine, cooperazione sociale produttiva, lavoro vivo. Non occorre tuttavia essere un filologo per segnalare la differenza tra chi parla e scrive di lavoro autonomo di seconda o terza generazione e chi invece gli preferisce l’uso del termine, generico e approssimativo, di precarietà diffusa. Come non ricordare, inoltre, le critiche di Sergio Bologna al reddito di cittadinanza, proposta invece fatta propria, articolata, agita da chi vede nella precarietà la dimensione “normali” dei rapporti tra capitale e lavoro vivo. Nell’articolo di Formenti le diverse posizioni sono invece accomunate per dare sostanza a un j’accuse contro il postoperaismo, un fantasma che si aggira solo nelle pagine e nei testi di chi malinconicamente guarda al capitalismo come alla hegeliana fine della storia, sospettando di chiunque si misura, per combatterlo, con le piccole o grandi trasformazioni che hanno segnato negli ultimi decenni il regime del lavoro salariato.
Da parte mia posso dire che la moltitudine non è una categoria sociologica, come sostiene ritiene Formenti, che qui si ritrova in compagnia di Aldo Bonomi e Enzo Rullani, bensì è una categoria che attiene al Politico, che registra come il lavoro vivo sia indisponibile a ricomposizioni giacobine dall’alto e che la singolarità è un fattore da usare politicamente per costituire nuovi rapporti sociali. Detto più banalmente, più che rappresentare la composizione sociale della forza lavoro, la moltitudine è un terreno per una prassi teorica, e dunque politica, tesa a immaginare organizzazioni politiche adeguate a una lavoro vivo en general, indisponibile a ricomposizioni imposte dall’alto, da un chissà quale partito che althusserianamente produce la classe per sé, dopo aver definito quella in sé.
Lascia inoltre interdetti la sottolineatura di Formenti sulla mia (inesistente) rimozione delle gerarchie e stratificazioni che caratterizzano i soggetti produttivi contemporanei. Scrivendo della Rete come esemplificazione dei rapporti sociali, segnalo semmai come il capitalismo contemporaneo si nutra di differenze e come il governo del mercato del lavoro tenda a scomporre e ricomporre le gerarchie all’interno del lavoro vivo, stabilendo politicamente linee di frattura del colore, del sesso, della prestazione lavorativa. Per dirla più semplicemente, il capitalismo postfordista non ha all’orizzonte nessun equivalente dell’operaio massa.
Tanto i knowledge workers che i lavoratori dei servizi che gli operai della fabbriche globali più che conoscere processi di ricomposizione provocati da un processo produttivo come quello tayloristico esperiscono il fatto che la capacità di innovazione, di sviluppare cooperazione produttive, sono sussunte dal capitale attraverso anche la moltiplicazione delle differenze e delle gerarchie del lavoro vivo, prodotte per via politica – qui il diritto svolge una funzione essenziale – o alimentandole.
Le forme di lavoro sono diventate ormai un caleidescopio dove lavoro autonomo, lavoro servile, salariale classico sono compresenti e regolati giuridicamente. Per svelare l’arcano degli ateliers della produzione serve inchiesta militante, uso spregiudicato di differenti campi disciplinari – etnografia, la sociologia, la filosofia del linguaggio – al fine di sondare quell’osmosi tra stili di vita e collocazione produttiva che è parte integrante dei processi di socializzazione nel capitalismo flessibile. La grammatica della moltitudine, per citare il titolo di un libro di Paolo Virno, serve ad immaginare e sperimentare forme politiche adeguate a questa frammentazione del lavoro vivo.
Siamo però su un terreno già disossato e arato. Quello che manca è produrre forme politiche meno legate alla contingenza, che facciano però tesoro degli elementi acquisiti in questo lungo vagare nel deserto della controrivoluzione neoliberista. Per Formenti, invece, quello che è sperimentazione, prassi teorica in divenire è solo una sommatoria di fallimenti. Scambia cioè l’amara materialità dei rapporti di forza con il rovello di chi quei rapporti di forza li vuole rovesciare. Da qui la sua nostalgia di quando tutto era meno opaco, scivoloso, ambivalente. La sua è la stessa realpolitik espressa dagli orfani e dalle vedove del quarto stato che invocano – povero Antonio Gramsci – il pessimismo della ragione da contrapporre all’ottimismo della volontà di chi vede nello sciopero di alcune fabbriche cinesi l’alba di un nuovo ciclo di lotte. Una lettura più attenta delle analisi provenienti da quelle latitudini indurrebbero a una maggiore cautela, ma tutto va bene per inventare la quinta colonna del nemico all’interno dei movimenti, variamente dipinti come liberali di sinistra, collusi con il capitale e chi più ne ha più ne metta. .
E fallimento, nostalgia, persino l’accusa di liberalismo mimetico c’è nell’analisi che fa di come nel libro affronto la Rete. Su questo crinale, gli abbagli la fanno da padroni. Senza cadere nella pedanteria, non mi ritengo un nostalgico dell’etica hacker, né mi sono mai spellato le mani per l’anarcocapitalismo. Allo stesso tempo non sono un fan della tecnopolitica à la Manuel Castells. Più prosaicamente ho sempre ritenuto che la Rete sia l’esito di una convergenza tra attitudine hacker, attitudine al controllo sociale, visione neomanageriale della comunicazione. Sono tutti elementi che hanno contribuito allo sviluppo della Rete, dove il conflitto è stato permanente.
Quello degli hacker contro il regime della proprietà intellettuale, quello dei ricercatori contro la volontà dei militari di dirigere le ricerche di base e applicate, quello contro la volontà dei governi, in particolar modo quello di Washington, di usare la Rete come infrastruttura tecnologica per il business. Non ho difficoltà a dire che mi erano e mi sono simpatici gli hacker. Irriverenti, insofferenti alle gerarchie e al comando, insomma dei ribelli, ma non certo dei rivoluzionari. Ho solo registrato che molte delle innovazioni e delle modalità di cooperare sono state fatte proprie dalle imprese. Anche se l’attitudine hacker è riuscita a riproporsi con Anonymous e l’esperienza di Wikileaks. Qui il termine che meglio esprime l’attitudine hacker è ambivalenza: nell’attitudine hacker, infatti, non è mai stato contemplato il superamento del capitalismo. Ultimi simboli di quel “comunismo dei ricercatori” caro a Robert K. Merton, hanno solo agito conflitto dentro la Rete.
È questo conflitto che ho sempre privilegiato, perché apriva un ampio spettro di possibilità a una azione politica dentro la Rete. Le mitologie della frontiera elettronica e dei cow boy della consolle sono fattori divertenti, che ho anche usato polemicamente verso chi, nel campo dei movimento, considera Internet un abbaglio, ma non ho certo mai pensato che il cyberspazio fosse la terra promessa o l’utopia realizzata. Anche qui ho registrato come l’anarcocapitalismo fosse qualcosa di più che un esercizio di retorica: l’anarcocapitalismo è l’ideologia nemica che punta all’innovazione più che alla conservazione, che ha supportato tutte le operazione politiche e manageriali che hanno puntato a sovvertire la costituzione materiale del capitalismo industriale. Anche in questo caso, la posta in gioco era, ed è almeno per il capitale, la “cattura”, cioè la sussunzione della capacità innovativa del lavoro vivo nella rete. Ma che ha fatto dei contenuti della comunicazione online, indipendentemente dalla loro qualità, un florido settore produttivo.
Dunque controllo sociale, normatività delle modalità della comunicazione, ma anche segmentazione e proliferazione delle diversità: la trasformazione dei social network in una sommatoria di tribù di simili non presenta nessuna smagliatura rispetto al controllo esercitato da imprese e stati nazionali. La dimensione libertaria dell’anarcocapitalismo può inoltre contemplare l’eclissi della proprietà privata, così come può contemplare l’affermazione radicale dei diritti alla diversità, ma la vision anarcocapitalista poco a che vedere con il regno della libertà. Semmai è la gabbia, che può essere anche dorata, di quel regno della necessità che continua a macerare e triturare bisogni e desideri di uomini e donne. Fa sorridere il ricordo di chi invocava l’alleanza tra l’imprenditore smart e il lavoratore della rete per sconfiggere i guerrieri e il vecchio e marcescente capitalismo industriale. Internet non è più un mondo a parte, è il media universale sognato nei tempi andati: è dunque tecnologia del controllo, ma anche habitat dove il conflitto tra lavoro vivo e capitale assume forme inedite. È a queste forme inedite che occorre applicare sguardo critico, innovando la cassetta degli attrezzi.
E qui si giunge infine al quesito del “che fare?”, meglio dei soggetti produttivi su cui fare leva. Certo non quel regno dell’imponderabile che sono gli “impoveriti”, ma neppure la salvezza verrà dagli operai di linea delle fabbriche cinesi, non così diversi dai professional o di chainworkers. Meglio: la salvezza potrà venire dal lavoro vivo en general, dunque dalla classe operaia industriale, dai chainworkers, dai professional, dai knowledge workers. A patto però che si riesca a produrre contesti dove tutte le forme del lavoro vivo possano condividere la loro condizione di sfruttamento al fine di creare luoghi dove organizzarsi socialmente e politicamente per superare il regime del lavoro salariato.
Luoghi cioè dove la miseria del presente non impedisca che la ricchezza del possibile si trasformi in azione politica contro il regime di accumulazione capitalistica. Anche questo è liberalismo mimetico? Ne dubito. È solo una scommessa squisitamente politica, e dunque teorica, da giocare.
Questo articolo è stato pubblicato su alfabeta2 il 12-07-2015