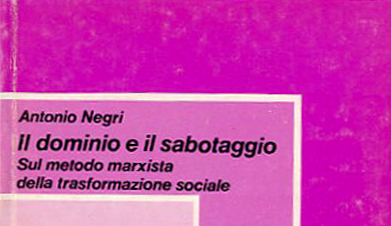di EMANUELE LEONARDI e UGO PIAZZA
Considerate come ‘pulsazioni’ del pianeta,
le esposizioni vanno misurate nei loro intervalli
e nelle loro intensità,
nelle loro scelte territoriali
e nelle loro politiche celebrative,
sino a ricomporre andamenti sincronici e diacronici
di un apparato in cui ‘lavoro concreto’
e ‘lavoro astratto’ trovano soluzioni ‘esemplari’
estremamente articolate e profondamente legate
agli automatismi ma anche alle derive
della società meccanica.
Alberto Abruzzese1
Si è finalmente concluso il grande circo mediatico dell’EXPO milanese, dedicata al tema Nutrire il pianeta, energia per la vita. Non siamo affatto certi che il trionfalismo governativo sarà confermato da un’attenta lettura dei dati, né che la patata bollente del post-esposizione sarà gestita in maniera adeguata e trasparente. Si tratta di problemi seri e urgenti, cui i movimenti No EXPO non potranno sottrarsi. In questo breve intervento2 vorremmo tuttavia focalizzare l’attenzione su tre elementi più generali, in grado forse di fornire all’ondata informativa che si appresta a travolgerci un contesto storico di riferimento, uno sfondo capace di dare senso politico al mega-evento dell’anno.
1. EXPO 2015 come lente analitica sul neoliberalismo
Le esposizioni universali non sono soltanto enormi fiere dello stupore applicato al processo produttivo. Esse sono anche rappresentazioni simboliche, vere e proprie messe in scena dello sviluppo capitalistico: se interrogate da questa prospettiva sanno raccontare di come si produce la ricchezza, di chi la crea e a quali condizioni, di come circola e si moltiplica – oppure si distrugge. Scrivendo a proposito della prima great exhibition, quella di Londra del 1851, Marx e Engels si rendono perfettamente conto di come essa sia “una prova lampante del potere concentrato grazie al quale la grande industria moderna sta smantellando ovunque le barriere fra nazioni e sta facendo sfumare, sempre di più, le differenze locali di produzione, società e carattere nazionale fra i popoli […] Con questa esposizione la borghesia mondiale ha eretto il proprio Pantheon nella Roma moderna, dove – con compiaciuto orgoglio – esibisce gli dei che si è fabbricata”3 .
Possiamo dunque concepire il Crystal Palace londinese (1851) o la Tour Eiffel di Parigi (1889) come apoteosi del Progresso, dell’industria pesante e della cosiddetta età dell’oro della borghesia. Ma possiamo anche utilizzare la successione storica delle EXPO come lente analitica sulla modalità industriale del conflitto capitale-lavoro e delle sue convulse trasformazioni. Luca Massidda suggerisce per esempio di leggere le EXPO dei trenta gloriosi post-bellici come teatralizzazioni della Guerra Fredda (in particolare Bruxelles 1958) e celebrazioni dell’organizzazione fordista del lavoro e della società di massa (specialmente Osaka 1970)4. Dopo una morte apparente più che ventennale – prosegue Massidda – le esposizioni universali tornano alla ribalta per mettere in scena la rivoluzione neoliberale e la produzione del comune: la network society a Siviglia 1992, la metropoli biopolitica a Shanghai 2010, la natura come driver di valorizzazione a Hannover 2000 e a Milano 2015. Vale la pena soffermarsi su quest’ultimo punto perché segna un forte elemento di discontinuità rispetto al ciclo fordista delle EXPO. Se ancora nel 1967, a Montréal, il tema da affrontare è Terre des hommes, narrazione della battaglia antropocentrica per l’appropriazione tecnologica dell’ambiente – la cui posta in gioco è il benessere umano da strappare prima e quindi difendere –, i temi delle EXPO del XXI secolo sapranno assumere il limite ecologico non più come barriera all’accumulazione capitalistica, bensì come opportunità di investimento ad alto margine di profitto. Si tratta del peculiare anti-naturalismo neoliberale, ovvero di uno spazio di creazione di valore in cui le pratiche di sfruttamento non si danno sull‘ambiente, bensì passano attraverso di esso. È, in altri termini, la retorica della green economy, cioè della compatibilità dolce – anzi, del mutuo sostegno – tra rendimenti finanziari e salubrità degli eco-sistemi, tra l’agri-business delle multinazionali e le esperienze di sovranità alimentare. Nel caso di Milano 2015 questo aspetto ha assunto i toni parossistici del progetto di Orto Globale, cioè del fiore all’occhiello del concpetual masterplan del 2009 – capolavoro di retorica della sostenibilità: quasi inutile rimarcare che di esso non è rimasta alcuna traccia.5 E non è tutto: si pensi alla scelta di Coca Cola e McDonalds come sponsor principali, mentre la visibilità per coloro che effettivamente nutrono il pianeta – cioè i contadini del mondo – è ridotta all’osso.6 Curiosissimo, infine, il fatto che un po’ di potenziale nutrimento – oltre mille ettari di suolo agricolo – sia stato sommerso di cemento per costruire il sito espositivo e le tre opere autostradali indicate come connesse a EXPO (Pedemontana, BreBeMi e tangenziale Est esterna).7
2. Expo 2015 come vettore di spoliazione.
Proviamo ora ad analizzare la natura dei processi di produzione e accumulazione di valore territoriale catalizzata dall’EXPO milanese. Le sue peculiarità rispetto ad altri mega-eventi – quali i giochi olimpici o i mondiali di calcio – riguardano la fusione tra la dimensione tangibile di opere ed infrastrutture necessarie alla celebrazione dell’evento e la rappresentazione simbolica di forme e contenuti di una fase specifica dello sviluppo capitalistico. La realizzazione di opere e infrastrutture ad alto valore simbolico, culminate nella realizzazione del sito espositivo vero e proprio, ha funzionato però anche da catalizzatore di una serie di trasformazioni territoriali direttamente ed indirettamente connesse, finalizzate alla produzione ed accumulazione di valore in forme dirette. Intorno a EXPO si è infatti animato un quadro articolato di iniziative pubbliche e private che si sono allineate comunicativamente alla narrativa dell’evento, anche se nella maggior parte dei casi non hanno mantenuto particolare coerenza con le sue stesse premesse di sostenibilità, rivelandosi mere appropriazioni di risorse pubbliche e beni comuni.
Due piani apparentemente contraddittori caratterizzano i processi di produzione e accumulazione di valore territoriale di EXPO: da un lato la produzione di valore attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture – trainate da ingenti investimenti pubblici – che si sono irradiate sul territorio dell’area metropolitana milanese a partire dalla realizzazione del sito espositivo, con impatti significativi sulla vita degli abitanti dello spazio urbano direttamente interessato.
Dall’altro lato troviamo la produzione e disseminazione di una nuova narrazione territoriale volta a riposizionare l’immagine del territorio, ad attrarre flussi turistici e ad attivare processi di sviluppo8. Tale narrazione viene generata a partire dai temi centrali della sostenibilità alimentare e tradotta in una riedizione greenwashed di brand territoriali pre-esistenti. Si intende qui la messa in opera di un complesso dispositivo di comunicazione e disseminazione di narrazioni territoriali che è servita soprattutto a ridefinire l’immagine di Milano verso lo scenario internazionale, ma che tuttavia presenta una influenza diretta su percezioni ed usi dello spazio urbano da parte dei suoi abitanti.
Come interagiscono queste due dimensioni? In che misura l’operazione di greenwashing del brand-Milano (e più in generale del made in Italy) si riflette nello sviluppo di coerenti progetti urbanistici destinati a durare oltre l’evento? Oppure: quanto tutto ciò serve solamente da ombrello di legittimazione di più spicce operazioni predatorie di risorse pubbliche e beni comuni? In che modo le trasformazioni innescate da EXPO hanno modificato e modificherà l’uso dello spazio da parte degli abitanti, includendo in questa definizione anche turisti e visitatori che hanno attraversato ed attraverseranno l’area milanese?
Allo stato attuale è possibile osservare alcune tendenze generali che si sono manifestate a partire dalla lunga fase di preparazione dell’evento, che si possono riassumere in:
1) Produzione di valore territoriale a partire dal nucleo principale di interventi urbanistici sostenuti da un grande investimento pubblico a fondo perduto (con relativo trasferimento di risorse pubbliche verso operatori privati);
2) Iniziative speculative sul mercato immobiliare locale, seppur contenute ed attutite da condizioni contestuali sfavorevoli (trend del mercato immobiliare locale negativo);
3) Lo sviluppo di una strategia di marketing territoriale che ha potuto contare su un diffuso consenso sociale ed è stata sostanzialmente in grado di allineare soggetti eterogenei alla narrazione mainstream dell’evento;
4) Una serie di tentativi di mettere a profitto funzioni e usi dello spazio preesistenti nel quadro della strategia di place-marketing orientata dai principi guida dell’evento.
La letteratura sui più recenti mega eventi ha ampiamente fatto uso del concetto di “accumulazione per espropriazione” [accumulation by dispossession], proposta da David Harvey per descrivere la natura prevalentemente “estrattiva” delle forme di produzione di valore territoriale che li caratterizzano9. Come evidenziato da Miguel Mellino in un recente articolo10, dietro questa nozione ci sono una serie di nodi problematici che investono da un lato la definizione marxiana del concetto di accumulazione originaria e, dall’altro, l’insistenza sulle linee di esclusione sociale generate da questa forma neo-primitiva di accumulazione violenta che, “a differenza dell’accumulazione originaria del passato, non espande il dominio dei rapporti capitalistici a ogni segmento della società, anzi, finisce per estromettere dal vincolo capitalistico una parte importante della popolazione umana”.
Da questo punto di vista è lecito interrogarsi su quanto questa chiave di lettura sia realmente in grado di rappresentare l’eterogeneità delle forme di produzione di valore messe in campo attraverso EXPO 2015. Certamente l’accento posto sulla violenza dei mezzi rende “accumulazione per espropriazione” una formula utile ad evidenziare la natura predatoria del capitalismo neoliberale ed efficace per descrivere le forme di spoliazione dei beni comuni che ha caratterizzato per esempio i mondiali di calcio in Sud Africa e Brasile, così come i giochi olimpici 2016 che si terranno a Rio de Janeiro. Sebbene con una violenza di intensità molto differente, anche l’EXPO milanese ha sicuramente comportato forme di espropriazione dei beni comuni tangibili come nel caso delle aree del sito espositivo. Allo stesso tempo EXPO ha però rappresentato un laboratorio per produzione e messa a profitto di narrazioni territoriali che sono state costruite anche grazie al coinvolgimento attivo della società locale, mettendo il territorio e i suoi abitanti al servizio della produzione di beni intangibili.
Lo sfruttamento della dimensione intangibile dello spazio urbano in EXPO può essere osservata lungo due linee complementari: da un lato tramite la costruzione dall’alto di una rappresentazione simbolica del territorio che ospita l’evento intorno a cui organizzare gli interventi urbanistici catalizzatori. Dall’altro attraverso la messa a profitto di funzioni e usi dello spazio preesistenti costruiti socialmente da abitanti e visitatori che possano essere compatibili o funzionali alla costruzione della nuova narrazione del territorio.
EXPO è infatti stata soprattutto l’occasione per lo sviluppo di una strategia di place-marketing per Milano. Inoltre ha coinvolto attivamente e passivamente le istituzioni e la società locale nella ridefinizione dell’immagine della città a partire dalle proprie parole chiave. L’obiettivo prioritario di questa strategia è innanzitutto l’incremento dei flussi turistici nazionali ed internazionali, che rappresentano una delle leve economiche principali dell’intera operazione di EXPO.
La costruzione narrativa della Milano di EXPO, supportata fortemente da investimenti di comunicazione istituzionale, ha spinto ad allinearsi tutta una serie di settori dell’economia milanese. Da questo punto di vista è bene ricordare l’importanza del settore espositivo e più in generale di quello della produzione creativa nell’economia del territorio milanese, ambiti che sono stati in gran parte cooptati nella costruzione di una strategia di marketing territoriale allargata.
Allo stesso tempo la narrazione di EXPO ha tentato di appropriarsi di identità territoriali preesistenti cercando di metterle a valore, come nel caso del progetto delle “Vie d’acqua”11, dove si è cercato di modificare in senso “folkloristico” la funzione del sistema di canali e navigli della provincia est milanese integrandola alla narrazione sostenibile dell’evento.
A conclusione di questa rapidissima disamina è bene osservare come anche dal punto di vista degli organizzatori il valore aggregato delle componenti intangibili (Turismo e Legacy immateriale) superi di gran lunga la capacità produttiva degli investimenti direttamente rivolti alla realizzazione di opere e infrastrutture (Tabella 1). Questo dato conferma la necessità di proseguire nei prossimi mesi ad indagare le trasformazioni urbane introdotte da EXPO proprio a partire dalla complessa relazione tra produzione di immaginario territoriale e trasformazione urbana.
Tabella 1. I Valori di EXPO12
| Investimento iniziale |
Aumento totale di produzione |
Aumento totale del pil |
Aumento totale di occupazione |
|
| Infrastrutture expo |
1.30 |
3.60 |
1.00 |
16900.00 |
| Costi gestione |
0.90 |
2.40 |
0.60 |
10200.00 |
| Investimenti esteri |
1.00 |
2.80 |
0.70 |
13000.00 |
| Flussi turistici |
8.80 |
3.80 |
73700.00 | |
| Legacy |
6.20 |
2.50 |
47400.00 | |
| Totale |
3.20 |
23.80 |
10.1 |
191.2 |
3. EXPO 2015 come laboratorio di nuovo sfruttamento
C’è un ulteriore aspetto dell’EXPO milanese che ci interessa prendere in considerazione: il suo ruolo di terreno di sperimentazione per nuove forme di sfruttamento. Da questo punto di vista la fiera che sta per concludersi ha valore paradigmatico, rappresenta cioè il destino che attende milioni di lavoratori sullo sfondo di una crisi che pare cronicizzarsi ogni giorno di più. Un destino non scontato – sta ai movimenti scongiurarlo – che tuttavia incombe minacciosamente. In estrema sintesi, ciò che il laboratorio EXPO 2015 ha testato sul corpo vivo della società è il lavoro gratuito come condizione normale dell’attività produttiva. Andrea Fumagalli ha definito il modello del lavoro gratuito come “un martello in grado di scolpire un nuovo sistema delle relazioni industriali in Italia”13, concepito originariamente dal Protocollo di Luglio del 2013 (siglato da EXPO S.p.a. e CGIL, CISL e UIL) e infine generalizzato dal Jobs Act. Il Protocollo di Luglio è un documento importante perché istituzionalizza la derogabilità in peggio dei trattamenti economici e normativi assicurati dalla legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Tale accordo, in buona sostanza, non solo prevede l’indebolimento della forza contrattuale del lavoro retribuito (che la fiera ha creato in misura assai minore rispetto alle attese) ma prevede il ricorso legale e massivo (18.500 unità) a forme di lavoro definite “volontarie”.
L’aggettivo è tuttavia fuorviante: ai sensi della legge quadro166/1991 art.1, infatti, per “volontariato” s’intende una “espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo […] per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale”. Ora, dal momento che a nessuno è sfuggito che EXPO S.p.a. abbia il lucro come finalità principale – se non unica – ne deriva che la scelta lessicale sia del tutto impropria: non di volontari si sta parlando, ma di lavoratori non retribuiti14. Tuttavia la questione non è solo terminologica: sebbene i numeri si siano ridotti rispetto alle previsioni del Protocollo di Luglio, si tratta pur sempre di 7500 unità suddivise nei vari programmi predisposti da EXPO (Volunteers, Civil Society Participants, Servizio Civile Volontario, DoteComune, Progetto Scuola)15. Insomma, l’occupazione creata dal mega-evento è quasi interamente costituita da prestazioni gratuite – che oltretutto rendono superflue quelle retribuite (per esempio quelle fornite da guide, interpreti e personale fieristico), il che conferma la diagnosi di Sergio Bologna, secondo cui “l’economia dell’evento non crea posti di lavoro ma li distrugge”16.
Questo dato di fatto suggerisce una riflessione che non è possibile sviluppare compiutamente in questa sede, ma che ci pare importante quantomeno indicare. La diffusione capillare di ciò che Marco Bascetta definisce una “vasta area di disretribuzione”17 segnala la crisi del salario come istituzione cardine e campo di mediazione privilegiato tra soggetti produttivi. A quale condizione poteva funzionare, infatti, la società salariale? A patto di mantenere l’alterità irriducibile tra chi sul mercato del lavoro vende la propria forza lavoro (in cambio, per l’appunto, di un salario) e chi invece l’acquista (cioè anticipandolo, quel salario). È la differenza di natura tra lavoratori e imprenditori. Ci pare che il paradigma del lavoro gratuito si regga su presupposti molto diversi. Qui il salario non funge da pagamento di una subalternità (declinabile in moltissimi modi, però una), bensì da investimento sul proprio capitale umano, su se stessi in quanto imprese. I lavoratori non esistono più: ci sono tutt’al più imprenditori che ancora si trovano incastrati nelle rigidità del lavoro salariato. Insomma: la retorica della employability (“occupabilità”) come forma contemporanea del pieno impiego.
Questo passaggio ci sembra davvero significativo: se il salario è il prezzo da pagare per una subordinazione, per una differenza costitutiva nello scambio, allora può essere il terreno d’incontro tra le classi sociali che a quello scambio partecipano. Ma se invece il salario diventa reddito da capitale umano, ecco che ognuno si trova nella possibilità di gestirlo individualmente in piena “libertà”, di investirvi quote variabili di tempo e denaro – a seconda delle proprie condizioni sociali e delle proprie inclinazioni. Una forma particolare di capitale, non il suo “altro”. Come hanno giustamente osservato Marco Assennato e Toni Negri, “l’asimmetria tra capitale e lavoro, fondativa del giuslavorismo della seconda metà del novecento, scompare o si scioglie nel mito di individue parti equivalenti in un regime pluralistico”18.
È su questo sfondo che possiamo cominciare a comprendere cosa spinge una persona a “lavorare per nulla”19, per usare l’efficace espressione di Andrew Ross. Si tratta della convinzione di stare operando un investimento strategico su se stessi come impresa, cioè di stare acquisendo competenze in grado in un futuro non meglio precisato di garantire un ritorno monetario alle proprie prestazioni lavorative. Qui entrano in gioco tanto la promessa di un impiego a venire (Bascetta) che la necessità di conquistarsi uno spazio di visibilità per non essere esclusi dai network che contano, cioè working for exposure (Ross), lavorare in cambio di una remunerazione puramente simbolica. È sempre qui, però, che dobbiamo giocare la partita della lotta allo sfruttamento capitalistico: uno sfruttamento che sempre più mostra, accanto ai dispositivi della sussunzione e del salario, una logica inedita che imprime nei soggetti l’imperativo della competitività perpetua tra imprenditori di se stessi.
A. Abruzzese (1990), “Estetiche del conflitto e del potere”, in Quaderni Di – Le esposizioni del ‘900 in Italia e nel mondo, vol. 11, Liguori, Napoli. ↩
Si tratta della prima tappa di un cantiere d’inchiesta che proseguirà nei prossimi mesi. ↩
Si veda https://www.marxists.org/archive/marx/works/1850/11/01.htm (traduzione nostra). ↩
L. Massidda (2011), Atlante delle grandi esposizioni universali, Franco Angeli, Milano. ↩
Da un’articolo del marzo 2011, dedicato alla cancellazione del progetto Orto Globale: “L’Expo 2015, ricordiamolo, era stata inizialmente concepita come un grande orto globale, dove i vari paesi avrebbero dovuto mettere in scena letteralmente le colture del mondo: il trait d’union della manifestazione sarebbe dovuto essere il tema della sostenibilità, attuale oggi come tra quattro anni fa in un Pianeta dove la popolazione cresce e le risorse diminuiscono” [disponibile online: http://www.tuttogreen.it/expo-2015-addio-allorto-globale-e-ora/]. ↩
Si veda EXPO Zero, supplemento de Il manifesto, 1 Maggio 2015. ↩
Si vedano W. Bukowski (2015), “Come ce l’hanno data a bere parlando di mangiare”, in Shock Press n. 15; e G. Montanari (2015), “Nutrire il pianeta con il cemento: un grande evento e il suo impatto sul territorio”, in Expo 2015: il cibo che affama, Luce, Torino. Segnaliamo inoltre i vari numeri dell’utilissimo Pieghevole di contro-informazione messi a punto da Off Topic. ↩
Maria I. Simeon e Giovanni Di Trapani, “Mega Eventi e creazione di valore per il territorio: un’analisi delle Esposizioni Universali e Internazionali,” Sinergie Rapporti Di Ricerca, 2012. ↩
Ad Esempio: Luanda Vannuchi and Mathieu Van Criekingen, “Transforming Rio de Janeiro for the Olympics: Another Path to Accumulation by Dispossession?,” Articulo-Journal of Urban Research, no. Special issue 7 (2015); Kristoffer Olofsson and Vítor Peiteado Fernández, “Accumulation by Dispossession through Sports Mega-Events: The Case of Vila Autódromo and the Creation of the Rio 2016 Olympic Park,” 2014. ↩
Miguel Mellino (2014), “David Harvey e l’accumulazione per espropriazione”, in Euronomade. ↩
Si veda “#NOCANAL STORIA DELLA LOTTA CHE HA MESSO A NUDO EXPO”, di OffTopic. ↩
EXPO 2015 spa, “Rapporto di sostenibilità,” 2013. ↩
A. Fumagalli, “Il Jobs Act è legge: dal lavoro precario al lavoro gratuito passando dalla destituzione del potere legislativo”, in Effimera. ↩
Si veda D. Vitale, “Le nuove frontiere del lavoro gratuito”, intervento al convegno Le promesse del capitale. La precarietà al tempo del lavoro gratuito, tra EXPO e Jobs Act, Università Ca’ Foscari, Venezia, 4 Maggio 2015. ↩
Per un’analisi critica dettagliata del lavoro gratuito a EXPO 2015 si veda R. Ciccarelli (2015), “Volontari all’EXPO: I dannati dell’evento”, in AAVV, Economia politica della promessa, Manifestolibri, Roma. ↩
S. Bologna (2015), “Lavoro gratuito ed economia dell’evento”, in C. Morini e P. Vignola, Piccola enciclopedia precaria, Agenzia X, Milano, p. 81. ↩
M. Bascetta (2015), “L’economia politica della promessa”, in Euronomade. ↩
M. Assennato e T. Negri (2015), “Deficienza del sindacato europeo”, in Euronomade. ↩
A. Ross (2014), “Lavorare per nulla: l’ultimo dei settori produttivi ad alta crescita”, in Commonware. ↩