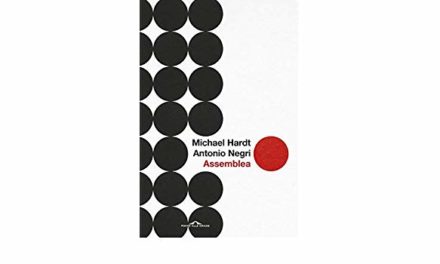di MIMMO SERSANTE.
La potenza della vita inautentica
A leggere oggi Essere e tempo[1], in particolare alcune sue pagine (penso al cap. V della prima parte dedicato alla situazione emotiva che l’uomo si trova a vivere), la sensazione è quella di essere gettati senza troppi complimenti dentro una realtà che conosciamo bene. Nella vita inautentica e deietta analizzata in quelle pagine ritroviamo la nostra forma di vita oggi, dopo che tutti gli sforzi collettivi per cercare di cambiarla sembrano falliti.
Da parte sua Heidegger non aveva dubbi in proposito: la deiezione (Verfallen), scriveva, è una determinazione esistenziale di cui non possiamo liberarci perché qualifica il nostro rapporto quotidiano con il mondo. Heidegger, come sappiamo, sceglie accuratamente le sue parole chiave nel vocabolario greco e latino. Questo sostantivo deriva dal tardo latino deiectionem che noi oggi traduciamo tranquillamente con defecazione, feci, escrementi. Il verbo d’origine è deicere, che in latino significa gettare giù, gettare fuori. Per Heidegger (§38) la deiezione è una sorta di moto vorticoso in cui precipitiamo per scendere al livello delle cose. Così la nostra espressione vita di merda acquista un sapore particolare se ripensata in quest’ottica heideggeriana. Solo che per Heidegger questa vita di merda riguarda un po’ tutti perché per l’Esserci l’effettività dell’esistenza è per l’appunto il suo essere gettato nel mondo a contatto con gli altri e con le cose che Heidegger chiama gli strumenti utilizzabili.
Nessun progresso della civiltà umana potrà pareggiare i conti, né oggi né domani.
Dunque questa vita fattizia, vale a dire una vita vissuta in modo impersonale e inautentico, subita piuttosto che scelta, è l’altro nome per dire la realtà effettiva, il mondo nel quale siamo naturaliter immersi. Il che significa che una vita siffatta non sta a indicare una caduta, una perdita del sé autentico, come credevano i comunisti del ’900: noi ci troviamo già sempre in una situazione in cui siamo presi nelle nostre faccende.
Mutatis mutandis: siamo assuefatti al capitalismo allo stesso modo dell’esserci inautentico di Heidegger che si trova a proprio agio nella tranquilla intimità dei suoi rapporti quotidiani.
Heidegger scriveva queste cose nel 1927 e da allora niente sembra cambiato.
Oggi sono le nuove generazioni segnate dalla controrivoluzione liberista a riconoscere pertinente il termine con cui Heidegger definiva la vita del tedesco medio durante gli anni venti: nebulosità ma, contemporaneamente, sono queste stesse generazioni a intravedere nella vischiosità della nebbia la possibilità di essere quello che Essere e tempo voleva che fossimo: intrinsecamente progettanti, capaci di realizzarci come possibilità.
La contraddizione è solo apparente. Basta non prendere sul serio le pagine che Heidegger dedica all’esistenza autentica e restare sordi al richiamo della morte che la voce della nostra coscienza fa risuonare affinché l’essere autentico dell’esserci si svegli dal suo sonno. La fuga nell’interiorità non ci salva. Se poi di esistenza autentica si vuole comunque parlare, facciamolo pure senza però dimenticare quanto afferma lo stesso Heidegger: “l’esistenza autentica non è qualcosa che si libri al di sopra della quotidianità deiettiva; esistenzialmente, essa è soltanto un afferramento modificato di questa”[2].
Comunque sia, liberarsi dell’esistenza inautentica non è facile. Ne sapeva qualcosa l’antica saggezza cristiana alla quale pare ispirarsi anche il Nostro[3]. Che il commercio col mondo nella forma del prendersi-cura delle cose, fino a comprendere l’aver-cura degli altri, comporti l’oblio di se stessi, è un’idea che Heidegger tira fuori da lì. Caduta e peccato per certo pensiero cristiano, modificazione della cura autentica e oblio di se stessi per Heidegger. Soltanto così può aver luogo il perdersi, da parte dell’esserci, nel mondo di cui si prende cura per rivolgere l’attenzione unicamente alla manipolazione attiva degli utilizzabili. Ma se il lavoro resta una condanna da espiare, esso in un qualche modo ci salva tanto è vero che alla fine ritroviamo noi stessi proprio in ciò che facciamo e di cui abbiamo bisogno.
Marx aveva trovato un suo concetto per dire il dominio incontrastato del capitalismo. Parlando di sussunzione reale aveva pensato al lavoro sociale fagocitato dal capitale e perciò a una vera e propria coniazione capitalistica dell’essere sociale. È un motivo in più per prendere sul serio l’invito heideggeriano di accettare questo orizzonte e di essere cauti, molto cauti nel prospettare l’eventuale via di fuga.
Per riassumere: il legame tra l’inautentico e l’autentico in Essere e tempo “è così intimo e originale”[4] che l’esistenza autentica non ha altro contenuto che l’esistenza inautentica. Trovarci nella condizione di essere dispersi e sperduti nelle varie maniere decise dalla dittatura del Si impersonale e anonimo è la nostra forma di vita oggi perché la diversione evasiva è il primo tratto della fatticità.
Riconoscere tutto questo con disincanto e realismo è segno di onestà intellettuale.
L’esistenza anonima è quella di tutti e di nessuno e questa ovvietà non fa scandalo; è anche l’esistenza in cui il si «dice» o il «si fa» domina incontrastato e anche questa è una verità ovvia. L’importante è leggere in questa miseria tutta la potenza della vita inautentica perché in essa si agitano, come dice Virno, “segmenti di sapere sociale accumulato, paradigmi teorici, knowledge immediatamente comunicabile”[5].
Essere e tempo dunque come l’utile cassetta degli attrezzi per le nuove leve del lavoro immateriale e cognitivo, protagoniste delle lotte dell’ultimo ventennio. Il che significa tornare a sfogliarlo alla luce delle trasformazioni radicali che in questi ultimi vent’anni hanno stravolto il modello fordista di produzione e l’assetto della società keynesiana.
Nel lettore non distratto Essere e tempo ha sempre prodotto effetti contrastanti perché intenzionalmente lo inchioda “al sentimento della propria situazione”[6] costringendolo a incontrare se stesso nella forma della fuga oppure in quella della ricerca. Paradossalmente ci sembra che quest’ultima via vada cercata proprio nelle figure dell’esistere inautentico, proprio in quei luoghi, come dice Virno, noti e diffamati ma atti a ricostruire le linee di una moderna esperienza individuale[7].
È su questo versante che oggi registriamo l’attualità di Heidegger.
Prendiamo a mo’ di esempio il tratto più caratteristico della vita inautentica: la chiacchiera, modo della deiezione dell’essere quotidiano del Ci, e forma diretta di stravolgimento della funzione autentica del linguaggio.
Per Heidegger infatti il linguaggio è per sua natura lo svelamento dell’essere, ciò in cui l’essere stesso si esprime e prende corpo[8]. Ma “il linguaggio è l’espressione del discorso”e il discorso “è l’articolazione della comprensibilità”[9], dice il mondo in cui viviamo, spiegando e interpretando tutto ciò che nel mondo ci viene incontro, le cose e i nostri simili. In particolare nel linguaggio “l’utilizzabile è scoperto come tale nella sua utilizzabilità, nella sua inspiegabilità, nella sua dannosità”[10].
La significatività[11] del mondo “non è altro che la scoperta sempre rinnovata dell’ente intramondano sotto il profilo della sua«appagatività» strumentale”[12]. Le parole “attraverso cui il discorso acquista un proprio essere «mondano»”, che dicono il mondo, – e sono esse stesse disponibili come utilizzabili[13] – rinviano dunque al lavoro, nel linguaggio di Heidegger al commercio che usa e manipola.
Il linguaggio diventa chiacchiera inconsistente quando questo rapporto con l’ente di cui si discorre si spezza; così il linguaggio si priva della sua referenzialità mentre il discorso comunicante si autonomizza,
fondandosi esclusivamente sul “si dice” e obbedendo all’assioma “le cose stanno così perché così si dice”[14].
Heidegger, pur prendendo atto che della chiacchiera non possiamo liberarci perché “costituisce il modo di essere della comprensione e dell’interpretazione dell’Esserci quotidiano”[15], la considera comunque una chiusura verso la comprensione articolata del mondo e un coprimento dell’ente intramondano.
Eppure la chiacchiera, se preclude a una comprensione autentica, “diffonde una comprensione indifferente, per la quale non esiste più nulla di incerto”[16]. Che significa? Per Virno questa analisi heideggeriana della chiacchiera getta una luce nuova sul modo di produrre attuale e sulla composizione tecnica della nuova forza lavoro. Infatti nella produzione postfordista il linguaggio ricopre un ruolo determinante; concerne direttamente il lavoro e la produzione sociale. Il postfordismo ha messo al lavoro il linguaggio. Al lavoratore, sostiene Virno, è richiesto un agire comunicativo informale, duttile, in grado di far fronte alle più diverse eventualità; a venire attivata è la stessa facoltà del linguaggio più che la sua specifica applicazione. Questa generica potenza di articolare ogni sorta di enunciazioni acquista un rilievo empirico proprio nella chiacchiera informatica. Lì, infatti, non conta tanto che-cosa-si-dice, quanto il puro e semplice poter-dire[17].
Heidegger arcade?
Heidegger scrive Essere e tempo tra il 1925 e il 1927 nella Germania di Weimar, a metà di un decennio che, a riattraversarlo oggi, ci scorre davanti agli occhi affascinante e drammatico. Eppure nulla di quegli anni traspare in quest’opera come pure in altre sue opere del decennio.
Almeno all’apparenza infatti sembra più preoccupato a salvaguardare “la solitudine delle montagne [che] tiene l’anima più che mai lontana da ogni turbamento e cruccio dell’esistenza [… mentre] il lavoro ha la stessa regolarità del colpo d’ascia di un boscaiolo che risuona in lontananza nel bosco”. Parole d’amore[18] che sembrano confermare però una vecchia idea secondo cui l’evoluzione di Heidegger sarebbe avvenuta in un ambiente politicamente asettico, unicamente interessato a questioni di filosofia (professore a Friburgo nel periodo 1915-1923; professore a Marburgo tra il 1923-1927; professore a Friburgo al posto di Husserl dal 1928). Possibile che il filosofo della comprensione ordinaria della storia, della storicità dell’Esserci e della storia universale[19]sia rimasto insensibile di fronte agli avvenimenti che tra il ’18 e il ’33 fecero della Germania un vero e proprio laboratorio della crisi europea?
Non un cenno, ad esempio, non una parola, sulla rivoluzione e la controrivoluzione dell’immediato dopoguerra. Eppure si trattò di una sofferta guerra civile, ora aperta, ora strisciante, combattuta e persa dalla classe operaia tedesca, a cui seguì (1921-1923) un’inflazione dirompente che portò il valore del marco a livelli così catastrofici da indurre gli storici a parlare di morte della moneta. Silenzio, anche, sul periodo della Rational-sierung del ciclo 1924-1929 che restituisce alla Germania un profilo sociale stabilizzato e l’immagine di un paese a elevato grado di industrializzazione, con un proletariato estremamente esteso e una classe media modernizzata. È come se oggi il filosofo ignorasse tutta la serie di cesure che hanno squassato la nostra modernità e accelerato il passaggio al capitalismo cognitivo con la tendenziale egemonia del lavoro immateriale. Eppure qualcosa di simile era accaduto nella Germania di Weimar in quegli anni. La rivoluzione dall’alto che il capitale riuscì a condurre in Germania dopo la stabilizzazione del marco produsse, come si accennava, la massificazione della classe operaia e l’introduzione delle linee di montaggio nelle fabbriche.
Si trattò di una rivoluzione forse meno appariscente di altri fenomeni che invece furono registrati nel mentre accadevano e di cui troviamo traccia nella descrizione heideggeriana del mondo della vita inautentica. È facile scorgervi una critica alla massificazione e all’inurbamento, al nervosismo della vita pubblica, alla potente ascesa dell’industria dei divertimenti, alla quotidianità febbrile, al qualunquismo di terza pagina in cui scade la vita spirituale. Certamente tutti questi elementi confluiscono nella descrizione heideggeriana di un esserci che non vive del suo proprio poter-essere.
Heidegger e la rivoluzione conservatrice
Ora, a proposito del rapporto di Heidegger con la Germania di Weimar si è detto di tutto e di più. Su un punto estimatori e detrattori concordano: posizionare l’autore di Essere e tempo tra i teorici della rivoluzione conservatrice o del modernismo reazionario. Ce lo ricorda Remo Bodei nella bella Introduzione al libro di Adorno sulla filosofia tedesca della seconda metà degli anni venti, Il gergo dell’autenticità[20]. Heidegger sarebbe una sorta di àrcade con in testa e nel cuore la campagna e la provincia, oasi di idillica serenità, avulse dal mondo moderno. La lettera alla Arendt confermerebbe questa tesi per gli anni venti, altri documenti sarebbero lì a dimostrarla vera per gli anni successivi.
Se il ricordo di Heidegger del suo vecchio amico contadino che lo sconsiglia di accettare l’offerta di una cattedra prestigiosa a Berlino ci fa sorridere, più meditata è certamente la conclusione della Premessa a Saggi e discorsi del 1954: “Mentre il pensiero rappresentativo corrente –scrive Heidegger–, […] vuole sempre andare avanti e trascina con sé ogni cosa, i cammini dell’indicazione aprono talvolta una prospettiva su un unico massiccio, un unico raccolto riparo (Ge-birg)”[21]. Nel termine Ge-birg (riparo) che alla lettera significa massiccio, riunione di montagne, Heidegger intende far risuonare il richiamo al verbobergen, che dà origine a un genere esclusivamente tedesco di film: quello, appunto, della montagna (ad es. i film del dottor Arnold Franck, divenuto uno specialista nel mescolare precipizi e passioni, dirupi inaccessibili e insolubili conflitti umani). Se così fosse, Heidegger avrebbe respirato la stessa aria che negli anni venti impregnò a poco a poco la borghesia colta tedesca che cominciò a invocare la fine dell’ alienazione usato come sinonimo di sradicamento, in nome però del radicamento nel suolo natìo, nel popolo e nella natura (le passeggiate nelle foreste e le ascensioni in montagna tanto care a Heidegger). Le prove a conferma di questa tesi sembrano inconfutabili. Adorno, Löwith, Bourdieu, Farias[22] le esibiscono con dovizia di particolari. In aggiunta, c’è la storia del cosiddetto vestito esistenzialista che Heidegger si fece confezionare per testimoniare la sua fedeltà alla tradizione e al folclore della sua terra: un abito nero fuori moda, come ricorda la signora Cassirer (pantaloni stretti e un soprabito, una redingote). Anche il più piccolo dettaglio della biografia di Heidegger concorrerebbe dunque a confermare l’immagine di un brillante parvenu. Solo resta da spiegare come sotto queste mentite spoglie si celi un autentico maître à penser. Evidentemente anche nel caso di Heidegger vale il vecchio adagio popolare secondo cui l’abito non fa il monaco.
Heidegger e la Rational-sierung capitalistica
Torniamo alla Germania di quegli anni. Si diceva che Essere e tempo è stato pensato e scritto negli anni centrali del ciclo di razionalizzazione dell’industria tedesca i cui effetti si fanno sentire anche a livello universitario attraverso la crisi che colpisce soprattutto il cosiddetto ceto medio, il Mittelstand. È Bordieau a ricordarci la perdita di aurea dell’università tedesca negli anni venti in seguito all’espansione di un proletariato intellettuale di docenti e di lavoratori intellettuali subalterni ben rappresentato da tutti quegli studenti eterni ai quali né l’università né l’industria né l’apparato statale offrono un valido sbocco.
Alla proletarizzazione del ceto medio si accompagna “la disintellettualizzazione dell’operaio, la liquidazione del suo orgoglio professionale attraverso un macchinario più raffinato e preciso e attraverso l’abolizione delle componenti tecniche del processo lavorativo” Ma la razionalizzazione che prende definitivamente piede nel 1923-24 ha di mira qualcosa di più della trasformazione di una determinata composizione di classe; disarmare la classe operaia restava la grande sfida che il capitale voleva vincere a tutti i costi, nonostante la vittoria sul piano militare nel ’21. Come dice Roth, “bisognava spezzare il vecchio orgoglio professionale, ma solo se al suo posto subentrava un nuovo apprezzamento del lavoro che coinvolgesse anche quegli operai che avevano sempre sentito la fabbrica come una prigione e il lavoro come un tormento privo di senso” [23].
La lotta per l’anima dell’operaio fu la nuova parola d’ordine del capitale, subito accolta e propagandata dai suoi corifei. Senza questa sfida non si comprenderebbe L’operaio di Jünger[24] (1932) né l’apprezzamento di Heidegger per questo libro ai tempi del suo rettorato nel 1933. Apprezzamento dovuto, perché nella filosofia politica de L’operaio, nel suo pathos metafisico, ritroviamo in verità temi che sono al centro dell’ontologia di Essere e tempo.
L’utilizzabile intramondano
Riprendiamo allora il nostro discorso dal punto in cui l’abbiamo lasciato. L’equivoco, la curiosità, la chiacchiera, si diceva, sono per Heidegger figure dell’esistere inautentico, modi della deiezione dell’Esserci. Questa deiezione è frutto della sospensione del “prendersi cura maneggiante e usante”[25] , vale a dire si manifesta soprattutto quando abbandoniamo il lavoro. Così accade per la chiacchiera che indica l’autonomizzarsi della comunicazione dalla produzione strumentale, così accade per la curiosità allorché il lavoro viene sospeso affrancandoci dal mondo delle opere; così, infine, accade per l’equivoco che, dice Heidegger, “accredita il parlare in luogo del fare e il presentimento curioso come vera realtà, screditando l’esecuzione come qualcosa di secondario e privo di interesse”[26]. L’essere-nel mondo deiettivo prende forma “in questa fermata”, esattamente in questo “venir meno di ogni manipolazione e utilizzazione”[27] .
Ma l’inautenticità, lo abbiamo visto, è anche un modo preciso di essere nel mondo, addirittura il modo in cui l’Esserci è completamente immedesimato nel suo mondo ambiente. Certamente un modo difettivo, ma mai un tradimento, una rinuncia, un distacco da ciò che per Heidegger è un diverso modo di rapportarsi al mondo: lavorando ma senza alienarci nel lavoro, evitando di restare schiavi delle strumenti che usiamo, quindi andando oltre la loro mera utilizzabilità e adoperabilità, per scoprirli invece portatori di un significato che rimanda alla nostra intimità con il mondo, intimità che nel linguaggio di Heidegger apre l’esserci alla comprensione di sé[28]. Solo il lavoro ci restituisce il nostro mondo nel quale incontriamo un po’ di tutto, dagli utilizzabili intramondani ai prodotti dal lavoro fabbricati “su misura del corpo dell’utilizzante”[29], i nostri simili e noi stessi; con questo universo di uomini e cose, di enti ed esserci, intrecciamo relazioni di relazioni e connessioni di rimandi.
Certo: la descrizione heideggeriana pare modellato sul “mondo di attività di un artigiano”[30]; pure, però, la descrizione si confà alla produzione in serie. In questo caso il rinvio non è a questo o quel cliente ma alla massa anonima dei consumatori, nel linguaggio di Heidegger “a chiunque, al medio”[31]. L’utilizzabile intramondano traduce il termine greco pragmata che non indica la semplice cosa ma l’opera costruita per, in vista di uno scopo ben preciso. Il luogo della sua produzione resta anche per Heidegger la fabbrica. Non c’è traccia del classico linguaggio dell’economia che resta per Heidegger un sapere ontico nella misura in cui ci descrive i caratteri della cosa come tale senza mettere in questione il suo essere. Anche il riferimento al valore risulta inutile perché questa inerenza resta oscura, nonostante gli sforzi degli economisti classici.
Invece è rilevabile una certa affinità dell’utilizzabile intramondano con il valore d’uso della merce, la sua utilità. Facciamo esperienza del mondo, dice Heidegger, lo riconosciamo come il nostro mondo-ambiente solamente “attraverso il commercio nel mondo e con enti intramondani ”[32] e questo commercio, che usa e manipola, è contrassegnata dalla precomprensione, cioè dalla visione ambientale preveggente, un modo particolare di vedere che contrassegna il nostro comportamento pratico. A differenza di Marx, Heidegger non pensa che la società capitalistica si presenti come una immane raccolta di merci anonime e che la merce, cioè l’utilizzabile intramondano, sia un oggetto esterno pronto a soddisfare i bisogni umani. Il mondo non consiste di utilizzabili[33] che noi scegliamo di volta in volta secondo i nostri bisogni perché non abbiamo a che fare con semplici presenze. Heidegger dedica un paragrafo[34] all’essere dell’ente che si incontra nel mondo-ambiente, cioè agli utilizzabili. L’utilizzabile non «c’è» come ente isolato perché nella sua struttura è implicito un rimando di qualcosa a qualcosa[35]; l’utilizzabile è tale solo a partire dalla sua appartenenza ad altri utilizzabili; prima del singolo utilizzabile, dice Heidegger, è già scoperta una totalità di utilizzabili. L’utilizzabile ha una sua anima, letteralmente possiede un «essere in sé», la sua utilizzabilità[36] al quale il suo uso e la sua manipolazione devono sottostare. Non può essere cercato, spiato o braccato come accade con la merce nel caso del consumatore distratto e neppure usato maldestramente dal lavoratore pigro. L’utilizzabile viene incontro, si mostra, soccorre chi si assume la responsabilità del suo operato di fronte al mondo e ha cura che il lavoro sia ben riuscito, che la sua opera, “ossia ciò che si sta facendo, [sia] tale che, in virtù della possibilità di impiego che appartiene ad essa in linea essenziale, lascia co-incontrare già sempre l’«a-che» del suo impiego”[37]. Anche nella produzione in serie ovvero nel mondo chiuso della fabbrica, dice Heidegger, agisce questo rimando[38]. Era stato l’operaio qualificato, di mestiere, dell’industria meccanica a immedesimarsi con i propri utensili, manuali o meccanici, a partecipare direttamente alla modificazione della struttura del prodotto, a trasformare da sé le proprie tecniche di lavoro facendo la fortuna imprenditoriale dei settori più dinamici dell’industria tedesca. È questa composizione di classe a prendersi cura (il Bergosen heideggeriano) dei macchinari, delle opere e della fabbrica tutta intera, avendo cura (il Fürsorge heideggeriano), insieme, degli interessi degli altri, cioè dei propri compagni incontrati al lavoro[39]. Forse è per questa intimità, di cui Heidegger parla a proposito del prendersi cura[40], che gli utilizzabili hanno questa denominazione pudica e una loro vita che ci sembra eterna, libera dai dolori e dai patimenti degli umani che li hanno prodotti. Così il mondo-ambiente di Essere e tempo ci appare diverso da quello che ci descrive Engels, pieno di fabbriche, anzi nel suo insieme un immane stabilimento industriale sempre più gigantesco. La roba pesante della modernità capitalistica non ingombra il mondo ambientale di Essere e tempo, ogni cosa è al suo posto e finanche la natura, amata e rispettata, è resa accessibile a tutti grazie all’uso sapiente degli utilizzabili[41].
La battaglia per l’anima dell’operaio
Con Essere e tempo Heidegger partecipa alla battaglia per l’anima dell’operaio iniziata pochi anni prima, attorno al 1923-24, allorché il capitale tedesco avverte l’urgenza di sostenere la razionalizzazione con una specifica propaganda, anche manipolata, tesa a recuperare ideologicamente l’operaio nel riorganizzato ciclo dello sfruttamento, date le ridotte possibilità di concessioni in fatto di salario reale e di riduzioni d’orario. Ma il libro non è un pamphlet politico, non porta traccia di vis polemica, non è un libello; è un libro di filosofia, caratterizzato, come ci ricorda Safranski nella sua biografia filosofica di Heidegger[42], “da una drammaturgia a effetto”, da “una tecnica di straniamento, dato che ciò che si deve indagare non è una cosa estranea e sconosciuta, ma viceversa la cosa più prossima”; infine da un “linguaggio calcolato” ma reso astruso da “accozzaglie di parole separate da trattini che hanno il compito di connotare le strutture nel loro nesso inscindibile” [43]. Ma qui l’operazione linguistica di Heidegger rassomiglia in verità al gesto di rottura di talune avanguardie del periodo (dadaismo, surrealismo, espressionismo). Con i suoi neologismi infatti intende distruggere le definizioni ontologiche dell’uomo come animale razionale, imago Dei, res cogitans, soggetto, Io, Persona, ecc. ecc.
A produrre l’effetto di straniamento sono dunque gli esistenziali, in particolari quelli che fanno riferimento all’uomo e che descrivono tutto ciò che riguarda la sua esistenza (l’esser-ci, l’essere-nel-mondo, l’essere-gettato, il con-essere e altri ancora).
Ne risulta una realtà rarefatta anche per l’approccio scelto da Heidegger, di far reagire assieme il rigore del saggio filosofico euna costruzione per via narrativa. L’esito, si diceva, è quello di una realtà rarefatta, ma anche immaginaria, parallela, fantasmagorica, e totalizzante. Questa realtà ci sorprende ma anche ci cattura così che alla fine dobbiamo riconoscere a Heidegger il genio espressionista di un Fritz Lang, visto la sua capacità di infuturare il presente.
Essere e tempo non è ovviamente la versione filosofica del capolavoro del regista austriaco, ma con Metropolis, uscito nelle sale tedesche nei 1927, condivide il sogno di un oltrepassamento definitivo della lotta di classe operaia. Per l’occasione Heidegger ha fatto tabula rasa di sottosuoli e grattacieli sfavillanti. Con gesto cartesiano il suo mondo-ambiente è stato liberato dalla presenza ingombrante di operai e padroni, svuotato di realtà e di corpi; ad abitarlo è solo il nudo Esserci, esistenziale per antonomasia, consegnato per sempre al sentimento della propria situazione emotiva come l’anima dannata dell’inferno dantesco.
Come gli operai di Lang, anche l’Esserci, in quanto essere-nel-mondo, è spaurito[44], con la differenza però che i primi hanno paura mentre sono al lavoro, a contatto diretto con la macchina che può ucciderli alla minima distrazione, mentre il secondo si trova nella situazione emotiva della paura fuori dal lavoro. Il rapporto con l’utilizzabile lo salva a condizione però che conosca lo strumento e sappia usarlo con cura amorevole, in una parola che ami il suo lavoro. Il lavoro resta l’ultimo rifugio per non perdersi.
Com’è noto, nel novero dei modi possibili della situazione emotiva elencati da Heidegger mancano quegli affetti in grado, secondo Spinoza, di accrescere la potenza individuale, in primis la gioia. Ad alimentare lo stato emotivo che avvolge l’Esserci ci sono solo passioni tristi tra le quali primeggia l’angoscia indicata come la sola capace di condurci alla “comprensione esplicita[…] dell’essere dell’Esserci”[45], vale a dire alla scoperta dell’anticipazione della morte che costituisce l’Esserci come un tutto autentico. Siamo evidentemente mille miglia distanti dalla tesi spinoziana della filosofia come meditazione della vita e non della morte perché, era questa l’idea di Spinoza, della morte non saremo mai causa adeguata perché non potremo mai farne un nostro progetto.
Con quale stato d’animo allora incontriamo gli altri? Spesso e per lo più, come direbbe Heidegger, con indifferenza e diffidenza, simulando e dissimulando, oppure con ostilità e reticenza.
Questo vale nei rapporti interpersonali; invece, quando si tratta di “giocare tutto in comune per una medesima causa”, il rapporto si fa autentico e ognuno è rimesso “alla propria libertà”[46]. Ma come intendere questo gioco in comune, questa causa comune?
Rispetto al marxismo, operaio e lavoro hanno per Heidegger un altro senso e un suono nuovo che l’amico Jünger colse subito negli esistenziali di Essere e tempo. L’esser-ci e il con-esserci, l’aver cura e il prendersi cura non sono lo sfruttato di Marx e la classe di Lenin, il lavoro alla catena della Opel o la solidarietà di classe. Ogni tentativo di leggere in tal senso il testo heideggeriano non potrà sortire alcun effetto per il semplice motivo che l’autore pensava e intendeva altro.
In particolare è il concetto di classe, assolutamente centrale nel pensiero rivoluzionario del primo novecento, a subire l’effetto corrosivo degli esistenziali heideggeriani, in questo caso del Si (Man)[47]. L’appartenenza alla classe fa sì che “ognuno è gli altri, nessuno è se stesso”. Nella classe si diventa “il nessuno a cui ogni Esserci si è abbandonato nell’indifferenza del suo essere-assieme”[48]. Il lavoratore che si pensa appartenente alla classe operaia, che ha, come direbbe Lukács[49], coscienza di classe, deve allora ritrovare se stesso ma può farlo solo se modifica la sua esperienza vissuta; in una parola deve cercare altrove il luogo dove desumere le possibilità per progettarsi una vita autentica.
“L’Esserci ha sempre effettivamente la sua «storia»”[50]. In quanto gettato, abbandonato a se stesso, è assegnato a un «mondo» (il suo paese) dal quale eredita un particolare “destino-comune. Con questo termine –dice Heidegger- intendiamo lo storicizzarsi della comunità, del popolo”[51]. È alla luce di questa appartenenza che l’operaio deve ripensare il senso del suo lavoro. Il lavoro allora diventa un servizio che, al pari di altri servizi, appartiene allo Stato; l’operaio, membro della comunità del popolo, è obbligato, perciò, a partecipare allo sforzo comune per difendere l’onore e assecondare il destino della nazione. A educarlo a un siffatto servizio provvederà direttamente lo Stato secondo l’auspicio del conte Yorck che Heidegger non esita a sottoscrivere:“Lo Stato dovrebbe assumersi il compito pedagogico di dissolvere le opinioni elementari e pubbliche, e di favorire, mediante l’educazione, la massima individualizzazione possibile del vedere e dell’osservare. Si avrebbe allora, al posto della cosiddetta pubblica opinione […] di nuovo coscienze individuali; cioè le coscienze si farebbero forti e operanti”[52].
Sussunzione reale e crucialità del tempo
Sono i due temi che fanno la differenza e che Heidegger affronta di petto nelle pagine dedicate all’interpretazione temporale del lavoro, vale a dire del «prendersi cura»[53]. Sussunzione reale è concetto marxiano[54] mentre è Negri, sulla scia di Marx, a insistere oggi sull’aspetto costitutivo del tempo alla luce della transizione infinita dal fordismo al postfordismo[55].
Essere e tempo li affronta entrambi. Da una parte l’accento cade sulla realtà della sottomissione della società al capitale (si tratta del nostro essere nel mondo ambiente di cui ci prendiamo cura); trattandosi di un mondo, cioè di una società, che non conosce differenze e resistenze, dobbiamo pensare che la sussunzione reale è pensata effettuale. Dall’altra c’è il tema, assolutamente centrale nell’ontologia di Essere e tempo, della temporalità come il senso dell’essere dell’ente che noi siamo. Forse soltanto oggipossiamo apprezzare questa tesi del tempo costitutivo dell’esserci. Infatti il lavoro sociale, come da più parti è ormai riconosciuto, copre tutto il tempo della vita e ne investe tutti i comparti sicché è diventato impossibile distinguere la totalità della vita (quella che Negri sulla scia di Marx chiama i rapporti sociali di produzione e di riproduzione) dalla totalità del tempo da cui questa vita è intessuta. Il periodo della cosiddetta Rational-sierung (1924-1929) rappresenta per la società tedesca la prima tappa in questa direzione, esattamente la sua fase fordista che segna anche la fine di una determinata figura di tempo, quella dell’orologio e del prodotto tipico dell’operaio professionale. Essere e tempo non solo registra il passaggio al tempo flusso della produzione di massa ma coglie anche la sua sostanzializzazione fino a intravedere l’inedita figura del tempo come tessuto di tutto l’essere. E questo molto prima che l’essere tutto intero resti implicato nella rete dei rapporti di produzione. L’ontologia heideggeriana, si dice, è diversa da tutte le altre della storia della metafisica perché ha portato alla luce il carattere temporale dell’essere; bisognerebbe aggiungere che la crucialità del tema e la risolutezza con cui Heidegger l’ha affrontato e risolto non possono prescindere dal rivolgimento nel modo di produrre dell’industria tedesca nella seconda metà degli anni venti e dalle sue ricadute nella composizione sociale e nello stile di vita anche del cittadino medio.
Un esempio di società fordista
Cos’è che caratterizza una società fordista? Indubbiamente il primato della fabbrica sul mercato, il fatto che la fabbrica produce la società decidendo ciò che si deve comprare. Generando un certo tipo di consumi, la fabbrica impone le mode, i costumi, le abitudini, i modi di vivere e di pensare. Questo primato della fabbrica comporta la rigida separazione delle due sfere della produzione e della riproduzione, circoscritta quest’ultima al consumo delle merci e al riposo.
Anche Heidegger fa questo distinguo allorché parla del nostro prenderci cura preveggente ambientalmente, cioè del tempo che dedichiamo al lavoro, e della nostra vita fuori dal lavoro, quando a farla da padrone è la signoria incontrastata del Si, della sua pubblicità e della sua potenza d’attrazione. Rispetto alla critica marxiana, l’interpretazione heideggeriana di queste due forme di vita “è del tutto estranea a ogni critica moralizzante”[56]. A differenza dell’ontologia marxiana, quella di Essere e tempo è un’ontologia senza etica. Scegliere l’una o l’altra forma di vita non ci libera dall’inautenticità dell’esistenza il cui primato su quella autentica è, come abbiamo visto, fuori discussione. Addirittura l’inautenticità “può […] determinare l’Esserci, con concretezza più piena, nella operosità e nella vivacità, nella capacità di interessarsi e di godere”[57].
A proposito di questa vita inautentica, dobbiamo sempre distinguere due livelli di inautenticità.
Si può restare svuotati del proprio essere quando, lontani dal lavoro, restiamo preda della soggezione altrui dissolvendo la nostra singolarità nel modo di essere di tutti: “Ce la passiamo e ci divertiamo come ci si diverte; leggiamo, vediamo e giudichiamo di letteratura e di arte come si vede e si giudica. Ci teniamo lontani dalla «gran massa» come ci si tiene lontani, troviamo «scandaloso» ciò che si trova scandaloso”[58].
Nella vita lavorativa invece, quella che Heidegger chiama del prendersi cura preveggente ambientalmente, il rischio non è una perdita di sé perché in essa “la stessa esistenza autentica dell’Esserci si mantiene in questo prendersi cura, anche quando sia per essa «indifferente»”[59]. Anzi, proprio perché si tratta di una vita messa al lavoro, l’inautenticità che in essa comunque si annida può essere in un qualche modo trascesa. Nel lavoro dimentichiamo noi stessi, non ci sono dubbi[60], ma siamo salvi da tutto ciò che caratterizza l’altra forma di vita.
Lo spazio della fabbrica infatti non è lo spazio pubblico dove alligna la chiacchiera, ovvero il discorso infondato che ci distoglie dalla cura manipolante e adoperante in cui consiste il lavoro. Addirittura il processo produttivo, in quanto agire strumentale, esige il silenzio.
L’applicazione della scienza alla produzione infatti ha provveduto, come dice Marx, a trasformare le macchine in organi della volontà e del cervello umani[61] relegando l’uomo al ruolo di sorvegliante e regolatore del processo di produzione. La macchina possiede tutte le informazioni di cui il lavoro ha bisogno e per questo motivo il lavoro può tranquillamente procedere in un senso solo, al suo ritmo e senza replica.
Anche l’analisi heideggeriana del lavoro non si discosta da questa impostazione antropologica che risale allo Hegel giovane dellaFilosofia dello spirito jenese e della Fenomenologia dello spirito e che Marx riprende nel 1° libro del Capitale.
Il tempo della vita inautentica
Il Capitolo quarto di Essere e tempo ci introduce direttamente nel nostro tema: quale figura di tempo per la nostra quotidianità?
Ma prima dobbiamo chiarire cos’è il tempo per Heidegger. Perché Zeitlichkeit e Temporalität per nominarlo?
Intanto ciò che il tempo non è. Il tempo non può essere interpretato come un’armatura fissa o come la successione continua di istanti in cui si svolgono gli eventi e le variazioni delle cose (come recita alla voce tempo il nostro Garzanti) in movimento tra presente, passato e futuro. Perciò l’esserci che noi siamo non esiste nel tempo e la nostra esistenza non è la somma delle esperienze vissute che si rincorrono e si susseguono in esso.
Verrebbe da dire che l’esserci è il tempo stesso se non fosse che Heidegger parla di Zeitlichkeit, di temporalità, come “sensodell’essere dell’ente che chiamiamo Esserci”[62], una questione di comprensione e di interpretazione, quindi, più che di fondamento. Teniamo bene a mente quanto in proposito dice Heidegger: “Il fatto di porre il problema del senso dell’essere non conferisce alla ricerca il carattere recondito e imperscrutabile di un’indagine intorno a ciò che starebbe dietro all’essere”[63]. In gioco nella comprensione come nell’interpretazione è infatti il nostro modo di essere nel mondo, al lavoro e fuori dal lavoro. Oggetto della comprensione come dell’interpretazione è la nostra esistenza inautentica e deietta, nulla di più, nulla di meno. Solo dopo averla portato alla comprensione diciamo che la nostra esistenza ha il suo senso determinato[64].
Dunque l’essere dell’Esserci cui allude la definizione heideggeriana di Zeitlichkeit è l’esistenza quotidiana. Se il tempo ne è il senso recondito, è perché la quotidianità ne è pervasa; a livello di sussunzione reale infatti tempo, vita e produzione finiscono per costituire una tautologia, modi similari della temporalizzazione (Temporalität) della temporalità (Zeitlichkeit), come si esprime Heidegger. Solo così il tempo può costituire “l’orizzonte di ogni comprensione e di ogni interpretazione dell’essere”[65].
Più sopra si accennava all’operazione di scarnificazione del reale da parte di Heidegger per via, in primo luogo, di certa terminologia: ente intramondano per dire i mezzi di produzione, le macchine, più che gli utensili della bottega artigiana,commercio (Um-gang) a indicare l’incontro e il rapporto con questi mezzi, il prendersi cura e il suo esser-presso che indicano, come dice lo stesso Heidegger, “il manipolare, il produrre l’utilizzabile e i loro modi difettivi e neutri”[66]. E poi il « con» e il « con-che », il « per », l’utilizzabilità e l’appagatività, a indicare la complessità di rapporti che intrecciamo al lavoro, dentro la fabbrica[67], con le macchine e i nostri simili. È quest’ultimo termine (appagatività: così Chiodi traduce il termine tedesco Bewandtnis mentre Marini preferisce opportunità) a risultare il concetto chiave dell’analisi heideggeriana del lavoro. Esso indica “il riconoscimento del modo di essere fondamentale dell’utilizzabile”[68], vale a dire un sapere che solo l’operaio dell’industria meccanica e cantieristica prima della grande ristrutturazione della seconda metà degli anni venti possedeva: un operaio, come ci ricorda Sergio Bologna, altamente specializzato, di elevate capacità professionali, che sapeva lavorare di precisione sul metallo, conosceva alla perfezione i propri utensili manuali e meccanici, che collaborava col tecnico e con l’ingegnere alla modificazione del processo lavorativo[69]. Sapere pratico, sapere come fare piuttosto che sapere-che-cosa, cioè sapere proposizionale; infine sapere che non appartiene a chi lo ha perché il Dasein heideggeriano non è il soggetto individuale. In questo contesto e per talune sue determinazioni d’essere, potrebbe addirittura richiamarci alla mente il coevo concetto lukäcsiano di classe operaia.
L’appagatività significa anche realizzarsi nel lavoro, essere contenti di ciò che si è come lavoratore. Si tratta, a ben vedere, della riproposizione da parte di Heidegger dell’ideologia del lavoro e del suo contributo alla battaglia per la conquista dell’anima dell’operaio. Questo rapporto di cura col proprio lavoro ha una sua struttura temporale che Heidegger chiama dell’aspettarsi(Chiodi) o dell’attendersi (Marini[70]), Gewärtigen, la sola in grado di garantire “la caratteristica immedesimazione del prendersi cura col suo mondo di mezzi ”[71].
L’aspettarsi è un modo inautentico di temporalizzarsi dell’avvenire, un modo che nasce da un oblio particolare, come dice Heidegger[72]. Proprio perché nel lavoro perdiamo noi stessi, possiamo lavorare, “intraprendere «realmente» delle opere e volger[ ci ] alla manipolazione”. Il che non significa cancellazione totale, azzeramento, del nostro poter essere. Quest’ultimo trova il proprio surrogato nell’immagine che il lavoro e le sue macchine ci rimandano perché sono essi a contare nella nostra vita. Per chi si trova in questa situazione, la vita non viene vissuta pensando veramente a se stessi, ma viene vissuta a partire da un avvenire inautentico com’è, appunto, quello di pensarsi, di aspettar-si in relazione al lavoro. Tutto viene a dipendere da esso, la situazione presente come il progetto per il futuro, le incertezze e le paure ma anche le soddisfazioni e i momenti di felicità. Soltanto così può aver luogo il perdersi, da parte dell’esserci, nel mondo di cui si prende cura per rivolgere l’attenzione unicamente alla macchina e al lavoro. È così che il presente diventa l’orizzonte esclusivo del commercio con l’utilizzabile, e per esprimere il quale Heidegger conia il concetto di “presentifizazione aspettantesi e ritenente”[73].
Il lavoro dunque trasforma il nostro avvenire in aspettazione e attesa perché aspettiamo noi stessi da ciò che solo il lavoro ci può offrire o rifiutare[74]. Alla fine tutto sembra dipendere dal successo o dall’insuccesso di ciò di cui ci prendiamo cura.
La gratificazione, ovvero quella sorta di intimo compiacimento e di soddisfazione morale che proviamo quando vengono riconosciuti i nostri meriti al lavoro, magari con l’aggiunta di un compenso straordinario in denaro accanto alla normale retribuzione, rientra in quest’ordine di idee. È il motivo per cui inseguiamo chimere, obliando il nostro poter–essere più proprio (l’avvenire autentico) e gettato ( il passato autentico).
Anche il passato paga così il suo prezzo. Se infatti l’avvenire si temporalizza come un’aspettarsi inautentico, il passato viene semplicemente schivato; più esattamente viene, come si diceva, obliato[75]. Non si tratta di un’assenza di memoria ma “di un modo di essere nel quale io sono-stato innanzi tutto e per lo più”[76]. Heidegger gioca qui col tempo del passato prossimo trasformandolo dapprima in un endiadi per riassorbire in un secondo momento il participio passato nel tempo presente. Come dire: ciò che è stato non è diverso da ciò che è.
Il tempo della vita deietta
Ben diverso è il presente della nostra esistenza deietta, quella che viviamo fuori dal lavoro. Si tratta di un presente che non è meno pesante o più facile da vivere, come da più parti viene riconosciuto. Prendiamo a mo’ di esempio un libro il cui titolo richiama espressamente quello del nostro filosofo: Essere senza tempo[77]. Sociologi come Bauman, Beck e Mc Luhan, storici come Le Goff e Braudel, filosofi della modernità (Kant ed Hegel) e della postmodernità (Lyotard, Baudrillard), marxisti della cattedra e marxisti eretici concorrono a descrivere una forma di vita in cui la precarietà, la vulnerabilità, l’instabilità sono un destino. Delle tre estasi heideggeriane (passato, presente, futuro) solo il presente sembra sopravvissuto, un presente vissuto in velocità, con la sensazione desolante che sia sempre troppo poco il tempo a disposizione per agire e per comprendere quanto accade intorno a noi; presente, infine, eterno, opaco e intrascendibile, con un futuro ormai tramontato e riassorbito nel presente, e un passato congelato, quasi pietrificato. Ma questo è anche un modo per anestetizzare la realtà sociale. La società senza profondità temporale, che vive una sorta di perpetuo presente, non si preoccupa più in alcun modo dell’avvenire e del passato. Viene sostituita da una temporalità sociale nella quale non si annunciano veri cambiamenti, dove il lavoro della memoria non viene sollecitato, dove il passato, tormentato ma ricco, del XX secolo è interpretato come un susseguirsi di catastrofi da commemorare per meglio dimenticarle[78].
A questa descrizione preferiamo quella di Heidegger, volta a scoprire “il senso temporale della quotidianità dell’Esserci”[79], ovvero “il modo di esistere in cui l’Esserci si mantiene «tutti i giorni»”[80]. Il senso temporale della vita deietta non può risolversi nella mera constatazione che il nostro tempo ci sfugge tra le mani oppure che il nostro domani è solo l’eterno ieri e che questo tempo bastardo[81] determina la qualità della nostra esistenza anche se nessuno di noi ha scelto, come dice Heidegger, “il Si come suo eroe”[82].
Fuori dal lavoro, lontani dalla prestazione lavorativa, è la situazione emotiva con la sua particolare temporalità a occupare la scena. E qui la psicologia non può esserci d’aiuto perché ciò che proviamo non è “uno stato interiore che si esteriorizzerebbe misteriosamente per colorire di sé cose e persone”[83], bensì è il nostro modo di essere originario: effettivamente siamo così e così. Il buon umore e il malumore, l’indifferenza emotiva oppure l’euforia, la noia mortale oppure la paura, in una parola quegli stati d’animo che vanno e vengono e che l’osservazione ordinaria considera fuggevoli ed evanescenti, fanno parte della struttura originaria della nostra esistenza deietta. Non potremo mai liberarcene.
Ora, afferma Heidegger, queste tonalità emotive sono possibili solamente sul fondamento della temporalità. In esse e solo in esse il tempo acquista a seconda dei casi la sua leggerezza oppure tutto il suo peso, come possiamo sperimentare nel caso della noia quando ci colpisce in una stazione ferroviaria. Continuiamo a guardare l’ora ma, si domanda Heidegger, per “ constatare che cosa? Soltanto che ora è in generale? ”[84]. Oppure il nostro è un tentativo di accorciare il tempo, di irrompere in esso per meglio combatterlo?
La quotidianità che noi viviamo in situazioni emotive sempre cangianti si palesa così come un modo della temporalità. In una parola noi siamo il tempo che viviamo. La formulazione di Heidegger è, a questo proposito, tanto suggestiva quanto analitica: “La tonalità emotiva ci assale; essa però non viene né dal di fuori né dal di dentro; sorge nell’essere-nel-mondo come una sua modalità”[85].
La situazione emotiva si presenta proteiforme. Speranza, gioia, entusiasmo, allegria oppure tedio, tristezza, malinconia, disperazione sono stati d’animo sempre fuggevoli che accompagnano il grigiore quotidiano della nostra vita, rendendola ora più pesante da sopportare, ora più leggera. Ma sempre questi stati d’animo sono miei, li provo io e nessun altro al mio posto. Il proprium della situazione emotiva consiste nel portare l’Esserci davanti al proprio essere come essere gettato, e questo è possibile per il solo motivo che l’Esserci esiste già sempre temporalmente come “stato”, che esso è costitutivamente stato[86].
Gli stati d’animo rivelano sempre questo o quel modo dell’essere-stato. È il caso della paura che Heidegger torna a rivisitare sub specie temporis nella seconda sezione (§ 68 b). Nel cap. V della prima parte (§ 30) invece lo stesso fenomeno viene affrontato a prescindere dalla temporalità, cioè come un semplice modo tra i tanti della situazione emotiva inautentica.
Tema importante oggi, questa della paura. Urbanisti come Mike Davis e Saskia Sassen, sociologi come Zygmund Bauman e Massimo Ilardi, criminologi come Alessandro De Giorgi l’hanno posto al centro della loro ricerca. Controllarla e governarla è la parola d’ordine che si è imposta ultimamente alle politiche degli Stati postmoderni, al di qua e al di là dell’Atlantico ma anche produrla artatamente diventa importante per mettere in campo strategie e pratiche di controllo della società[87]. Heidegger a modo suo aveva anticipato i tempi quando scriveva che solo “ avendo paura è possibile alla paura […] « rendersi conto » di ciò che fa paura. La visione ambientale preveggente si rende conto di ciò che fa paura perché si trova nella situazione emotiva della paura”[88]. Ma per il filosofo Heidegger, a differenza dei nostri urbanisti, sociologi e criminologi, la paura ha poco a che fare con il futuro. Certo, il fatto che ciò che ci minaccia non è ancora qui ma si sta avvicinando sempre più, ci fa ragionevolmente pensare che il senso temporale primario della paura sia l’avvenire[89]. Resta tuttavia da stabilire qual è il fondamento dell’aver-paura. Perché l’esserci si impaurisca deve sentirsi minacciato nel suo essere, in ciò che già da sempre è: nel suo essere di poter-essere. Ma la vita vissuta in modo inautentico significa proprio trovarsi in quell’orizzonte della dimenticanza di sé nel quale l’Esserci è già fuori di sé, in fuga davanti alla sua autentica effettività. La paura si temporalizza a partire da questo oblio. È il motivo per cui nella paura non sappiamo più dove andare e temiamo per la nostra vita. Dimenticarsi di sé, cioè del propriopoter-essere, significa fuggire davanti al proprio passato e precludersi la possibilità di progettare diversamente la vita condannandosi, per bene che vada, a un’esistenza sovraccarica di ricordi e di attese(la protensione piena di cura verso tutto ciò che ci occupa e preoccupa di cui sopra)[90].
La dimensione temporale propria delle due forme di vita inautentica è dunque il presente.
Infatti nella vita inautentica è più facile mantenersi entro l’orizzonte di ciò che è stato già fatto, già provato, già detto. Interpretiamo noi stessi e il mondo in base al senso e ai significati entro i quali ci siamo formati, tutt’al più dilatandone i confini.
È quanto sperimentiamo ad esempio con la curiosità. Se vista in relazione al tempo[91], essa si manifesta come “movimento verso il non-ancora-visto, ma in modo tale che la presentazione [da intendersi come presente inautentico] cerca di sottrarsi all’aspettazione […]. La presentazione della curiosità «scaturente sfuggendo», è così poco dedita alle «cose» che essa, mentre sta vedendo, volge già lo sguardo altrove”[92]. Si tratta di un presente inautentico, che noi viviamo incapaci di afferrare le nostre più proprie possibilità e di trattenere quanto abbiamo appena visto. Tutto quanto ci viene incontro è, in ultima analisi, già noto e conosciuto.
Il disincanto di Heidegger si ferma qui, a questa constatazione. Perché poi indietreggia davanti alla radicalità della tesi del primato dell’inautenticità, prendendo ad esempio sul serio l’ipotesi, appena abbozzata a proposito del lavoro e della sua temporalità, che forse non esiste alcuna autenticità da cercare e che forse il gioco non vale la candela. Infatti vivere inautenticamente il presente o, come dice Heidegger, “l’estatizzarsi dell’esistenza nella presentazione non significa […] che l’Esserci si sciolga dal suo Io e dal suo se-Stesso”[93].
Anche se estraniati dal nostro poter-essere più proprio, possiamo benissimo comprenderci.
L’autenticità in Essere e tempo
Abbiamo insistito sul primato della vita inautentica e volutamente non abbiamo preso in considerazione la nozione heideggeriana di autenticità. Avendo privilegiato l’analisi della quotidianità media, l’ attenzione si è appuntata esclusivamente sull’esserci nel suo modo di essere inautentico. Una scelta, questa, coerente con la ratio della fenomenologia come metodo, interessata al come e non al che cosa reale degli oggetti[94].
Invece nutriamo forti sospetti per l’ontologia come scienza dell’essere dell’ente se l’essere in questione viene ricondotto a una sorta di proprietà di cui l’ente dovrebbe riappropriarsi. È quanto accade allorché la Zeitlichkeit è pensata come “temporalità originaria e autentica”[95] mentre la sua temporalizzazione (Temporalität) accade sempre in modi diversi, e sempre inautentici, a seconda del prevalere di questa o quella estasi. Da senso dell’essere, la Zeitlichkeit diviene ousìa dell’ente, ovvero ciò che appartiene all’ente di necessità e in questa nuova veste comincia a funzionare come principio di individuazione[96]. Il resto è una logica conseguenza di questa premessa; così la definizione di essenza come esistenza dell’esserci obbliga a pensare che un’esistenza degna di questo nome, cioè una vita degna di essere vissuta, debba corrispondere alla sua essenza, in una parola che debba essere autentica.
È stato osservato che nel suo discorso del ’33[97] Heidegger abbia attinto a piene mani nell’universo concettuale di Essere e tempo e, contemporaneamente, nel vocabolario del nazismo. Non so se questa osservazione di Löwith[98] corrisponda a verità. Certamente per Heidegger “l’esserci deve, nel suo stesso essere, divenire, cioè essere, ciò che non è ancora”[99]. L’alternativa è secca e radicale: essere se stesso o non essere.
In questo caso per Heidegger il problema non sarebbe la semplice interpretazione ordinaria dell’essere dell’esserci, quanto la sua autenticità, da affermare anche sul piano storico perché per Heidegger c’è una storicità autentica e una inautentica, quest’ultima identificata con l’orizzonte immediato della quotidianità. Per la storicità autentica invece c’è bisogno di riattraversare il calvario della coscienza, della colpa e della decisione anticipatrice della morte. Decidersi per la propria morte significa prendere su di sé e scegliere autenticamente quelle possibilità tramandate che costituiscono la nostra eredità. Solo così possiamo sentirci liberi per il nostro destino che è sempre destino comune (Geschick). Destino individuale e destino comune diventano una sola cosa mentre il futuro è indicato come il luogo dello storicizzarsi autentico dell’esserci. Non è difficile immaginare come questo tema della storicità autentica e della decisione anticipatrice fu recepito dal tedesco medio di quegli anni. Heidegger offriva ai suoi concittadini afflitti dalla crisi una prospettiva temporale e un’idea di futuro che avrebbe risparmiato alla Germania l’esito catastrofico paventato dal tempo lineare e progressivo della modernità. Ma per porsi fedelmente in ascolto delle possibilità ereditate, per non dimenticare l’antico, era necessario depresentificare l’oggi, vale a dire distogliere lo sguardo dal presente e non interrogarsi sulle cause reali della crisi. L’ultima parte di Essere e tempo assolve questo compito.
[1] M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976.
[2] Ivi, p. 225.
[3] Certamente un filosofo come S. Kierkegaard studiato a fondo da Heidegger proprio negli anni venti.
[4] G. Agamben, La potenza del pensiero, Neri Pozza Editore, Vicenza 2005, p. 309.
[5] P. Virno, Materialismo e convenzione, Edizioni Theoria, Roma-Napoli 1986, p. 27.
[6] M. Heidegger, Essere e tempo, cit. p.173.
[7] P. Virno, Convenzione e materialismo, cit. p.27.
[8] “L’uomo si presenta come l’ente che parla. Ciò […] significa […] che questo ente esiste nella maniera dello scoprimento del mondo e dell’Esserci stesso” ( Essere e tempo, cit. p. 209).
[9] Ivi, p.204.
[10] Ivi, p.184.
[11] Ivi, p.117.
[12] P. Virno, Convenzione e materialismo, cit. p.28. Questa scoperta è resa possibile dalla fatica del linguaggio, dal suo ininterrotto lavorìo: “il discorso è sempre discorso su… […]. Ciò di cui nel discorso si discorre è sempre « preso di mira » sotto un determinato riguardo ed entro certi limiti ” (Essere e tempo, p.206). Accanto a ciò di cui si discorre, troviamo nel linguaggio come suoi momenti costitutivi “ciò-che- il-discorso-dice come tale, la comunicazione e il far conoscere” (ivi, p. 205).
[13] M. Heidegger, Essere e tempo, cit. p. 204.
[14] Ivi, p. 213.
[15] Ivi, p. 211.
[16] Ivi, p. 213.
[17] P. Virno, Grammatica della moltitudine, Rubbettino Editore, Catanzaro 2001, pp.61-66.
[18] Lettera a Hannah Arendt 21-3-’25 in H. Arendt/M. Heidegger, Lettere 1925-1975, Edizioni di Comunità Torino, 2001, p. 7.
[19] Vedi il cap.V della seconda sezione di Essere e tempo.
[20] Introduzione: Segni di distinzione in T. W. Adorno, Il gergo dell’autenticità, Bollati Boringhiari Torino, 1989.
[21] M. Heidegger, Saggi e discorsi, Mursia Milano, 1980, p. 1.
[22] T. W. Adorno, Il gergo dell’autenticità, cit. ; K. Löwith, Saggi su Heidegger, Einaudi Torino, 1974; P. Bourdieu, Führer della filosofia?, il Mulino Bologna, 1989; V. Farias, Heidegger e il nazismo, Bollati Boringhieri Torino, 1988.
[23] K. H. Roth, L’altro movimento operaio, Feltrinelli Milano, 1976, p. 80 e 81.
[24] E. Jünger, L’operaio, Longanesi Milano, 1984.
[25] M. Heidegger, Essere e tempo, cit. p. 92.
[26] Ivi, p. 219.
[27] Ivi, p. 86.
[28] Ivi § 18. Appagatività e significatività. La mondanità del mondo.
[29] Ivi, p. 97.
[30] Ivi, p. 152.
[31] Ivi, p. 97.
[32] Ivi, p. 92.
[33] Ivi, p. 113.
[34] Il 15° del cap. terzo della Prima parte di Essere e tempo.
[35] Ivi, p. 94.
[36] Ivi, p. 95.
[37] Ivi. P. 96.
[38] Ivi, p. 97.
[39] Ivi, p. 155.
[40] Ivi, p. 103.
[41] “Nelle vie, nelle strade, nei ponti, nei fabbricati, il prendersi cura scopre la natura secondo particolari direzioni. La costruzione di una tettoia tiene conto delle intemperie, la disposizione della pubblica illuminazione dell’oscurità, della presenza o dell’assenza della luce del giorno, cioè delle posizioni del sole”(ivi, p. 97).
[42] R(üdiger) Safranski, Heidegger e il suo tempo, Longanesi, Milano 1996.
[43] Ivi, p. 182.
[44] Bisogna ricordare che per Heidegger anche la timidezza, il timore, l’inquietudine, lo stupore sono modificazioni della paura, fino al terrore (Essere e tempo, p. 181).
[45] Ivi, p. 229.
[46] Ivi, p. 158.
[47] Ivi, pp. 162-167.
[48] Ivi p. 164.
[49] G. Lukács, Storia e coscienza di classe, Sugar Milano, 1970. Questo libro esce nel 1923.
[50] M. Heidegger, Essere e tempo, cit., p. 458.
[51] Ivi, p. 461.
[52] Ivi. p. 481.
[53] M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 1976, Cap. IV, §§ 68-69.
[54] La testimonianza di Marx vale ovviamente per l’epoca d’oro del capitalismo concorrenziale. In proposito vedi di K. Marx, Il Capitale:Libro I capitolo VI inedito, La Nuova Italia, Firenze 1969 e Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politicaI/II, La Nuova Italia, Firenze 1968/1970.
[55] A. Negri, Macchina tempo, Feltrinelli Milano, 1982, cap.XIII.
[56] Essere e tempo, cit. p. 211.
[57] Ivi, p. 65.
[58] Ivi, p. 163.
[59] Ivi, p. 422.
[60] “Il se-Stesso, « perso » nel mondo dei mezzi, può intraprendere « realmente » delle opere e volgersi alla manipolazione, solo se ha obliato se stesso”, ivi, p. 425.
[61] K. Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica II, La Nuova Italia, Firenze 1970, pp. 400-403.
[62] Essere tempo, cit. p. 35.
[63] Ivi, p.193.
[64] “Senso è ciò in cui si mantiene la comprensibilità di qualcosa”, ivi, p.192.
[65] Ivi, p. 35.
[66] Ivi, p. 422.
[67] Ivi, p.97.
[68] Ivi, p.423.
[69] S. Bologna, Composizione di classe e teoria del partito alle origini del movimento consigliare in Operai e Stato Feltrinelli, Milano 1972.
[70] Ci riferiamo alla ri-traduzione di A. Marini di Essere e tempo, Mondadori, Milano 2006.
[71] M. Heidegger, Essere e tempo, cit. p. 424.
[72] Ivi, pp.424-425.
[73] Ivi, p. 424.
[74] Ivi, p.405.
[75] “L’estasi (l’esser- fuori) dell’oblio ha il carattere dell’esser-fuori fuggendo innanzi al più proprio esser-stato, sicché questo-esser-fuori-fuggendo-davanti-a… chiude estaticamente il « davanti-a-che » nello stesso tempo in cui chiude se stesso”, ivi p.407.
[76] Ivi, p. 407.
[77] D. Fusaro, Essere senza tempo, Bompiani, Milano 2010.
[78] T. Negri/J-M. Vincent, Il pensiero indebolito in T. Negri, Inventare il comune, DeriveApprodi, Roma 2012.
[79] È il titolo del §71 di Essere e tempo, cit.
[80] Ivi, p. 444.
[81] J. Egan, Il tempo è un bastardo, Edizioni minimum fax, Roma 2011.
[82] Ivi, p. 445.
[83] Ivi, p. 175.
[84] M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica, il melangolo Genova, p.129.
[85] Essere e tempo, cit. p. 175..
[86] “L’interpretazione temporale della situazione emotiva non può quindi proporsi la deduzione delle tonalità emotive dalla temporalità, risolvendole in semplici fenomeni della temporalizzazione. Al contrario, occorre dimostrare che le tonalità emotivenon sono possibili, quanto al « che » e al « come » del loro significato esistensivo, se non sul fondamento della temporalità”, ivi p.409.
[87] “Che cosa avverrebbe allo Stato « postmoderno » (quando cioè le ricche singolarità e la cooperazione sociale non hanno più bisogno dello Stato per mettersi dentro reti produttive) se il terrore delle vecchiette non lo riproducesse come sola condizione di sicurezza? ”, T. Negri, Prefazione a Zero tolleranza di A. De Giorgi, Derive Approdi, Roma 2000, p.9.
[88] M. Heidegger, Essere e tempo, cit. p.180.
[89] “ Senza dubbio, non solo l’aver paura si « riferisce » a qualcosa che è « futuro » nel senso che deve sopravvenire « nel tempo », ma questo stesso riferirsi è ad-veniente nel senso originariamente temporale”, ivi p. 409.
[90] Ivi, p. 407.
[91] Heidegger parla diffusamente della curiosità già nel § 36 del cap. V della Sezione prima.
[92] Ivi, p. 416.
[93] Ivi, p.417.
[94] Ivi, pp. 46 e 57-58.
[95] Ivi, p. 395.
[96] “La trascendenza dell’essere dell’Esserci è caratteristica perché in essa hanno luogo la possibilità e la necessità dell’individuazione più radicale”, cit. p. 59.
[97] M. Heidegger, L’autoaffermazione dell’università tedesca. Il rettorato 1933/34, il melangolo, Genova 1988.
[98] K. Löwith, Saggi su Heidegger, Einaudi, Torino 1966, p. 56.
[99] Essere e tempo, cit. p. 298.