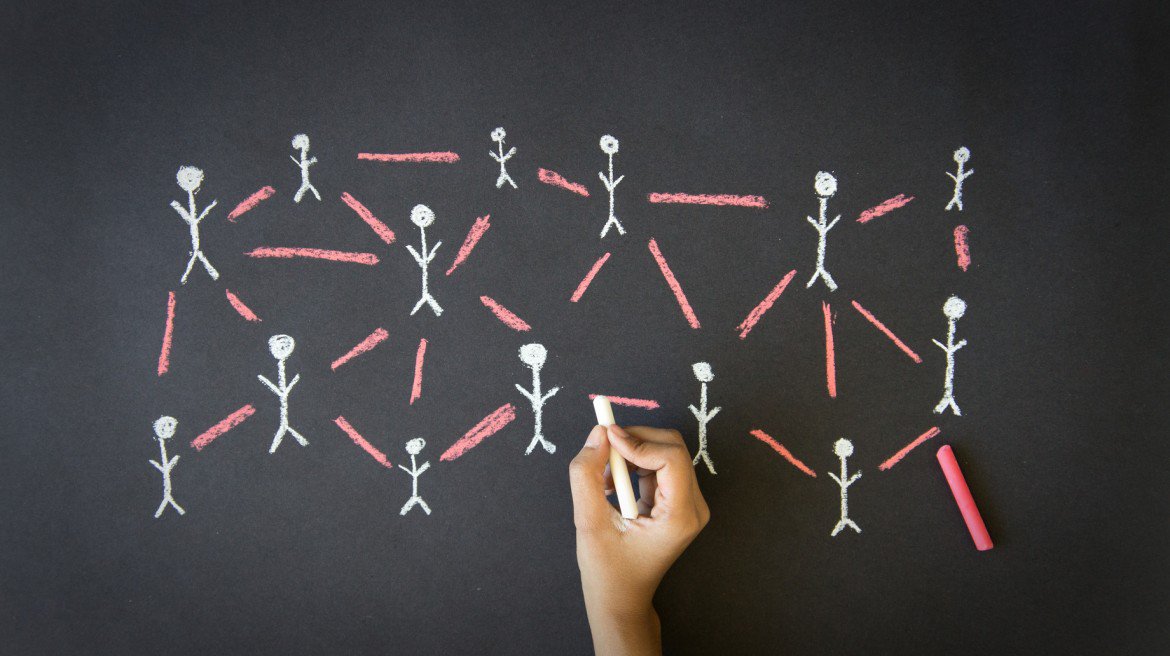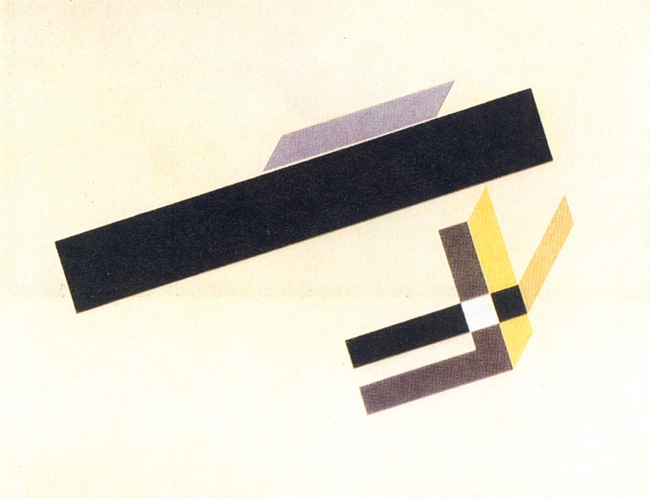di BENEDETTO VECCHI*. CODICI APERTI. Parassiti che si nutrono delle relazioni sociali e si appropriano dei profili personali. Occhi puntati sulla sharing economy e sull’industria dei Big Data. «Silicon Valley: i signori del silicio» di Evgeny Morozov per Codice edizioni.
Sharing economy è una espressione che si è fatta largo tra la selva delle definizioni che caratterizzano il capitalismo che ha nella Rete il suo medium. Segue quella dal sapido sapore controculturale della peer to peer production, che metteva l’accento sulla condivisione alla pari di conoscenze e mezzi di produzione nella quale Internet è una neutra piattaforma per determinate attività economiche separate tuttavia da quanto accade al di fuori dello schermo. Soltanto che il confine tra dentro e fuori la Rete è svanito. La logica della condivisione, infatti, è ormai riferita ad attività produttive, di informazione, conoscenza, software. Coinvolge infatti ogni attività di intermediazione tra produzione e consumo. Inoltre la sharing economy non prevede un rapporto alla pari, bensì una relazione mercantile, dove l’attività di intermediazione prevede un pagamento di una percentuale tra produttore e consumatore. Non è un caso che i nomi usati per esemplificare la sharing economy sono Uber e Airbnb, cioè servizi di taxi e di affitto di una stanza o di un appartamento per viaggi di lavoro o di piacere. Il tutto accompagnato da una melassa ideologica sul potere del consumatore di poter scegliere il miglior prodotto a prezzi accessibili e sulla possibilità di vedere realizzati il proposito neoliberista di trasformare ogni uomo o donna in imprenditore di se stesso.
In nome del municipalismo
Sarebbe un errore ridurre la sharing economy a mera ideologia, perché individua una forma specifica di organizzare tanto la produzione che la distribuzione o il consumo di merci, poco importa se tangibili o «immateriali». Coinvolge cioè gran parte della produzione di contenuti – non è un caso che Google o Amazon abbiano destinato miliardi di euro di investimento allo sviluppo di «piattaforme» per la loro condivisione di contenuti, integrando questa funzione con l’accumulo di dati. È proprio la diffusione virale di questa forma di intermediazione che ha accompagnato alcune tesi critiche della sharing economy incardinate sullo sviluppo di imprese «cooperative» alternative al regime di accumulazione capitalistico basate appunto sulla condivisione, evocando le forme di municipalismo e di mutuo soccorso sviluppate dal movimento operaio di inizio Novecento.
Sono alcuni anni che Evgeny Morozov dedica la sua attività di studioso a criticare la sharing economy. L’ultima, in ordine di tempo, tappa della sua sferzante critica, è la raccolta di saggi e articoli scritti tra il 2013 e il 2015 nel volume Silicon Valley: i signori del silicio (Codice edizione, pp. 151, euro 13. A questo proposito va segnalata l’intervista a «il manifesto» del 15 Ottobre 2015). Sono testi illuminanti non solo del percorso di Morozov ma di una tendenza teorica critica che attraversa tanto il Nord che il Sud del pianeta e che vede affastellarsi economisti, giuristi, filosofi, guru dell’era digitale come Nicholas Carr, Jason Lanier, Byung-Chul Han, Howard Rheingold. Ognuno di loro, seppur da prospettive diverse, mette in evidenza come la grande trasformazione sia ormai alle nostre spalle e che non tutto è oro quel che luccica. Ma Morozov ha dalla sua la costanza nel tessere una trama analitica, anche se non sempre convincente, tesa a costruire una storia del presente che registri sia le continuità che le discontinuità presenti nel capitalismo contemporaneo.
Lo studioso bielorusso non vuole cioè presentare nessuna «grande teoria», ma fornire elementi che consentano una «destrutturazione» di un immaginario che considera il capitalismo digitale come un mondo pacificato dove ogni ipotesi alternativa è bandita. Dunque, nessuna corrosiva critica alla «società del capitale», né nessuna proposta che punti alla sua fuorisucita come invece fa Paul Mason nel suo «manifesto postcapitalista» (il libro dell’economista e columnist britannico è in uscita per i tipi del Saggiatore), bensì una appassionata e sferzante radiografia del presente che arriva alla suggestiva proposta di una «socializzazione dei Big data», cioè quell’immane ammasso di dati individuali dopo la loro appropriazione privata da parte di social media e social network.
Nel diario di viaggio della sua navigazione del cyberspazio Morozov annota l’emergere del capitalismo delle piattaforme digitali, considerate alla stregua di parassiti che si nutrono delle relazioni sociali: non producono nulla, ma si appropriano di contenuti sviluppati da altri. Il caso più eclatante è la tanto citata e vituperata Uber che attua una politica aggressiva nei confronti di chi la usa come piattaforma, imponendo tariffe e «canoni» da pagare che costringono il singolo ad essere disponibile 24 ore al giorno se vuol conseguire un reddito dignitoso. Tanto aggressiva nei confronti di chi usa la sua piattaforma, Uber è specularmente friendly nei confronti dei potenziali utenti, prospettando basse tariffe e libertà di scelta.
Ma accanto a Uber e Airbnb c’è il variegato mondo dell’«internet delle cose». Con questa espressione si parla dei dispositivi digitali inseriti in elettrodomestici, in centraline elettriche collegati in rete (spesso gestiti da smartphone) destinati a ottimizzare consumi di energia elettrica. Oppure quelli usati per la geolocalizzazione che monitorano i movimenti dei singoli. L’effetto collaterale, va da sé, è la crescita dell’industria dei Big Data.
Con efficacia, Morozov parla di una smartification della vita sociale, cioè di una riduzione di ogni attività a una elaborazione di informazioni e di profili individuali al fine di aumentare i Big Data da vendere per strategie pubblicitarie oppure operazioni di marketing personalizzato. Da qui la centralità della cyber security sia aziendale che sociale, l’unico altro settore con una crescita a due cifre dell’industria high-tech. Morozov denuncia ovviamente i rischi dello sviluppo di una società del controllo di un regime postdemocratico.
Il volume, che raccoglie scritti apparsi su «Frankfurter Allgemeine Zeitung», «the Observer» e «the New Yorker», non nasconde riferimenti teorici eterodossi e l’interesse verso le tesi dell’attivismo radicale, ognuno a suo modo chiavi di accesso alla comprensione dello sviluppo capitalistico. E coglie nel segno nel porre la sharing economy come, appunto, componente di una ideologia dominante di quel neoliberismo che ha usato la crisi come chance per continuare l’opera di demolizione dei diritti sociali di cittadinanza e per uscire rafforzato da una crisi ritenuta il suo ultimo canto del cigno.
L’austerity è diventata così un dogma che orienta le politiche economiche e sociali degli Stati Uniti, dell’Unione Europea, ma ormai anche di paesi emergenti come la Cina, il Brasile, l’India. E se la finanziarizzazione dei diritti sociali sembrava non più di un lustro fa una tendenza, ormai è diventata la «cifra» per avere la pensione, la sanità, la formazione e l’istruzione. Ma questo non significa che molti degli «effetti collaterali» dell’austerity (disoccupazione, aumento delle disuguaglianze sociali, crisi della democrazia) non trovino echi nei teorici proprio del neoliberismo. Negli Stati Uniti, ad esempio, think tank conservatori parlano espressamente di un reddito minimo garantito per i disoccupati di breve e lungo corso. Ovviamente nelle forme neoliberali dei voucher da usare nell’acquisto di merci e servizi; e della disponibilità degli stessi disoccupati ad accettare lavori dequalificati o di riqualificazione urbana (gli equivalenti degli italiani lavori socialmente utili). D’altronde è stato proprio l’economista Milton Friedman, il «padre» dei Chicago Boys, a proporre una versione del reddito di cittadinanza ben prima dell’era della Rete.
Tuttavia l’agit prop più convinto del reddito di cittadinanza è una delle figure che ha legato il suo nome proprio alle tecnologie digitali. Si tratta di Jason Lanier, il «capitalista di ventura» nonché sviluppatore dei primi dispositivi di realtà virtuale, che terrorizzato dalla scomparsa della middle class propone da anni un reddito di cittadinanza per chi rimane senza lavoro e di sostegno a chi riceve un basso salario come le folte schiere dei working poor.
Jason Lanier non è un teorico. Da tecnico con simpatie new age si colloca in quella zona di confine che fa di un indifferenziato patchwork culturale, dove si giustappongono tesi anche confliggenti, la sua weltanshauung. Ma coglie lo stesso elemento messo a fuoco da Morozov: la sharing economy non è solo una tag buona per tutti gli usi, bensì una vera marxiana astrazione reale. Per Lanier, e anche per Morozov, l’obiettivo è salvare il capitalismo da se stesso. Il problema invece è come destrutturare, l’incantesimo della sharing economy.
Macchine politiche
Nel mondo anglosassone sono molte le voci critiche che si sono misurate con la sharing economy. Da Christian Fuchs a Nick Dyer-Whitefort, da Andrew Ross a Sara Horowitz, c’è tutto lo spettro di interpretazioni dove la condivisione viene vista come lo strumento per legittimare un regime di accumulazione segnato da superlavoro, bassi salari e precarietà radicale nel rapporto di lavoro. In questo spettro la voce che più di altre cerca di ribaltare in senso positivo la sharing economy è quella di Trebor Scholtz. In un recente report stilato per la fondazione Rosa Luxemburg, Scholtz elabora un vero e proprio manifesto programmatico di un Platform Cooperativism nel quale propone la costituzione di una rete di piccole e medie cooperative che possono offrire gli stessi servizi e condivisione di contenuti proposti dalle imprese della sharing economy, garantendo però servizi sociali e buoni salari. Scholtz è consapevole che le imprese cooperative – in crescita anche negli Stati Uniti – operano in nicchie di mercato, ma hanno dalla loro la possibilità di costruire consenso sociale attorno al loro operato, attraverso l’investimento di una parte dei profitti – non oltre il dieci per cento afferma Trebor Scholtz – in servizi sociali, pratiche di mutuo soccorso (il reddito di cittadinanza, per esempio) e quindi diffondersi come un virus che corrode dall’interno del mercato le logiche capitalistiche. Le piattaforme digitali svolgerebbero il ruolo di medium per tessere relazioni tra le cooperative, rafforzando il loro operato, ma anche e soprattutto, nelle tesi di Scholtz, di svolgere una funzione politica.
Le tesi di Scholtz possono essere sicuramente qualificate come ingenue, così come la sua concezione del Politico. Il mutuo soccorso, come anche il mutualismo, sono state esperienze importanti nella formazione del movimento operaio, ma non sono state scalzate dal podio da cinici rivoluzionari di professione, come recita una retorica presente nei movimenti sociali, ma perché il potere viene esercitato producendo gerarchie, istituzioni che garantiscono la riproduzione del regime di accumulazione. Da qui la necessità di svolgere un doppio movimento: creare momenti produttivi, mutuo soccorso, come auspica il Platform cooperativism di Trebor Scholtz, ma al tempo stesso immaginando e sviluppando un Politico che consenta quella riappropriazione del comune che la sharing economy ha espropriato.