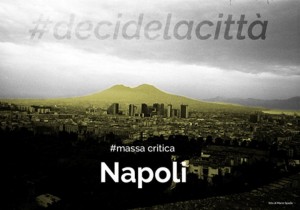di FRANCESCO FESTA.
“La disunione della plebe e del senato romano fece libera e potente quella Repubblica”. Il Machiavelli dei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio attacca il culto della concordia civica ritenendo che uno dei punti di forza di Roma siano stati proprio i tumulti – all’oggi, le lotte sociali – piuttosto che cause di debolezza. Anzi, Machiavelli ritiene che le sollevazioni popolari avrebbero avuto il grande merito di impedire che i “grandi” attentassero alla libertà. In fondo una città che punta a estendere la propria egemonia o a non cadere vittima di altri Stati, secondo Machiavelli, ha bisogno anzitutto di un esercito numeroso, ossia che l’intera popolazione si senta chiamata a combattere e che la medesima popolazione – chi vive l’urbe – possa esercitare il diritto di cittadinanza: vale a dire che le classi subalterne siano messe nella condizione di far valere con più forza le proprie rivendicazioni.
Come recita il primo capitolo del terzo libro dei Discorsi: “a volere che una setta o una Repubblica viva lungamente, è necessario riportarla spesso verso il suo principio”: il tumulto, le lotte sociali sono precisamente uno dei modi attraverso cui il filo prezioso con l’origine – con i principi preziosi – non viene mai a interrompersi del tutto. All’oggi, invece, la dittatura di centro cui è inchiodata la politica europea vuole proprio che la qualità del politico aumenti in modo inversamente proporzionale al numero di conflitti che crei, individui e cerchi di risolvere. Insomma i governi neoliberisti non vogliono assolutamente essere infastiditi: l’ordine del centrismo europeo è di non disturbare il manovratore, poiché è intento a “sbloccare” la nave incagliata tra le faglie di una crisi infinita; occorre affidarsi a lui, ché traghetterà economia e società oltre il buio della siepe. Infatti, esemplare è l’opera del governo Renzi: svalutazione del lavoro e adozione di dispositivi di precarietà nel campo della cooperazione sociale; gestione proprietaristica della città o anche utilizzo di forme ambigue di intervento pubblico e privato come rigenerazione urbana; decretazione di politiche autoritarie in soccorso tanto di gruppi imprenditoriali del comparto energetico quanto della solita borghesia industriale. In altri termini il modello renziano è tautologia delle dottrine neoliberiste e demagogia del consenso intorno alla retorica del “governo del fare”. In fondo, gioco facile hanno i giornalisti embedded – come Stefano Folli – nel soccorrere il governo dalle minacce che giungono dalle periferie del regno, dalle città e dai territori sofferenti e insorti.
In Europa, le città vanno assumendo maggior protagonismo e un sempre più significativo ruolo negli equilibri di governo, nonostante le dottrine ordoliberali suggeriscano l’avocazione all’Unione Europea delle questioni di governance periferica o delle amministrazioni regionali e locali. Il fenomeno neomunicipalista appare dunque una reazione alle politiche di austerity e alla costituzionalizzazione del pareggio di bilancio. Certo, l’affermazione dell’urbanizzazione è un processo politico ben più longevo; ma l’attualizzazione della formula – non solo lefebvriana – di “diritto alla città” è indubbiamente prensile delle rivendicazioni degli abitanti dello spazio urbano. In realtà, la stessa formula diritto alla città è un significante vuoto, vale tanto per i gruppi finanziari e immobiliari quanto per i senzatetto e i precari. Tra uguali diritti – ricorda Marx – decide la forza. È appunto il caso di quanto avviene nella città di Napoli: un governo che dispoticamente commissaria le decisioni per il riassetto di un’importante area metropolitana, affidandone la ricostruzione proprio a quei gruppi finanziari e immobiliari colpevoli dell’inquinamento e senza coinvolgere la popolazione e le forze sociali che la vivono; al contempo, la stampa di governo giunge in soccorso ritenendo quel tessuto sociale contrario al commissariamento e gli attori del presunto risanamento affetti da inclinazioni camorriste. Qui, non vi è icasticamente uno scontro di poteri all’interno di una narrazione provinciale, tipicamente italiana; piuttosto siamo dinanzi a uno scontro di forze differenti fra città e governo. Detto altrimenti: lo scontro fra un’Europa delle città ribelli e l’Europa della violenza neoliberista. Quanto avviene a Napoli è una traduzione, mutatis mutandis, di quanto avviene in molte città e metropoli europee, un rapporto differenziale fra isotopia ed eterotopia: fra governi sottoposti all’UE che costringono dispoticamente territori e “sudditi” a eseguire le scelte della Troika e i subalterni che esercitano il diritto a cambiare e reinventare la città in base alle esigenze e agli interessi comuni. In questo rapporto viene meno quella legittimità accettata dagli individui che – come affermava Max Weber – è l’esistenza stessa di uno stato, donde gli ordini emanati vengano eseguiti. In altri termini, l’egemonia che esercitano le classi dominanti nel controllare le classi dominate è venuta meno: “non è più dirigente, ma univocamente dominante – scriveva Gramsci – detentrice della pura forza coercitiva”, dunque i subalterni sono staccati dalle “ideologie tradizionali” e dalle “forme di governo in cui prima credevano”. Tale è la “crisi organica”, “dove il vecchio muore e il nuovo non può nascere”; dove si “verificano i fenomeni morbosi più svariati”: il proliferare di fascismi, razzismi e autoritarismi nello spazio europeo. Cionondimeno, in questa fase vi sono anche le condizioni per le vie di fuga: la via del neomunicipalismo è appunto la costituzione di nuove istituzioni del comune e la sperimentazione di nuove coalizioni tra soggetti subalterni. Rebus sic stantibus: chi esercita il potere? Chi decide delle sorti di una città, di un quartiere, di un territorio?
Come una sorta di Giano bifronte, ci pare che le città ribelli in Europa o – per dirla con Saskia Sassen – “le città che prendono parola” siano custodi di un nuovo che va emergendo, e che abdica alla rappresentanza politica e ai partiti, in un tentativo tanto ambizioso quanto immanente di dare forma al potere costituente. In questa fase, si fronteggiano infatti due campi di forze: un nuovo che fronteggia un vecchio che reagisce tramite violenza, dominio, coercizione.
Da una parte il nuovo: i laboratori metropolitani che adottano pratiche eterotopiche, contro-condotte in grado di far sospendere norme, regolamenti e statuti municipali; che delineano spazi di possibilità liminali, dove qualcosa di diverso non è solo possibile ma necessario per definire delle traiettorie rivoluzionari; dove esperienze di cooperazione, di mutualismo e di innovazione dal basso vanno sovvertendo il quadro politico e sociale consolidato da anni. Certo, in queste città, la questione del potere e della capacità effettiva di decisione non si può risolvere – e non si risolve – nei contropoteri emergenti; infatti, le pratiche eterotopiche delle città ribelli si articolano anche grazie alle soggettività politico-istituzionali che, usando la leva dell’anti-austerità, hanno credibilmente intercettato un malcontento diffuso, lasciando incrinare il “bipolarismo all’italiana”; e parimenti, le medesime soggettività sono il riflesso delle condizioni politiche poste in essere dai movimenti e dai laboratori metropolitani. Ad esempio in Spagna, questo fenomeno comunicante è alquanto apodittico; mentre in Italia, è un riverbero spontaneo, spesso incondizionato, di una composizione sociale – non proprio un blocco sociale – irrappresentata, precaria, danneggiata dalla crisi e dalla svalorizzazione del lavoro.
L’altro campo di forze sono le composizioni di governo rette su partiti che sono sempre più partiti personali, con assai poca persuasione, nondimeno detengono arrogantemente la prerogativa del funzionamento strutturale dello stato, se non dell’avocazione di sempre più poteri eccezionali ed emergenziali; governi che assai spesso non sono neanche eletti oppure, crollate le strutture della rappresentanza, sono al potere per una manciata di voti di elettori – pochi – che non vedono alternativa tra paura e abitudine. Ciò che sorprende è come il sistema della rappresentanza da troppo tempo funzioni nella sua vacuità solamente perché volontà dei potenti, dei detentori di ricchezza, dei produttori di informazione, e dei piazzisti di paura, dei predicatori di superstizione e violenza.
Occorre tornare ai principi, suggerirebbe Machiavelli. Tornare alle fonti della democrazia sostanziale: la partecipazione diretta e non delegata nella costruzione di ciò che è comune. Compito di ciascuno è cominciare un’opera di traduzione di ogni lotta e di ogni momento di partecipazione, consci che da territorio a territorio, da città a città, il rapporto di classe, le forze in campo nella composizione di classe sono differenti, così come differenti sono le forme di empowerment utilizzate dai movimenti. Ciò che accomuna la stagione di neomunicipalismo europeo è la possibilità di far saltare in aria “l’autorizzazione politica”, ossia di rompere il falso sillogismo che dice: “la democrazia è votare, i governi eletti sono democratici, i governi possono fare quello che vogliono fino alle prossime elezioni perché sono democratici”.
Infatti, i laboratori metropolitani sembrano reggersi su tre ipotesi di emancipazione, che sono anche metodi di disarticolazione dell’autorizzazione politica. Vale a dire: a. trasformazione/riforma, b. rivoluzione/ribellione, c. metodologia aperta e concatenata (composta da: agorà metropolitane, partecipazione molteplice e diretta; linee di fuga da meccanismi binari, di chiusura e abitudinari; umanitarismo sostanziale versus vecchi e nuovi fascismi; trasparenza, inventiva e capacità di dialogo; spirito di strada, identità meticce e desiderio di cambiamento). Quanto i laboratori siano pratiche costituenti in grado di decidere sulle sorti della città? Innanzitutto vedremo se saranno in grado di aggredire le questioni radicali di quel Giano bifronte, ossia l’accumulazione estrattiva della rendita, i processi di gentrification, l’urbanizzazione del capitale immobiliare. E se saranno in grado di rispondere alle rivendicazione della cooperazione sociale, alle richieste di emancipazione del lavoro vivo, alle pratiche di sindacalizzazione e mutualismo sociali e alla necessità di ricostruire istituti di solidarietà sociale, in altri termini, nuove forme di welfare.
Certo, l’articolazione delle tre anime dell’emancipazione: trasformazione/riforma, rivoluzione e ribellione sono un programma da tradurre nello spazio dell’Europa delle città ribelli. La spinta trasformativa o riformistica è tanto simmetrica all’ordine esistente quanto è gradualmente capace di inventare e costruire nuove istituzioni della partecipazione, rette sull’uguaglianza sostanziale e su metodi di protagonismo diretti (il suffragio universale o l’uguaglianza di fronte alla legge non sono state forse conquiste rivoluzionarie). La spinta rivoluzionaria, frontale, segnata dall’urgenza, costruisce la proposta in contrasto con la cornice istituzionale, ispirandosi a un programma di massima e agisce come contropotere forte alla cristallizzazione delle istituzioni borghese – rischio sempre in agguato. Ultima, e indispensabile fonte, è la spinta ribelle, un’ecceità che ci riporti ai principi, per superare le forme politiche consolidate del ventesimo secolo e per segnalare le libertà, le uguaglianze e le solidarietà, in base ai nuovi soggetti sociali e alla trasformazione della composizione di classe, su cui vanno costruite le nuove istituzioni del comune.