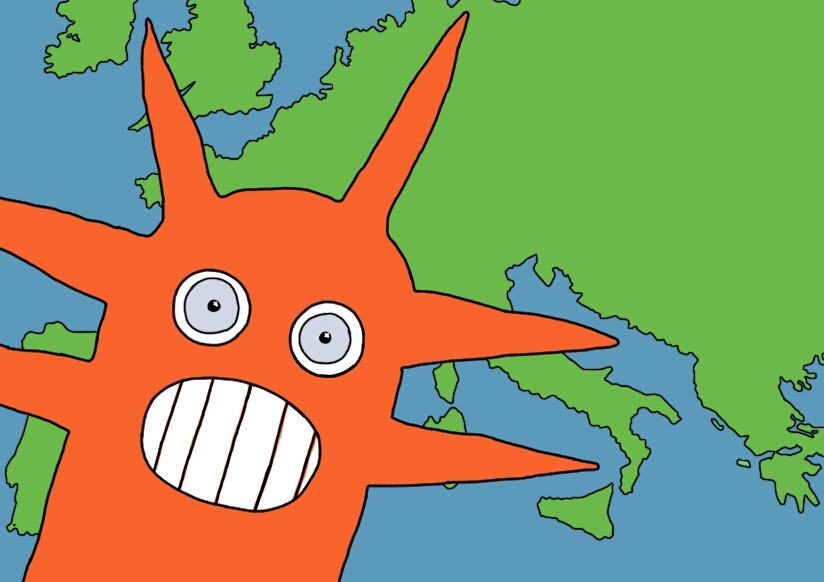di FABIO MENGALI.
Partiamo da un dato di fatto che nessun fa fatica ad ammettere e che i governi per primi non nascondono: l’Europa è in crisi. Sono in crisi l’idea, l’anelito, il concetto storico-politico del Vecchio Continente unito. Un processo di integrazione iniziato formalmente con il Trattato di Roma del ’57 – ma il cui concetto ha iniziato a delinearsi già dal XVII secolo – che aveva l’obiettivo di garantire la pace dopo le ferite della Seconda Guerra mondiale. Certo, il processo di integrazione andava inquadrato nel bisogno di ristrutturare il modo di produzione capitalistico e i suoi apparati di valorizzazione: non è un caso che Foucault si fosse concentrato, per esempio, sulla Scuola di Friburgo e sugli ordoliberali tedeschi nel descrivere la nuova razionalità, emersa dopo la prima metà del secolo scorso, che vedeva nello spazio europeo il suo oggetto di analisi e applicazione.
La crisi può essere presa da molti punti di vista. Possiamo infatti parlare di crisi politica alla luce delle fratture interne alla governance europea; oppure della normalizzazione dell’austerità portata avanti sull’ormai onda lunga della crisi finanziaria e i suoi continui colpi di coda; in ultimo, della crisi che concerne i confini. In questo breve testo, vorrei provare a parlare di questo aspetto in particolare a partire delle esperienze di inchiesta e di mobilitazione, promosse dalla rete “Over the Fortress” e da “Agire nella Crisi”, che si sono verificate nell’ultimo mese: la carovana di solidarietà dal basso a Idomeni, la mobilitazione contro la chiusura delle frontiere il 3 aprile scorso al Brennero e la manifestazione contro l’accordo Turchia-Unione Europea del primo maggio a Roma. Tutti questi momenti interrogano in misura diversa la cittadinanza europea e la trasformazione che sta subendo nell’ultimo periodo.
La cittadinanza europea, da quando è in entrato in vigore Schengen nel 1999, si è caratterizzata per un’estensione della libertà di movimento e di residenza oltre i confini degli Stati nazionali. Dal lato prettamente politico non è corrisposto un potere effettivo di decisionalità democratica a livello continentale; allo stesso modo, un’omogeneizzazione dei diritti, soprattutto sociali, non è in alcun modo stata avviata tra tutti i Paesi membri. Diciamo che nella complessità multilivello dello spazio europeo, in cui molti caratteri sono rimasti in mano al fantasma dello Stato nazionale, la libertà di movimento è stato l’unico aspetto ad essersi modellato sul processo di integrazione europea. Proprio dal ’57 a Roma la pace è la condizione sotto la quale si è iniziato a pensare all’Europa, ad un continente che doveva necessariamente abbandonare la dicotomia del Politico sovranista amico/nemico – almeno al suo interno. La difesa dei confini, storicamente, è sempre servita a questo, a demarcare un territorio sopra il quale il sovrano doveva garantire la “sicurezza pubblica” anche nei confronti di possibili invasioni esterne. Il territorio diventa nazionale, un pubblico privato di un popolo principalmente secondo la linea del sangue e dell’etnia, per difendersi dall’esposizione e dal rischio delle guerre.
Come scritto più sopra, una volta arrivati alla garanzia della pace in Europa, il dispositivo della guerra che organizza le società in Stati nazionali supera i loro confini ottocenteschi. Di qui la possibilità, quarant’anni dopo, di circolare liberamente al di là della cittadinanza nazionale. Una possibilità che si è fatta realtà anche grazie all’abbattimento di quel muro, di quella cortina creata dai decenni di Guerra fredda tra Occidente e Russia, sancito nel 1989.
Non è mai stato tutto oro ciò che luccica: ad un innegabile ampliamento delle possibilità per la vita di milioni di cittadini che vivono in Europa e vogliono spostarsi, si è sempre accostata l’opportunità per il capitale di intensificare i meccanismi di sfruttamento e di valorizzazione. Le persone che si muovono sono forza-lavoro delocalizzata che si sposta in uno spazio eterogeneo per condizioni di produzione e occupazione, nonché di diritti e previdenza sociali. Il divario Nord e Sud Europa era già ben visibile negli anni Novanta quando Schengen è stato concepito e, per scomodare brevemente Gramsci, è sempre stata una differenziazione utile all’estrazione di valore dalle classi subalterne del Sud da parte del capitalismo più avanzato settentrionale. Inoltre, da tenere ben presente che come le persone ottengono la libertà di circolazione in quanto portatrici della merce forza-lavoro, allo stesso modo Schengen doveva liberalizzare il passaggio tra una frontiere e l’altra di uno Stato di tutte le altre tipologie di merce.
L’altra ombra del lato oscuro della libertà di circolazione è delineata dallo spostamento geografico della dicotomia dentro-fuori. Se i confini interni sono stati aperti per coloro in possesso di un passaporto europeo, la conformazione di quelli esterni ha subito un rafforzamento dei controlli e della militarizzazione. I popoli non-europei rimangono in un rapporto potenzialmente bellico con i nuovi cittadini comunitari, tanto da dover giustificare un controllo poroso del passaggio dei migranti provenienti dal Nord Africa, dal Medio Oriente, dall’Est non comunitario. L’evacuazione della guerra dallo spazio interno ai margini del Continente, o in tutt’altra zona del globo, fa fede e invera tale dicotomia. Possiamo, dunque, affermare che i cittadini europei si sono visti spianare le frontiere nella misura in cui i migranti extra-europei hanno visto ergersi dei nuovi sbarramenti via mare e via terra. Rischiando di tagliare con l’accetta la fotografia della situazione fin qui descritta, possiamo dire che la governamentalità biopolitica interna è andata a braccetto con una tanatopolitica nei confronti dei corpi indesiderati dei migranti esterni – una politica di morte che è stata descritta dal “lasciar morire” qualcuno e dall’inclusione differenziale, sfruttando la sua estrema ricattabilità, sotto il dominio del lavoro.
L’esplosione dei flussi migratori a seguito della guerra in Siria ha palesato questo binomio dicotomico della libertà di movimento. Il meccanismo di “selezione di razza e di classe” in atto a Idomeni a causa dell’accordo tra le istituzioni europee e la Turchia di Erdogan disegna bene la divisione tra chi può essere accettato (alcuni siriani o afghani) e chi no. Sicuramente i tedeschi, gli austriaci e i paesi scandinavi accetteranno quel siriano che può essere inserito nell’apparato produttivo nazionale, che può mettere a valore la sua forza-lavoro; mentre quell’ “altro” previsto dall’accordo in questione può essere rinchiuso in un campo di detenzione, lungi dall’essere sottoposto ai benché minimi criteri di rispetto dei diritti umani, e rispedito nella zona di guerra o miseria da cui è fuggito. Credo, però, che la porosità delle frontiere esterne vada vista anche al di là del rapporto, diciamo, meramente tra capitale e lavoro, per quanto sia una dimensione assolutamente centrale per comprendere il fenomeno presente. La migrazione rappresenta in tutto e per tutto una crisi dell’Europa perché ne ha messo in contraddizione degli assunti di carattere simbolico, culturale, politico. Provo a spiegarmi meglio.
Innanzitutto, e non penso sia di poco conto, i criteri di intelligibilità della razza stabiliscono una gerarchia interna tra chi è degno di costruirsi una vita (pur sempre subalterna e sfruttata) dentro i nostri confini e chi no. Contestualmente al concetto di razza utilizzato da Foucault per descrivere la nuova governamentalità nel XIX secolo [Bisogna difendere la società], all’interno della “razza umana” universalmente e giuridicamente riconosciuta dal cosiddetto Occidente dall’impiego dei diritti umani, è come se si individuassero alcune “sottorazze” che disturbano l’equilibrio societario, la cui presenza crea disordini e necessariamente attenta alla sicurezza pubblica. Alcune persone appartenenti ad un’etnia, possibilmente coinvolta in una guerra su cui l’Europa ha degli interessi strategici, vengono giudicate buone in sé, degne di integrazione nella società europea. Tutti coloro che, invece, fuggono dall’indigenza o dalle desertificazioni, dai land grabbing, dai cambiamenti climatici non migrano perché devono essere “salvati” dall’Europa: loro sono i soggetti indesiderati. Ora, per quanto questo aspetto agisca sul livello simbolico-culturale, ciò non significa che non abbia delle ricadute reali nella produzione di soggettività e nella percezione sociale. Gli effetti del razzismo istituzionale che promuove un tale discorso si integrano con il razzismo sociale delle estreme destre, rendendo capillare la diffusione dell’immagine e della narrazione legate ai migranti. Più avanti, guardando alla cronaca politica recente dell’Austria, vedremo l’intreccio tra questi due razzismi.
In secondo luogo, i confini producono una contraddizione nel sistema istituzionale della governance. Per come si è costituita l’Europa economica e politica (in seno alla globalizzazione), sappiamo benissimo che il ruolo dello Stato-nazione è stato fortemente ridimensionato rispetto alla sua sovranità. Lo Stato moderno, la concezione stessa del Politico sono stati ampiamente superati dalla storia dell’ultimo mezzo secolo; e, anzi, se andiamo a scavare grazie ad un lavoro genealogico, scopriamo che il Politico in sé è sempre stato più ideologia che realtà storica. Bene, a partire da questo assunto, possiamo comunque dire che due elementi strutturali statuali hanno continuato a garantire quella presenza fantasmatica dello Stato: la giurisdizione sui confini e sulle forze armate. Certo, non tutto è così lineare, basta pensare ai vari vincoli che gli Stati hanno nei confronti delle missioni belliche oppure a tutti gli interventi apportati dal Consiglio europeo in materia di confini. Eppure, in linea di massima, possiamo stabilire questa affermazione se pensiamo che i confini non solo hanno continuato ad esistere per delimitare un territorio, ma che il loro ritorno è sempre stato formalmente previsto da Schengen stesso. Questo è il motivo per cui molti Stati dell’Unione hanno potuto chiudere le frontiere e erigere muri, appoggiandosi di fatto ad una norma prevista dal Trattato di libera circolazione in caso di stato d’emergenza. Attualmente la migrazione e l’attraversamento di massa dei confini stabiliscono uno stato di emergenza che, in via eccezionale, permette la chiusura delle frontiere. Non è possibile soffermarsi su cosa significhi la normalità dello stato d’emergenza dopo otto anni di crisi finanziaria; basti in questa sede dire che inquadrare la migrazione, vista la sua portata epocale, entro i parametri dell’emergenza comporta soluzioni insufficienti ad affrontarla nel segno dell’accoglienza e dei diritti, così come sposta e rende autoritaria qualsiasi decisione in materia.
Continuando sulla contraddizione Stato-governance, penso che l’attualizzazione nazionalistica dei confini determini in una certa misura una ri-territorializzazione del comando politico. Se la decisione in Europa è sempre stata la risultante di diversi vettori con pesi specifici differenti (dai mercati finanziari, dalle lobby colossali dell’energia e dalle industrie fino alle istituzioni europee sovranazionali colonizzate, comunque, dall’egemonia tedesca), di fronte al rafforzamento dei confini agisce un dispositivo che attualizza nuovamente il comando sovrano dello Stato. E tutto ciò crea ovviamente un cortocircuito rispetto alla governance che ha bisogno di una decisionalità spostata geograficamente e formalmente su di un altro piano. Del resto, i vari tentativi di centralizzare da un punto di vista formale le decisioni dell’Unione Europea, rendendole ancora più vincolanti, con il ripensamento di molti trattati europei e – forse – con una Costituzione europea sono una risposta neoliberale alle spinte centrifughe che ci sono state negli ultimi tempi.
Prendiamo ad esempio l’Austria. La scelta di militarizzare il Brennero e costruire un muro proposta in primis dai socialdemocratici va analizzata da due punti di vista. Il primo si inserisce nel solco del razzismo istituzionale del livello simbolico sopra descritto, con una puntualizzazione da fare: i socialdemocratici hanno fatto dichiarazione altisonanti perché spinti dalla pressione delle destre. I risultati della prima tornata elettorale non lasciano dubbi a questo proposito con l’enorme consenso delle destre populiste. Se le dichiarazioni austriache del centro-sinistra potevano essere un modo per guadagnarsi i consensi di quel centro populista conteso con le destre, ed essere velleitarie sul piano materiale, allo stesso tempo hanno in qualche modo inverato una tale possibilità lasciando il terreno proprio a quelle destre che volevano marginalizzare. La spinta a fortificare il passaggio del Brennero ha destato non poche opposizioni da parte dell’Italia e degli altri Stati della Mittel-Europa in un primo momento; successivamente, sono arrivate da Merkel le giustificazioni ad un simile provvedimento austriaco. Non è certo stata schizofrenia il cambiamento di opinione delle oligarchie europee: la minaccia di un blocco dei confini nazionali è funzionale ad un’ulteriore esternalizzazione del problema della migrazione. La minaccia del blocco del Brennero serviva per giustificare l’applicazione del modello dell’accordo Ue-Turchia in altri Paesi del Nord Africa per fermare sul nascere i nuovi flussi.
Questa strategia, tuttavia, potrebbe risultare controproducente se davvero si avesse una vittoria della destra populista: siamo così sicuri che non deciderà di chiudere il Brennero nonostante i centri di detenzione in Libia? “Chi di sovranità ferisce, di sovranità perisce”, si potrebbe argomentare. Ed ecco che torna il secondo punto di vista, relativo al conflitto tra governance e Stato.
L’uso, seppur strumentale, del dispositivo di sovranità non si riferisce comunque solo alle frontiere esterne e ai migranti non comunitari. Non è un caso che, a seguito della contraddizione palesata dai migranti che spingono per entrare in Europa, anche i neoliberali abbiano deciso di fare uso della sovranità secondo nuove spoglie. Sempre per aggirare e togliere il bacino di consenso alle estreme destre che si diffondono, molti Paesi stanno iniziano a mettere dei limiti materiali alla libertà di circolazione interna allo spazio europeo. Forse non ci saranno mai dei limiti visibili, evidenti, concretamente fatti di barriere, guardrail o gabbiottini, ma degli impedimenti a Schengen di fatto ci sono già. E’ il caso del Belgio, della Germania e della Gran Bretagna, con quest’ultimo Paese che addirittura dovrà andare alle urne a fine giugno su di un quesito che interrogherà la popolazione sul restare o meno in Europa. In tutti questi casi, le restrizioni dell’accesso al welfare e ai diritti sociali per i migranti comunitari diventano dei veri e proprio confini che si materializzano nel momento in cui si vogliono attraversare. Cameron ha ottenuto dalla Commissione e dal Consiglio europeo una moratoria di sette anni sull’obbligo di fornire i servizi ai migranti comunitari (perlopiù del Sud e dell’Est dell’Europa). I confini segnati dall’interdizione degli istituti della riproduzione sociale della vita si manifestano quando una persona decide di muoversi e stabilirsi in un altro luogo dell’Unione Europea. E’ una risposta ulteriore alla migrazione, intesa in senso generale, per continuare a privatizzare la ricchezza sotto l’effige dello spirito nazionalista e a scapito di una sua distribuzione collettiva: per l’accoglienza, per i diritti sociali, per il welfare.
Nell’esperienza diretta della manifestazione del 3 aprile al Brennero si è messa in luce la rivendicazione della libertà di movimento universale. I corpi che hanno disobbedito al divieto di passare il confine con l’Austria hanno segnalato proprio questo punto. Ben sapendo che la sospensione di Schengen per i cittadini comunitari per adesso rimane sul livello della minaccia, ma consapevoli del fatto che per gli oltre cinquecentomila italiani emigrati l’anno scorso esistono ben altri tipi di confine che non sono aggirabili grazie ad una carta d’identità europea; consapevoli anche di cosa voglia dire essere bloccati in un hotspot o in un campo profughi grazie alla partecipazione alla carovana “Over the fortress” in Grecia. Quel confine infame del Brennero, segnato da una storia a tratti tragica di separazione dei popoli, è stato un coacervo di rappresentazioni: della crisi interna alla governance, del ritorno fantasmatico della sovranità sulle frontiere, del governo dei flussi migratori da mettere a lavoro. I “loro” confini, i confini imposti ai migranti in fuga dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Iraq, dalla Libia, eccetera, non parlano solo della disumanità delle condizioni di vita a Idomeni o negli hotspot alle porte d’Europa: parlano di noi, dei nostri confini chiusi per non permettere a loro di passare e che si fanno ancora più stretti, in altre forme, per noi.
La crisi dei confini interroga profondamente la cittadinanza europea, per questo si apre il tempo politico – qui e ora – di agire per dare una direzione in termini di libertà, eguaglianza e diritti al tipo di cittadinanza che vogliamo rivendicare. Quella che vogliamo praticare e di cui vogliamo godere negli anni a venire. Interrompere gli accordi oltraggiosi nei confronti dei migranti con Paesi terzi dittatoriali, opporsi ad ogni forma di barriera sui confini e lottare per la libertà di movimento non sono percorsi contingenti, perché compongono la visione strategica del futuro del nostro essere cittadini d’Europa.
In tempo di crisi, la storia può andare avanti per catastrofe o per salvezza. La cittadinanza europea si sta sgretolando e sta subendo delle torsioni restrittive in questa fase di estrema eccezionalità. E’ questo il tempo di dare una svolta alla storia per salvare l’idea di cittadinanza, trasformandola radicalmente.