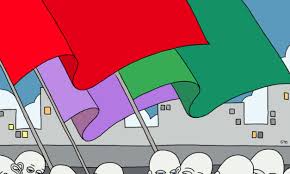di LORENZO RUSTIGHI. «Se la mia vita non vale, producete senza di me». Così recitava uno dei tanti cartelli e striscioni che abbiamo visto sfilare tra Avenida 9 de Julio e Plaza de Mayo, a Buenos Aires, durante lo sciopero delle donne del 19 ottobre. Sciopero. Non c’è a mio avviso una parola più esatta di questa per nominare ciò che è accaduto. Si è trattato di uno sciopero in piena regola, uno sciopero di e in nome delle donne, il primo nella storia dell’Argentina, ma diffusosi come un contagio in molti altri paesi dell’America Latina e perfino in Europa al grido di «Ni una menos», non vogliamo una sola donna in meno – «Non una di meno» sarà anche il nome della manifestazione convocata per il 26 novembre a Roma. La vita di una donna non è sacrificabile, questa è la verità che si è trattato di riaffermare in questo mercoledì di pioggia e di vento, che non hanno scoraggiato le migliaia di persone scese nelle strade. Almeno due sono gli episodi recenti che hanno portato allo sciopero di Buenos Aires. Il primo, che ha raggiunto le cronache di tutto il mondo, è la morte di Lucia, la 16enne di Mar del Plata violentata, torturata, impalata e infine lasciata all’ospedale in fin di vita. Il secondo, meno noto ma parimenti indice della situazione intollerabile e precaria in cui oggi ci si trova ad essere donne e ad agire politicamente come donne (in Argentina, in America Latina, ma in fondo, con differenti gradi di intensità, nel mondo intero): a conclusione del XXXI Encuentro Nacional de Mujeres a Rosario, proprio mentre Lucia andava incontro al suo atroce destino, le donne in corteo sono state oggetto di violente cariche da parte della polizia, intervenuta con il futile pretesto di alcuni graffiti dipinti sui muri della città per rivendicare l’opposizione senza mezzi termini alla cultura patriarcale. Tra gli altri, «Yo aborto sin culpa» (Io abortisco senza sensi di colpa) e «sexo débil, un chiste» (sesso debole, una barzelletta). La legalizzazione e la tutela dell’aborto sono da sempre uno dei temi cruciali del femminismo, ma negli ultimi anni si è imposto con rinnovata urgenza nell’agenda delle lotte. Anche in Europa, dove qualche settimana fa le donne polacche hanno dato vita ad una mobilitazione senza precedenti, capace di bloccare la proposta di legge che mirava a vietare completamente l’interruzione di gravidanza. Nel nostro paese, ancora oggi, la questione continua ad essere di vitale importanza: basti pensare al recente episodio catanese, una giovane donna morta in ospedale dopo una terribile agonia, perché il medico di turno, obiettore, ha rifiutato di intervenire. E non a caso di aborto si è parlato molto, in Argentina, proprio nel corso del Congresso delle donne di Rosario, dove si è trattato di denunciare una volta di più la violenza materiale e simbolica a cui sono soggette tutte quelle donne che – specialmente nelle classi più povere, ça va sans dire – si trovano costrette ad abortire in clandestinità, talvolta al prezzo della vita. La legge prevede l’interruzione di gravidanza in una serie di casi considerati “limite”, come la violenza sessuale o il pericolo per la salute psico-fisica della madre, ma anche in questo caso la procedura è altamente discrezionale. Per quanto riguarda le vittime di violenza sessuale che abortiscono, poi, molte finiscono di fatto in molti casi per divenire oggetto di stigma e riprovazione. Perché sono donne che hanno abusato, esse per prime, del proprio corpo di donna, che si sono prese una libertà che non dovrebbero avere, e che dunque liberamente si offrono all’abuso, lo rendono ovvio. Come Lucia, che in fondo se l’è andata a cercare salendo sull’auto dei suoi carnefici. O come Marina e María José, le due ragazze argentine assassinate in Ecuador qualche mese fa mentre si trovavano in vacanza: anche loro se la sono cercata, le ragazze non dovrebbero viaggiare da sole. È esattamente per disinnescare questa narrazione, il carattere di ovvietà e quasi di destinalità con cui si continua a guardare alla violenza di genere, che è nato il movimento «Viajo sola» e poi «Ni una menos».
Ma per disinnescare occorre cominciare a fare blocco. E cioè anzitutto bloccare, fermare, «parar». Per questo è necessario parlare a tutti gli effetti di «paro», di sciopero. Le donne hanno deciso di fermarsi, di lanciare un messaggio chiaro cessando le loro attività tra le 13 e le 14 (prima, quindi, del corteo delle 17 a cui hanno preso parte decine di migliaia di persone di tutte le età e di diversa composizione sociale e di genere). Dalle casalinghe alle professioniste, dalle operaie alle lavoratrici accademiche, dalle maestre alle infermiere, alle disoccupate, l’idea era dunque quella di congelare il lavoro delle donne, il loro lavoro sociale, allo scopo di renderne visibili la densità, la capillarità, la centralità economico-produttiva. Ma anche, ad un tempo, per rivendicare la stretta interdipendenza tra la sfera cosiddetta produttiva e la mansione riproduttiva che continua ad essere associata – quando non imposta – alle donne, anche a quelle che a vario titolo partecipano direttamente del mercato del lavoro. Fermare il lavoro femminile ha significato fermare questa coesistenza di produzione e riproduzione nel corpo della donna. Dichiarando appunto, nei termini di una sfida, che se la vita delle donne può essere sacrificata si dovrà rinunciare al loro lavoro vivo. Iniziare a dire «provate a produrre senza di noi» ha proprio questo senso, mi sembra. Rifiutare dunque quel lavoro, insieme ai rapporti in cui esso è catturato e addomesticato, ma ad un tempo risoggettivarlo e riappropriarlo rivendicandone il ruolo decisivo, prendendo cioè coscienza di quanto questo lavoro che è il lavoro delle donne sia necessario al capitale. Lavoro declassato e sottopagato, in molti casi, o più semplicemente pagato meno del lavoro maschile, come accade del resto pressoché ovunque. Lavoro invisibile, precario, subalterno. Il che non vuol dire, naturalmente, che il lavoro femminile sia sempre o per lo più lavoro non formalizzato o non salariato, non è evidentemente così. Vuol dire però, questo sì, riuscire a spostare l’attenzione in modo nuovo sulle condizioni materiali in cui si radica il lavoro femminile, come su ciò che è in grado di dirci qualcosa sulle condizioni del lavoro in generale, e più ancora nelle coordinate del capitalismo contemporaneo: il rapporto capitalista come rapporto di sfruttamento a cui è possibile e necessario sottrarsi, rapporto in qualche modo sempre strutturalmente femminilizzato e precarizzato dal lato del lavoro vivo. Detto altrimenti, la subalternità specifica del lavoro femminile nel patriarcato ci parla della subalternità di cui il rapporto di lavoro come tale ha bisogno per funzionare. Si è trattato quindi in altri termini, in questo sciopero, di cominciare a mettere a nudo e a sabotare il cuore del capitale quale è venuto configurandosi negli ultimi anni, e in particolare di ciò che esso è oggi in America Latina. Non si comprenderebbe l’economia latinoamericana, in fondo, se non si scavasse in tutti quei settori che l’economia classica e la sociologia del lavoro classica non contemplano nella sfera dell’economico (del mercato formale) e che dunque banalmente non riconducono a pieno titolo alle categorie classiche del lavoro. In Perù, per fare solo un esempio, si calcola che il lavoro informale copra circa il 70% delle attività economiche. E nel lavoro informale sono impiegate in larga misura proprio le donne. Specialmente nel cosiddetto lavoro di cura, che interessa una grande varietà di attività a partire dal lavoro domestico, sia esso remunerato oppure gratuito. Non a caso l’economia femminista in America Latina insiste e scommette proprio sulla economía del cuidado, che si tratta di strappare alle forme rigorosamente individuali e private in cui l’economia classica tende a relegare – e dunque a rendere invisibili – le funzioni di cura e riproduzione della vita che innervano la società. In particolare, la posta per le lotte femministe consiste in tal senso nella necessità di rendere esplicito il nesso fondamentale che sussiste tra il disciplinamento sociale del cuidado (la sua femminilizzazione o maternizzazione, in primo luogo) e le strategie di espropriazione e sfruttamento del comune che vengono agite nel quadro di inedite forme di accumulazione[1]. In un paese come l’Argentina, dove all’ordine del giorno è il discorso liberale dell’ajuste económico, ciò che in Europa abbiamo conosciuto come austerity, la lotta femminista in questa direzione è più che mai vitale e necessaria, perché più che mai capace di mettere in discussione gli indici apparentemente pacifici e oggettivi del mercato o dello sviluppo. Scioperare, dunque, riprendere in mano il senso e la tradizione dello sciopero operaio, significa affermare che il lavoro delle donne (anche quello informale) è a tutti gli effetti lavoro, anzitutto perché è inscindibile dai dispositivi locali e globali di governo del lavoro che abitano lo sviluppo del capitale; ma di più, significa affermare che è lavoro costitutivamente femminile, vale a dire che si inscrive nei processi di estrazione di valore capitalista in virtù di forme di subalternità, comando e precarizzazione che non sono generiche, ma piuttosto sono specifiche del dominio patriarcale e della sua capacità di disciplinamento ma anche di produzione (e femminilizzazione) del corpo, a partire dal corpo delle donne. Un disciplinamento che in fondo, a ben vedere, è lo stesso che ha investito e martirizzato il corpo di Lucia. Si tratta di mostrare questa continuità, questa coerenza della violenza patriarcale che il capitale certamente non esaurisce ma che si dimostra in grado di colonizzare e mettere a valore. Non a caso è stato notato, e occorre continuare a dirlo, che gli assassini di Lucia non sono semplicemente dei mostri, dei diavoli. Non si tratta di una questione privata, di un caso eccezionale ed esorbitante (dunque socialmente assolutorio), ma si inserisce in una logica complessiva in cui fattori culturali tradizionali coesistono e si alleano con processi di sfruttamento del lavoro vivo delle donne. Mettere al centro dell’agenda politica una dimensione così pervasiva e stratificata come quella della cura, ad esempio, disancorandola in primo luogo dalle forme di estrazione che la attraversano nel quadro del neoliberalismo, vuol dire puntare fino in fondo e ripartendo dal basso sulla priorità operativa e metodologica della vita concreta del lavoro. Se è così, mi sembra che insistere sul senso dello sciopero non implichi oscurare o addirittura inibire la specificità della lotta femminista appiattendola semplicemente sui vecchi registri della lotta di classe. Io direi al contrario che, proprio nella misura in cui il registro delle lotte operaie è oggi irriducibile a quello dell’operaismo classico, la lotta femminista è forse uno dei luoghi di antagonismo più fertili in cui il gesto pratico e teorico operaista sopravvive e non cessa di rilanciare su nuovi fronti la propria sfida al capitale.
 Per questo «fare blocco» lo si può e lo si deve dire anche in un altro senso. Non solo bloccare, sabotare e deviare, ma anche costruire un soggetto politico, un blocco di contro-potere. Lo sciopero, mi sembra, ha avuto e sta avendo anche questa capacità di portare alla luce un processo di soggettivazione di cui si avvertiva da tempo l’urgenza, una presa di parola delle donne come soggetto ad un tempo politico e produttivo. E, con esso, la sua potenza reale che si fa corpo collettivo nella scelta e soprattutto nell’organizzazione del «blocco». Qualcuno ha giustamente posto l’accento sulla rapidità con cui un evento moltitudinario di questo tipo ha potuto costituirsi e propagarsi, e più in generale sull’inattesa efficacia del movimento femminista, per sua natura estremamente eterogeneo, quale canale privilegiato di mobilitazione e organizzazione di lotte in America Latina. Tra le ragioni di questa capacità di fare rete e istituzione si è menzionato ad esempio il cambio generazionale, l’opposizione al governo Macri e alle sue politiche sociali, la forza comunicativa del movimento «Ni una menos». Ma queste non mi sembrano essere ragioni sufficienti. A me pare piuttosto che le radici di questo successo debbano essere cercate altrove, e cioè nella capacità del femminismo latinoamericano (ma credo che si possa dire del femminismo in generale, oggi più che in passato) di pensare, costruire e articolare un’ontologia, per riprendere i termini di un contributo illuminante apparso qualche giorno fa. Un’ontologia positiva, vivente, un essere in comune. Si tratta in effetti a mio avviso, è il caso di ribadirlo, di riuscire a toccare e a manomettere il cuore pulsante del rapporto capitalista agendo dal lato delle donne. Il che non significa affatto guardare alle essenze e, dunque, peccare di essenzialismo. Nel movimento «Ni una menos» e nel Congresso di Rosario, ad esempio, non mi sembra che ci siano tracce, se non minoritarie, di quella tendenza alla santificazione naturalista del grembo materno e del femminile che abbiamo visto imperversare in Italia nei mesi scorsi all’altezza del dibattito sulla gpa, con preoccupanti derive omofobe o trans-fobiche che sono riuscite a mettere sinistramente d’accordo movimenti “pro life”, una parte del movimento femminista e chiesa cattolica. «Siamo donne, trans, travestiti, lesbiche», si proclama apertamente nel documento letto il 19 ottobre a Buenos Aires. Non è quindi di quella vita mortifera e normalizzata che parliamo qui. È un’altra forma di essere – e di essere donne – che qui viene rivendicata ed agita quale esperienza del comune. È tutto un altro modo di pensare e di affermare la vita. Anzitutto attraverso una riappropriazione collettiva dell’opera viva del corpo della donna. Corpo, certo, storicamente prodotto e oggi più che mai rideterminato e assoggettato come corpo che genera, assiste, nutre, cura, riproduce, risparmia. E tuttavia anche corpo che si rende capace di risignificare il proprio lavoro, facendone pietra angolare di strategie di visibilizzazione e soggettivazione di potenze sociali fondamentali, centro di irradiazione di saperi e di pratiche istituenti, infine arma di lotta ad un tempo e con pari forza contro i meccanismi del potere patriarcale e le gerarchie del comando capitalista. Capacità di funzionare come orizzonte ontologico dunque in questo senso, cioè come rimessa in gioco di rapporti materiali concreti, letteralmente scritti sui corpi, e come disinnesco/rovesciamento/riappropriazione delle potenze viventi senza le quali il capitale stesso non può far funzionare la propria macchina. Il femminismo in America Latina, oggi, sta manifestando esattamente questa possibilità di un cambiamento quasi copernicano dello sguardo, che rimette al centro ciò che il capitale non cessa di produrre come periferico, non economico né tanto meno politico. È vero, quell’orizzonte ontologico al femminismo è appartenuto da sempre, fin dalle sue origini. Ma nella speciale congiuntura di crisi delle democrazie sudamericane sta, mi sembra, esprimendo tutta la sua forza dentro una serie di pratiche di contro-potere. Ed è per questo che la lotta e la sua organizzazione non possono essere oggi a mio avviso se non (anche) una lotta e un’organizzazione femministe.
Per questo «fare blocco» lo si può e lo si deve dire anche in un altro senso. Non solo bloccare, sabotare e deviare, ma anche costruire un soggetto politico, un blocco di contro-potere. Lo sciopero, mi sembra, ha avuto e sta avendo anche questa capacità di portare alla luce un processo di soggettivazione di cui si avvertiva da tempo l’urgenza, una presa di parola delle donne come soggetto ad un tempo politico e produttivo. E, con esso, la sua potenza reale che si fa corpo collettivo nella scelta e soprattutto nell’organizzazione del «blocco». Qualcuno ha giustamente posto l’accento sulla rapidità con cui un evento moltitudinario di questo tipo ha potuto costituirsi e propagarsi, e più in generale sull’inattesa efficacia del movimento femminista, per sua natura estremamente eterogeneo, quale canale privilegiato di mobilitazione e organizzazione di lotte in America Latina. Tra le ragioni di questa capacità di fare rete e istituzione si è menzionato ad esempio il cambio generazionale, l’opposizione al governo Macri e alle sue politiche sociali, la forza comunicativa del movimento «Ni una menos». Ma queste non mi sembrano essere ragioni sufficienti. A me pare piuttosto che le radici di questo successo debbano essere cercate altrove, e cioè nella capacità del femminismo latinoamericano (ma credo che si possa dire del femminismo in generale, oggi più che in passato) di pensare, costruire e articolare un’ontologia, per riprendere i termini di un contributo illuminante apparso qualche giorno fa. Un’ontologia positiva, vivente, un essere in comune. Si tratta in effetti a mio avviso, è il caso di ribadirlo, di riuscire a toccare e a manomettere il cuore pulsante del rapporto capitalista agendo dal lato delle donne. Il che non significa affatto guardare alle essenze e, dunque, peccare di essenzialismo. Nel movimento «Ni una menos» e nel Congresso di Rosario, ad esempio, non mi sembra che ci siano tracce, se non minoritarie, di quella tendenza alla santificazione naturalista del grembo materno e del femminile che abbiamo visto imperversare in Italia nei mesi scorsi all’altezza del dibattito sulla gpa, con preoccupanti derive omofobe o trans-fobiche che sono riuscite a mettere sinistramente d’accordo movimenti “pro life”, una parte del movimento femminista e chiesa cattolica. «Siamo donne, trans, travestiti, lesbiche», si proclama apertamente nel documento letto il 19 ottobre a Buenos Aires. Non è quindi di quella vita mortifera e normalizzata che parliamo qui. È un’altra forma di essere – e di essere donne – che qui viene rivendicata ed agita quale esperienza del comune. È tutto un altro modo di pensare e di affermare la vita. Anzitutto attraverso una riappropriazione collettiva dell’opera viva del corpo della donna. Corpo, certo, storicamente prodotto e oggi più che mai rideterminato e assoggettato come corpo che genera, assiste, nutre, cura, riproduce, risparmia. E tuttavia anche corpo che si rende capace di risignificare il proprio lavoro, facendone pietra angolare di strategie di visibilizzazione e soggettivazione di potenze sociali fondamentali, centro di irradiazione di saperi e di pratiche istituenti, infine arma di lotta ad un tempo e con pari forza contro i meccanismi del potere patriarcale e le gerarchie del comando capitalista. Capacità di funzionare come orizzonte ontologico dunque in questo senso, cioè come rimessa in gioco di rapporti materiali concreti, letteralmente scritti sui corpi, e come disinnesco/rovesciamento/riappropriazione delle potenze viventi senza le quali il capitale stesso non può far funzionare la propria macchina. Il femminismo in America Latina, oggi, sta manifestando esattamente questa possibilità di un cambiamento quasi copernicano dello sguardo, che rimette al centro ciò che il capitale non cessa di produrre come periferico, non economico né tanto meno politico. È vero, quell’orizzonte ontologico al femminismo è appartenuto da sempre, fin dalle sue origini. Ma nella speciale congiuntura di crisi delle democrazie sudamericane sta, mi sembra, esprimendo tutta la sua forza dentro una serie di pratiche di contro-potere. Ed è per questo che la lotta e la sua organizzazione non possono essere oggi a mio avviso se non (anche) una lotta e un’organizzazione femministe.

Occorre allora essere in grado di allontanare, se non di neutralizzare, la litania democratico-liberale di quel contro-movimento che ha preteso di chiamarsi «Nadie menos», Nessuno in meno, che postula la necessità di una sorta di umanismo universale in cui qualunque forma di violenza sia rifiutata a prescindere da genere, razza, classe, ecc. Più in generale, occorre prendere le distanze dal discorso apparentemente così pulito e ragionevole dell’inclusività – mi è capitato spesso, recentemente, di trovarmi a discutere con chi accusa il femminismo radicale di produrre semplicemente nuove esclusioni, di limitarsi a ribaltare specularmente l’ordine del patriarcato, riproducendo il gioco del nemico. Occorre farlo perché è la voce del capitale a parlare dentro quel tipo di logica, al di là della buona fede dei suoi singoli sostenitori. È quella voce che da sempre non può fare altro che squalificare le lotte, a partire dalle lotte operaie, equiparandole tout court alla violenza di quelle strutture di dominio che combattono. E lo fa esattamente attraverso quell’illusionismo della ragione(volezza) che pretende di astrarsi dalla guerra, di tirarsene fuori. La lotta femminista invece è e non può che essere una lotta partigiana, di e per una parte. Una parte che non pretende di parlare per il tutto ma che in qualche modo ci parla appunto del o dal comune. Meglio ancora, la lotta femminista è forse una delle poche lotte che oggi siano in grado di costituire e organizzare politicamente quella parte che non possiamo astenerci dal prendere dentro una guerra – una guerra reale, sempre più tangibile, dove anzitutto si combatte per la vita in un contesto di uccisione brutale. «¡Vivas nos queremos!» è stato gridato il 19 ottobre, pretendiamo di vivere e siamo pronte a combattere per questo. Pensare un’ontologia, quindi, anche con questo ulteriore significato, che ha a che fare con un agire sempre necessariamente «di parte» e dunque con la disattivazione di uno slegame e di un isolamento che continuano a definirsi all’altezza di quel vuoto «Nessuno» sempre così saggiamente riaffermato dal discorso liberale.
Milagro Sala, anima del movimento indigenista Túpac Amaru a Jujuy e detenuta dal 16 gennaio 2016 con l’accusa di istigazione a delinquere e al tumulto, ha mandato dal carcere la propria adesione allo sciopero: «Quando noi donne ci alziamo in piedi, riusciamo sempre a realizzare trasformazioni importanti». Credo che sia proprio questa forza di alzarsi in piedi e di tenere i piedi per terra che, oggi più di prima, deve essere presa sul serio. Dire «sesso debole», qui, è davvero una barzelletta fuori tempo massimo.

[1] Cfr. N. Quiroga Díaz e V. Gago, «Los comunes en femenino. Cuerpo y poder ante la expropiación de las economías para la vida», Revista Economía y Sociedad, vol. 19, n. 45, 2014.