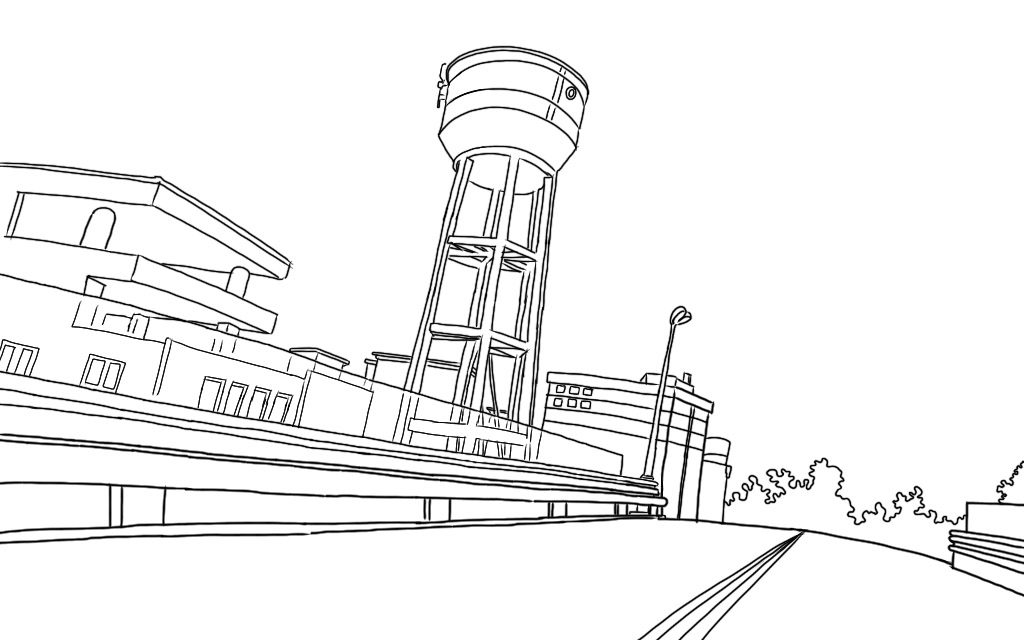di PIER VITTORIO AURELI.
Nella storia del Movimento Operaio, la fabbrica ha avuto un ruolo fondamentale e per certi versi epico nel coagulare sia lo sfruttamento degli operai, sia la lotta di questi ultimi contro la loro condizione. Per questo l’apparente scomparsa della fabbrica quale punto avanzato del capitalismo nel mondo così detto sviluppato è stata spesso interpretata come una vera e propria sparizione della classe operaia quale blocco importante della società. Se questa interpretazione segue la realtà della tendenza industriale degli ultimi quaranta anni, ovvero il passaggio dall’egemonia del lavoro materiale a quella del lavoro immateriale, ha anche dato luogo ad una visione della fabbrica come spazio chiuso in se stesso, come luogo specifico della produzione di merci materiali. Eppure il marxismo degli anni Sessanta, nella fattispecie dell’Operaismo, fu, tra le altre cose, anche la riscoperta della fabbrica come campo esteso che inevitabilmente ingloba nel suo funzionamento tutta la società.
Operai e capitale di Mario Tronti è sicuramente un libro difficile da staccare dallo sfondo della fabbrica fordista-taylorista, eppure anche questo tipo di fabbrica, sin dalla sua invenzione all’inizio del secolo scorso, eccedeva il proprio confine perché per funzionare, cioè per subordinare chi vi lavorava doveva ramificarsi in tutti gli ambiti sociali: la casa, la scuola, la cura medica, il tempo libero. È proprio nel cogliere questo passaggio che il libro di Tronti ebbe una certa risonanza nella cultura architettonica in Italia tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta. Le tesi del libro influenzarono tra gli altri il progetto critico e storiografico di Manfredo Tafuri e il lavoro del collettivo Archizoom. Inoltre tra gli stessi militanti operaisti vi furono sociologi, architetti e urbanisti come Romano Alquati, Claudio Greppi, Alberto Magnaghi, Paolo Deganello che proprio in quegli anni misero a tema il ruolo delle lotte nello sviluppo urbano individuando nel territorio attorno alla fabbrica – ovvero la città fabbrica – il campo allargato dello sfruttamento capitalistico e dello scontro di classe1.
Per quanto Operai e capitale fu pubblicato all’apice dello sviluppo della fabbrica fordista-taylorista in Italia, cui poco dopo le lotte operaie metteranno in crisi l’assetto, il modo nel quale il libro concettualizza il rapporto fabbrica-società eccede la sequenza netta «fordismo»/«post-fordismo» con cui è stato descritto lo sviluppo delle forme di lavoro.
Anche se Operai e capitale fu letto allora nel segno della centralità della fabbrica in quanto luogo della produzione, nel libro la fabbrica è teorizzata come apparato che lega il lavoro alla res extensa della valorizzazione sociale, vale a dire la fabbrica come dispositivo attraverso il quale tutta la società viene messa al lavoro. Partendo da questa interpretazione delle tesi di Tronti propongo di rileggere la lunga storia del territorio che va dalla metropoli moderna all’urbanizzazione planetaria, cercando di individuare nel concetto di fabbrica un paradigma (ancora) utile per leggere la condizione urbana contemporanea.
1. Nel libro Großstadt Architektur, pubblicato nel 1927, l’architetto tedesco Ludwig Hilberseimer sosteneva che con l’avvento del capitalismo la città rompeva risolutamente con la sua storia millenaria e si presentava come qualcosa di completamente nuovo: la Großstadt appunto, la grande città, la metropoli2. Rispetto a questo tipo di città ogni continuità con il passato è per Hilberseimer impossibile. Il capitale impone alla città non tanto un salto di scala, ma una diversa configurazione che la rende incompatibile con forme urbane tradizionali.
Si può dunque sostenere che l’avvento del capitalismo pone fine alla città quale entità politica sovrana (la civitas), e la sostituisce con una macchina economica in cui città e territorio, dentro e fuori sono integrati in un sistema totalizzante. Certo la città come centro sopravvive ma solo come feticcio, come simbolo, al massimo come leva per la rendita.
Prima di Hilberseimer è stato l’ingegnere spagnolo Ildefonso Cerdà, l’autore del celebre piano urbanistico di Barcellona del 1859, a sostenere che, con l’avvento dello sviluppo industriale, il concetto di città in quanto civitas era oramai anacronistico. Nella sua importante opera Teoria generale dell’urbanizzazione pubblicata lo stesso anno de Il capitale di Marx nel 1867, Cerdà riteneva già che il termine città dovesse essere sostituito con il neologismo urbanizzazione, vale a dire spazio in cui circolazione di merci e persone prendeva il sopravvento su qualsiasi altro aspetto dello spazio abitato3. Ciò che caratterizza la teoria urbanistica di Cerdà è la centralità che egli dava allo studio della popolazione a partire dalle condizioni di produzione-riproduzione della forza lavoro. Cerdà è il primo urbanista a fondare il progetto urbano su fonti statistiche, ottimizzando così la riforma urbana in base alle condizioni di vita della società e alla sua capacità di produrre. Per questo, come ha notato Andrea Cavalletti, l’ingegnere urbanista spagnolo è erede di tutto quel sapere urbano che si sviluppa nel segno della Polizeiwissenschaft in cui sicurezza, medicina ed economia si fondono nelle pratiche di governo del territorio4.
Teorie come quella di Cerdà postulavano che la città come entità differenziata dal territorio cessasse di esistere, sostituita da un sistema dislocato, senza più un fuori, potenzialmente estendibile all’infinito la cui funzione non è più quella di produrre una forma, bensì di essere processo, macchina funzionante che lega, dentro il medesimo apparato, circolazione e abitazione. È interessante notare come in un testo che la storiografia architettonica ha sempre letto come la magna carta dell’urbanistica classica, ovvero la Carta d’Atene redatta nell’ambito del Congresso di Architettura Moderna (CIAM) nel 1933 e di fatto scritta da Le Corbusier, vi sia una grande enfasi sul nesso produzione-vita come principale obbiettivo del progetto urbanistico.
Certo la Carta di Atene proponeva la divisione delle funzioni – circolazione, lavoro, abitazione, tempo libero ecc. – ma tale separazione era strumentale a una maggiore e più efficiente integrazione di questi momenti verso un sistema urbano in cui tutti gli aspetti della vita urbana diventassero il medesimo processo di riproduzione sociale.
Per Le Corbusier, come per Cerdà e Hilberseimer, l’organismo urbano non poteva essere più concepito nelle forme tradizionali della città, intesa come un centro opposto al suo intorno – la campagna o la periferia – ma si costituiva come una nuova entità, ovvero come territorio urbano.
Pur rimanendo dentro l’orizzonte riformista, che pretende di domare le forze della grande metropoli, dentro l’utopia razionalista del piano, questi approcci al territorio mettono a tema qualcosa che già allora eccedeva la ragione del piano, ovvero un paesaggio nuovo, inedito, sempre mobile e dunque spiazzante. Questo paesaggio è l’urbanizzazione intesa come processo incontenibile, e dunque privo di una forma definitiva. L’esperienza soggettiva di questo paesaggio fu compresa solo da coloro che avevano fatto i conti con il «pensiero negativo» della metropoli moderna, ovvero Georg Simmel e la sua relazione tra circolazione del denaro e esperienza dello spazio urbano; Max Weber, con l’analisi della città come macchina per l’accumulazione del potere politico ed economico; Walter Benjamin e la sua analisi dell’architettura della grande metropoli dell’Ottocento come fantasmagoria che nasconde, mistificandolo il conflitto di classe. Ciò che accomuna questi pensatori e le loro letture della metropoli è lo sforzo di dare forma ad una soggettività disincantata, un modo di essere che sia all’altezza della metropoli del capitale.
2. Oggi siamo portati a vedere queste «scoperte» della metropoli capitalista come delle ovvietà. Metropoli o Großstadt suonano come termini desueti, vintage, tant’è che siamo abituati a ben altre categorie dello spazio urbano come città diffusa, slums, urbanizzazione planetaria, capitalocene. Eppure nell’ambito del pensiero urbano pochi studiosi sono riusciti a tematizzare il rapporto tra capitale e forma urbana, al di là dei fenomeni più vistosi e ovvi come la speculazione, la rendita e la «gentrificazione». L’ideologia borghese delle scienze sociali ha talmente impregnato l’urbanistica che la storia della città è stata per lo più letta nei termini di un inesorabile progresso tecnologico, un’espansione inevitabile dell’urbano, esito naturale dello sviluppo delle forze produttive, piuttosto che come un sommovimento strutturale che cambia la composizione fisica sociale e politica di ciò che continuiamo a chiamare città. Sommovimento qui vuol dire rivoluzione e non evoluzione, perché – ed è bene ricordarlo – la metropoli del capitale nasce non dal proprio spirito imprenditoriale come molte storie della città moderna ci hanno raccontato, ma dalle lotte, dai tumulti degli oppressi e dalla controparte di questi ultimi ovvero dalle contro-rivoluzioni, dagli stati di eccezione politici ed economici che il capitale ha messo in atto per mantenere il suo paradossale ordine delle cose, vale a dire un ordine fondato sul disordine. Il disordine della metropoli capitalista non è quindi un «errore» del processo, una condizione di default come teorizzava l’urbanistica riformista. Il disordine della città capitalista è l’esito dello stato di guerra permanente che è necessario al capitale per controllare e costringere al lavoro i propri subalterni.
È qui che la tesi centrale di Operai e capitale di Mario Tronti – prima le lotte, poi lo sviluppo – si applica anche alla nascita e allo sviluppo della città moderna: prima le lotte, poi la città, il suo progetto, le sue trasformazioni e la sua architettura. Il progetto della città moderna non è altro che la risposta, da parte del capitale, al conflitto di classe. Le Corbusier lo aveva capito bene quando poneva les autorités di fronte al dilemma: architettura o rivoluzione5.
La rivoluzione paventata da Le Corbusier era lo spettro della rivoluzione bolscevica del 1917, che di lì a poco avrebbe costretto i capitalisti a ripensare la composizione politica del comando sul lavoro dando così vita al welfare state. Ma in fondo la rivoluzione che evocava Le Corbusier altro non era che la minaccia della forza lavoro di ribellarsi al proprio sfruttamento, una minaccia che come sosteneva Tronti era dentro lo sviluppo del capitale perché quest’ultimo non era altro che sfruttamento del lavoro vivo. Da parte dei governi e dei capitalisti la rivoluzione di classe era, dunque, qualcosa da scongiurare ma anche da utilizzare a proprio vantaggio, visto che, dai tumulti delle città comunali del Trecento alle rivoluzioni nelle grandi metropoli dell’Ottocento, lo scontro di classe aveva sempre segnato l’inizio dei grandi progetti di trasformazione urbana.
Non è dunque per brama tecnocratica che l’architettura della fabbrica diventa per gli architetti del Movimento Moderno come Le Corbusier, Hilberseimer, ma anche per Ludwig Mies van der Rohe, il paradigma architettonico da cui estrarre la nuova architettura. Per gli architetti moderni la fabbrica non è semplicemente la metafora dell’epoca macchinista ma è una vera e propria miniera di soluzioni tecniche da estendere a tutta l’architettura della città. L’uso del ferro e del cemento armato, la standardizzazione e prefabbricazione degli elementi costruttivi, tecniche messe appunto nell’architettura della fabbrica tra Ottocento e Novecento, vengono riprese dagli architetti moderni in tutti gli ambiti della città e del territorio: dall’abitazione alle infrastrutture, dagli edifici pubblici al design di interni. Si pensi ad esempio a come l’architetto austriaco Margarete Schütte-Lihotzky disegna la celeberrima «cucina di Francoforte», attraverso l’applicazione dei criteri di misurazione e coordinamento del lavoro in fabbrica al lavoro domestico.
La metropoli e il suo territorio diventano così una catena di montaggio di «fatti sociali» per parafrasare il titolo della No-Stop City, il celebre progetto del 1970 con il quale il gruppo Archizoom sviluppava le tesi di Operai e capitale. Ben prima che si iniziasse a parlare di «fabbrica diffusa» e di «operai sociali», la metropoli moderna aveva da tempo esteso la fabbrica a tutta la società.
3. La fabbrica dunque non è soltanto un luogo specifico della città moderna ma è un concetto che fa perno sull’idea della metropoli come organismo territoriale flessibile ed estendibile all’infinito, il cui compito è riprodurre e organizzare il lavoro vivo. Originariamente la parola «fabbrica» significa edificio, non tanto nel senso di forma dell’edificio quanto di congegno, macchina, artifizio.
Il senso comune intende fabbrica come un luogo circoscritto in cui avviene la produzione di determinate merci. Il pensiero politico ha inteso la fabbrica come il passaggio al capitalismo maturo che segna la fine delle forme tradizionali di manifattura e lo sostituisce con un sistema macchinico in cui gli operai non usano le macchine, ma sono queste ultime ad usare gli operai. In realtà la fabbrica ha una storia molto più complessa e irriducibile agli stereotipi che hanno tentato di rappresentarne l’evoluzione. La fabbrica non è un edificio e nemmeno un luogo; la fabbrica è piuttosto un insieme di macchine, un diagramma spaziale la cui funzione è quella di adeguare lo spazio fisico alla composizione tecnica che rende possibile il lavoro produttivo e il suo sfruttamento. La fabbrica dunque non ha una forma definitiva, ma è piuttosto un processo in continua trasformazione che, da un centro di volta in volta strategicamente rilocalizzato, innerva e organizza il territorio. Se c’è una fabbrica c’è una rete logistica che coordina macchine, trasporti, flussi di persone, materie prime, merci: il campo d’applicazione della fabbrica è sempre il territorio.
In principio le factories erano strutture leggere, anonime, posizionate lungo rotte militari e traffici commerciali per facilitare la colonizzazione di terre indigene. Come ha notato Carl Schmitt, diversamente dal colonialismo spagnolo e portoghese basato sulla conquista e la spartizione di grandi spazi, il colonialismo inglese fu un processo capillare di appropriazione, costituito dalla realizzazione di infrastrutture, canalizzazioni, strutture logistiche, trattati commerciali, e che eseguiva accurate mappature e misurazioni di risorse naturali da sfruttare6.
Per quanto la fabbrica è identificata con il passaggio dalla manifattura all’industria, la natura profondamente logistica della fabbrica ha origine proprio nella colonizzazione e gestione del territorio agricolo. Il termine factory proviene dal latino facere, fare e in origine è il factorium (da cui viene anche il termine fattoria) ovvero il frantoio, ma anche la postazione dei fattori incaricati dal proprietario terriero di gestire il territorio agricolo. Nel medioevo la factory è un luogo di raccolta per mercanti, e uomini d’affari in viaggio in terre straniere, e come tale dotato di magazzino e mercato7.
L’etimologia del termine ci fa capire che il concetto di fabbrica investe subito il territorio come spazio da mettere strategicamente sotto controllo, in modo da possederlo. Ma nella fabbrica questo possesso non è soltanto militare come nel castrum o nel forte, ma essenzialmente logistico ed estrattivo. In fondo il termine stesso territorium come scrive Cicerone indica il possesso della terra, l’area di influenza di un’istituzione o comunità. Il colonialismo allarga questa influenza dalla terra al mare facendo di quest’ultimo il paradigma geografico della modernità per antonomasia. Nei Lineamenti per una filosofia del diritto Hegel sosteneva che la storia della civiltà europea poteva essere letta come un conflitto tra terra e mare, vale a dire un conflitto tra la stanzialità della famiglia e la città e il campo aperto, mobile ed incerto del commercio marittimo8. L’ethos del mare è l’industria nel senso originale del termine, vale a dire destrezza, sollecitudine, capacità di innovazione per far fronte a situazioni avverse ed incerte. Il colonialismo degli ultimi cinque secoli è stato così un laboratorio di tecniche di appropriazione che con la nascita della grande industria è stato riversato sul territorio dei colonizzatori. Non è un caso che il capitalismo industriale nasce proprio in Inghilterra ovvero la prima nazione che aveva fatto del mare il proprio ambito di espansione imperialista. La così detta «rivoluzione industriale» non è stata altro che un processo di colonizzazione interna del continente europeo, una colonizzazione che per funzionare ha dovuto – da subito – mettere al lavoro non solo gli operai ma tutta la società.
4. Nel concettualizzare il dispositivo fabbrica e non relegarlo a feticcio tipologico o tecnologico, Operai e capitale ci offre un quadro categoriale ancora efficace. Nel capitolo La fabbrica e la società (pubblicato dapprima nel 1962, nei «Quaderni Rossi»), Tronti scrive che se nel processo lavorativo il capitale è comando sul lavoro, è solo nel processo di valorizzazione – vale a dire all’interno della società – che il capitale sviluppa il suo potere di coercizione che forza i lavoratori a consegnarsi allo sfruttamento9. «Il capitale riesce a cogliere, in un modo suo proprio – scrive Tronti – l’unità di processo lavorativo e processo di valorizzazione: e tanto più riesce a coglierla quanto più si sviluppa la produzione capitalistica e quanto più la forma capitalistica della produzione si impadronisce di tutte le altre sfere della società, invade l’intera rete dei rapporti sociali»10. Ciò che in questo passaggio viene messo in evidenza è il processo di «fabbrichizzazione» della società: la fabbrica si lega indissolubilmente al territorio e dunque alle sue forme di vita.
Come ricorda Tronti, Marx fa risalire il processo di messa a lavoro della società al passaggio cruciale della regolamentazione della giornata lavorativa, quando si passa dal plusvalore assoluto al plusvalore relativo. Incalzato dalle lotte operaie, il capitale non può semplicemente sfruttare il lavoro così come lo trova ma deve plasmare il processo lavorativo «a sua immagine e somiglianza», cioè colonizzando ogni momento della vita sociale, determinandone i tempi e i luoghi.
La regolamentazione della giornata lavorativa è dunque uno dei modi in cui stato, società, pubblico, privato, lavoro, vita, tempo e spazio si fondono all’interno del capitale fino a costituire il continuum dello sfruttamento. È per questo che il territorio si fa – come afferma Tafuri in Per una critica dell’ideologia architettonica – macchina per l’estrazione del plusvalore da tutti i rapporti sociali11. Strade, case, ferrovie, parchi, attrezzature per il «tempo libero», ma anche pianificazione, rendite, speculazione immobiliare, opere pubbliche, infrastrutture di ogni tipo, sono messi in opera sia come momenti del processo produttivo ma anche come apparati di cattura e organizzazione della vita umana. Eppure è proprio nel momento in cui il capitale realizza questo rapporto tra le cose sempre più organico e totalizzante che riesce anche a mistificarlo e a renderlo per così dire invisibile. Tronti osserva che nel momento in cui l’intera società è sussunta dalla produzione capitalista, la fabbrica paradossalmente scompare, ed è a questo punto che si realizza appieno l’ideologia borghese, ovvero l’ipostatizzazione del «sociale» come qualcosa in cui la potenza del lavoro è considerato soltanto un momento della vita sociale12.
La scomparsa della fabbrica dalla società, nel momento in cui tutta la società si fabbrichizza, non consiste solo in ciò che sarebbe avvenuto poco dopo Operai e capitale, ovvero nella rilocazione della fabbrica e nell’informatizzazione del comando sul lavoro, ma anche e soprattutto l’occultamento da parte del capitale di ciò che l’operaismo femminista definì qualche anno dopo l’uscita del libro di Tronti come l’arcano della riproduzione, ovvero lo sfruttamento del lavoro riproduttivo e affettivo necessario alla formazione della classe operaia13. Insomma dentro la fabbrica che diventa società non ci sono solo gli operai (maschi) ma, come scriveva Leopoldina Fortunati, anche le casalinghe e le prostitute il cui lavoro è stato per secoli nascosto e sfruttato dentro quella formidabile invenzione borghese che è la casa come «rifugio privato» quale luogo del non-lavoro.
5. Riposizionato in questo contesto Operai e capitale coglie un passaggio fondamentale che ancora oggi spiazza la scansione netta tra «fordismo» e «post-fordismo» su cui tanto ha insistito la tradizione operaista e post-operaista. La fabbrica sociale, la messa al lavoro della società a partire dalla sua stessa riproduzione, l’unità sempre più organica tra processo di lavoro e processo di valorizzazione e il ruolo delle lotte come energia propulsiva di questi processi, non hanno fatto altro che rafforzarsi nel così detto post-fordismo ma sono già presenti in nuce nei processi di urbanizzazione che a partire dal Medioevo hanno dato forma al territorio europeo e poi all’intero pianeta. Ciò che chiamiamo «Rinascimento» (un termine inventato, non a caso, dalla cultura borghese dell’Ottocento per mistificare l’origine conflittuale del proprio potere di classe) non è altro che l’inizio di quella grande contro-rivoluzione capitalista il cui obbiettivo era di costringere masse di persone a diventare operai salariati. Ne Il capitale Marx raccontò il momento originario – il peccato originale – di questo processo, disvelando la violenza dell’accumulazione primitiva, ovvero l’appropriazione della terra comune da parte dei primi proprietari terrieri che costrinse masse di persone a vendere la propria forza lavoro in città. È in questo violento passaggio storico che si forma il proletariato, costituendosi quest’ultimo storicamente prima del sistema capitalistico. Come scrive Tronti: prima il proletariato, poi la forza lavoro; prima gli operai politicamente come classe, poi lo sviluppo capitalista.
Operai e capitale ci ricorda che il rapporto di classe tra chi vende e chi compra forza lavoro è il fondamento del rapporto capitalistico. Questo rapporto prende forma nel Medioevo quando gli operai espropriati iniziano a minacciare non solo i padroni ma anche i governi municipali e le arti che difendono i diritti degli operai-imprenditori, i futuri padroni. Le arti maggiori, ovvero le prime istituzioni politiche della borghesia, attaccavano i magnati che minacciavano il potere democratico dei Comuni, ma reprimevano il nuovo proletariato urbano, la vera forza lavoro necessaria alla formazione del capitale. Cosa altro è l’invocazione dell’antica Roma che tanto anima la grande arte del Rinascimento se non la creazione del mito della Pax Romana contro i tumulti operai barbari che sconvolgono l’ordine della civitas medievale?
Scienza, cultura, civilizzazione rinascono nel XV secolo non nel segno dell’umanesimo ma come conseguenza dell’antagonismo tra la classe dei capitalisti e la classe operaia. Di fronte a questo antagonismo la classe dei capitalisti non ha scelta: la città e il territorio devono essere concepiti come un sistema. La città ideale rinascimentale con le sue piazze geometriche e le sue strade diritte non è altro che esorcizzazione del conflitto e sublimazione ideologica della necessità di un controllo esteso dello spazio.
Entrano in scena dispositivi sociali il cui compito è quello di catturare e mettere al lavoro il corpo sociale. Già nel Cinquecento Sebastiano Serlio include nel suo trattato sulle abitazioni – il Libro VI, Sulle habitationi di tutti li gradi de gli huomini – modelli di case non solo per tiranni o ricchi professionisti ma anche per poveri contadini e artigiani, questi ultimi essenziale forza lavoro che occorreva strappare al vagabondaggio e inchiodare alla routine domestica e alla proprietà privata della casa.
Vi è poi l’invenzione della prospettiva che è frutto non tanto della volontà di rappresentare scientificamente lo spazio tridimensionale nella superficie bidimensionale dell’immagine dipinta, ma della volontà di possedere nella sua estensione totale lo spazio dell’esperienza, dando ad esso una misura certa e scientifica. La rappresentazione prospettica, infatti, presuppone il rilevamento topografico del territorio che è possibile soltanto attraverso una concezione matematica dello spazio tra le cose. In fondo l’astrazione reale del denaro come equivalente universale nel quale tutte le cose diventano merce nasce dalla stessa astrazione dello spazio prospettico in cui tutto deve essere potenzialmente conoscibile da un sistema generale e certo come se tutto dovesse essere immesso nella logica del valore di scambio.
Come ha osservato lo storico dell’arte Marvin Trachtenberg, l’evoluzione della scienza prospettica nel Medioevo riceve un impulso decisivo dai tentativi di riforma dello spazio urbano avanzati dalle autorità delle città comunali contro l’instabilità sociale che minacciava l’efficacia del loro governo14. Non è un caso che Firenze tra il XIV e il XV secolo diviene l’epicentro di questa rivoluzionaria concezione dello spazio e del territorio: fu qui che nel Trecento si susseguirono vorticosamente conflitti sociali come il famoso Tumulto dei Ciompi del 1378, la prima rivolta operaista della storia proprio perché, come ha scritto Ernesto Screpanti, essa fu un grandioso esempio di rivoluzione proletaria moderna scoppiata nel punto più alto dello sviluppo capitalista di allora15.
In questo contesto conflittuale l’architettura svolge un ruolo fondamentale facendosi disciplina al servizio del governo urbano, distinguendosi così dalla attività artigianale del costruire e investendo il proprio sapere verso il calcolo e il progetto. Se da una parte l’architettura è progetto di monumenti che servono a manifestare l’ideologia del potere, dall’altro è anche pratica di riforma e controllo dello spazio urbano in cui l’uso della geometria, il calcolo, il rilevamento topografico, l’arte militare si fondono verso una concezione del potere non più simbolica ma spaziale. Si pensi a come il progetto architettonico in quanto pratica distinta dall’arte del costruire sviluppa il proprio arsenale di tecniche di rappresentazione dello spazio sotto l’impulso di progetti di infrastrutturazione del territorio nel quale arte civile e arte militare sono sempre meno ambiti operativi distinti. Gli architetti rinascimentali come Filippo Brunelleschi o Francesco di Giorgio Martini progettano macchine che servono a fare la guerra ma anche a organizzare la vita civile e soprattutto a far lavorare gli operai come nel caso delle innumerevoli macchine progettate da Filippo per il turbolento cantiere della Cupola di Santa Maria del Fiore dove un celebre sciopero degli operai del duomo aveva minacciato di fermare i lavori. È da questi eventi che nasce un sapere sempre più rivolto alla gestione della città come processo sociale. La fabbrica è dunque la visione della città come insieme di macchine il cui sviluppo dipende dall’intensità del conflitto che esse devono fronteggiare.
6. La fabbrica fordista è impensabile senza il processo di trasformazione della città e del territorio in macchina sociale. Il celebre assunto del post-operaismo che la moltitudine sta alla città come gli operai stanno alla fabbrica, per quanto utile e suggestivo rischia però di ipostatizzare la fabbrica come una struttura rigida e immobile, rischia cioè di non farci cogliere come il territorio urbanizzato sia dal principio la vera fabbrica. Peraltro l’idea della fabbrica fordista-taylorista come una struttura rigida contro l’apparato fluido del lavoro «immateriale» contemporaneo è una concezione di quel tipo di fabbrica troppo semplicistica e per certi versi fuorviante. Come la storia delle grandi fabbriche del Novecento ci dimostra la fabbrica fordista poteva resistere alla continua insubordinazione operaia soltanto innovandosi continuamente, trasformando il proprio assetto tecnico e sociale in modo compulsivo. Non è un caso che la fabbrica fordista assume quale suo principio spaziale la «pianta tipica», ovvero lo spazio vuoto in cui le strutture di sostegno sono ridotte al minimo. È interessante notare come lo stesso dispositivo venga oggi utilizzato negli uffici, nei musei (che spesso occupano fabbriche «dismesse»), ma anche nell’università e perfino nelle abitazioni.
Come ha osservato Francesco Marullo, questa concezione dello spazio architettonico come spazio flessibile altro non è che l’approssimazione spaziale della vera natura del lavoro vivo, vale a dire lavoro in potenza e dunque non riducibile a forme spaziali definitive16. Inoltre, come aveva già messo in evidenza Alquati, negli anni Sessanta, anche nella fabbrica fordista il capitale si appropriava del sapere e non soltanto dei muscoli dell’operaio17. Di contro, nell’ambito del così detto lavoro immateriale dell’operaio cognitivo vi è una crescente e neanche più nascosta (o nascondibile) pesante fabbrichizzazione del lavoro come è ormai palese, ad esempio, nei grandi «open floors» degli uffici di compagnie come negli uffici Facebook a Menlo Park dove più di mille persone lavorano dentro quella che è ormai conosciuta come «la più grande stanza del mondo». Qui non solo riappare letteralmente l’architettura della grande fabbrica con i suoi spazi astratti ma il lavoro stesso è compulsivamente misurato e controllato nella sua totalità. Non è un caso che molte di queste compagnie estendono il proprio controllo fuori dalla fabbrica iniziando progetti di housing annessi agli uffici e organizzando un capillare sistema di trasporto per i dipendenti, come sta accadendo a San Francisco, la Detroit 4.0. Per non parlare della così detta architecture of fulfilment la controparte logistica del commercio online (Amazon ecc.), fatta di luoghi in cui lo sfruttamento della forza lavoro raggiuge livelli impensabili in passato18.
In fondo l’esplosione delle app come Uber non sono altro che la logica continuazione dell’estensione della fabbrica sulla società: uberizzazione dello spazio non è altro che il prosieguo accelerato dell’urbanizzazione. Andrebbero presi più sul serio i tentativi di sublimare questa realtà attraverso il feticcio della factory come accade in molti luoghi del lavoro creativo e non. Proprio in Operai e capitale Tronti metteva in guardia verso la tendenza del pensiero marxista a definire tutto quello che avviene nel campo avverso come apparenza ideologica. In realtà è proprio l’utilizzo compulsivo da parte di molte compagnie del lavoro 2.0 del termine factory (come «fun factory», «creative factory», «knowledge factory», «food factory», «art factory») a tradire l’ethos stakanovista che si fa sempre più fatica a nascondere: work hard, have fun, make history recita una scritta che campeggia all’ingresso dei centri Amazon.
È un errore però credere che siccome lo sfruttamento del lavoro produttivo è ovunque, la fabbrica scompare. La fabbrica, come al principio della sua storia, si articola mediante luoghi strategici che animano la macchina territoriale urbana e rispetto a essa funzionano come dei colli di bottiglia. Il collo di bottiglia non ostruisce ma regola il flusso, ne indirizza la forza e ne regola la potenza. Allo stesso tempo il collo di bottiglia proprio perché crea attrito è sempre in procinto di essere ostruito e di bloccare il flusso. È interessante notare come molte delle occupazioni di spazi recenti come ad esempio le proteste di Piazza Tahrir in Egitto o quelle della Pearl Roundabout in Bahrain, sono avvenute non in piazze tradizionali come potrebbe essere piazza Navona a Roma, ma in roundabouts, rotatorie del traffico, un tipo di piazza nata con la città industriale che serviva a regolare in modo efficace il traffico19. L’occupazione di questi spazi sembra reclamare dunque stanzialità politica proprio dove il capitale ha trasformato la città in un sistema di flussi. La fabbrica deve essere dunque pensata come un sistema macchinico che mette insieme molte cose apparentemente disomogenee come i trasporti, la logistica, i sistemi algoritmici della finanza ma anche risorse naturali e territori agricoli.
Nella fabbrica contemporanea ci sono meno di sei gradi di separazione tra gli algoritmi della finanza, la start-up di San Francisco, il land-grabbing in Asia e Africa. Certo, dentro la fabbrica c’è anche il debito, il consumo, la rendita, le nuove forme di ascesi che il capitale utilizza per disciplinare i propri subalterni. Ma tutte queste cose devono essere lette come un ulteriore sviluppo di quel sistema coercitivo, di quella forma di accumulazione primitiva permanente ed estesa sul territorio con il quale il capitale comanda e sfrutta il lavoro vivo. Separare le forme di sfruttamento e coercizione come se fossero capitoli a sé stanti e vederli come salti di paradigma in cui il «nuovo» mette fuori il «vecchio» è a mio avviso un errore non solo tattico, ma soprattutto strategico.
Il ritorno della fabbrica è dunque una provocazione per riscoprire e ricostruire la geografia della fabbrica contemporanea e il suo rapporto simbiotico con la società. Di questa fabbrica occorre ricostruirne la genealogia come si è tentato di fare in modo succinto in queste brevi riflessioni, ma occorre anche saperla individuare nel territorio urbano contemporaneo. Forse dobbiamo uscire dalla retorica dei flussi delle molteplicità disincarnate con cui sono state lette le lotte contemporanee.
Le recenti lotte dei lavoratori nei centri logistici della TNT, di Amazon, dell’IKEA, ma anche le lotte dei No-Tav in Val di Susa contro la linea dei treni ad alta velocità, dei NoDAPL a Standing Rock nel North Dakota contro il passaggio dell’oleodotto, dei ciclo-trasportatori a Milano contro lo sfruttamento del lavoro al tempo delle app, ci hanno mostrato una nuova possibile geografia concreta della fabbrica contemporanea, dei suoi luoghi fisici e dei suoi confitti.
Questo articolo è stato pubblicato su OperaViva Magazine il 31 dicembre 2016
Su questi temi si vedano gli importanti contributi sul concetto di Città Fabbrica di Alberto Magnaghi tra cui ricordiamo «Dalla città fabbrica alla metropoli informatica», in S. Bonfiglioli, M. Galbiati, Dopo Metropolis, Franco Angeli, 1984. ↩
Ludwig Hilberseimer, Groszstadt Architektur, Julius Hoffmann Verlag, Stoccarda, 1927, trad. it. Groszstadt Architektur. L’Architettura della Grande Città, Clean Edizioni, Napoli, 1998, p. 7. ↩
Ildefonso Cerdà, Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona, Imprenta Española, Madrid 1867, trad. it. Teoria Generale dell’Urbanizazzazione, a cura di Antionio Lopez de Aberasturi, Jaca Book, Milano 1995, pp. 84-87. ↩
Andrea Cavalletti, La città biopolitica, Mondadori, 2005 ↩
Le Corbusier, Vers une Architecture, Georges Crés, Parigi, 1923, trad. it. Verso una Architettura, a cura di P. L. Cerri, P. L. Nicolin, Longanesi, Milano, 1973, p. 123. ↩
Carl Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Durcker & Huboldt, 1997 (1950), trad. it. Il Nomos della Terra nel diritto internazionale dello Jus Publicum Europaeum, a cura di Franco Volpi, Adelphi, 1991, pp. 269-287. ↩
Vedi: James D. Tracy, The Political Economy of Merchant Empires, Cambridge University Press, London, 1997. ↩
G. W. F. Hegel, Lineamenti per la filosofia del diritto, Laterza, 1969, p. 247. ↩
Mario Tronti, «La Fabbrica e la Società» in Operai e Capitale, DeriveApprodi, 2006 (1966), pp.35-56. ↩
Ibid. 35. ↩
Manfredo Tafuri, Per una critica dell’ideologia architettonica, «Contropiano», 1, 1969, pp. 31-79. ↩
Mario Tronti, Operai e Capitale, cit. 49. ↩
Vedi il necessario complemento a Operai e Capitale di Tronti, ovvero: Leopoldina Fortunati, L’arcano della rirpoduzione: Casalinghe prostitute, operai e capitale, Marsilio, Padova, 1981. ↩
Marvin Trachtenberg, The Dominion of the Eye, Urbanism, Art and Power in Early Modern Florence, Cambridge University Press, Londra, 2008. ↩
Ernesto Screpanti, L’angelo della liberazione nel tumulto dei Ciompi. Firenze Giugno-Agosto 1378, Protagon Editori Toscani, Firenze, 2008. ↩
Vedi: Francesco Marullo, Architecture and Revolution. The Typical plan as Index of Generic in Pier Vittorio Aureli (a cura di), The City as a Project, Ruby Press, Berlino 2014, 216-260. ↩
Vedi: Romano Alqauti, Lavoro e attività. Per una analisi della schiavitù neomoderna, Manifestolibri, Roma, 1998. ↩
Vedi la ricerca sviluppata su questo tema dal collettivo Behemoth ↩
Su questo tema vedi: Eyal Weizman, The Roundabout Revolutions, Sternberg Press, Berlino, 2015. ↩