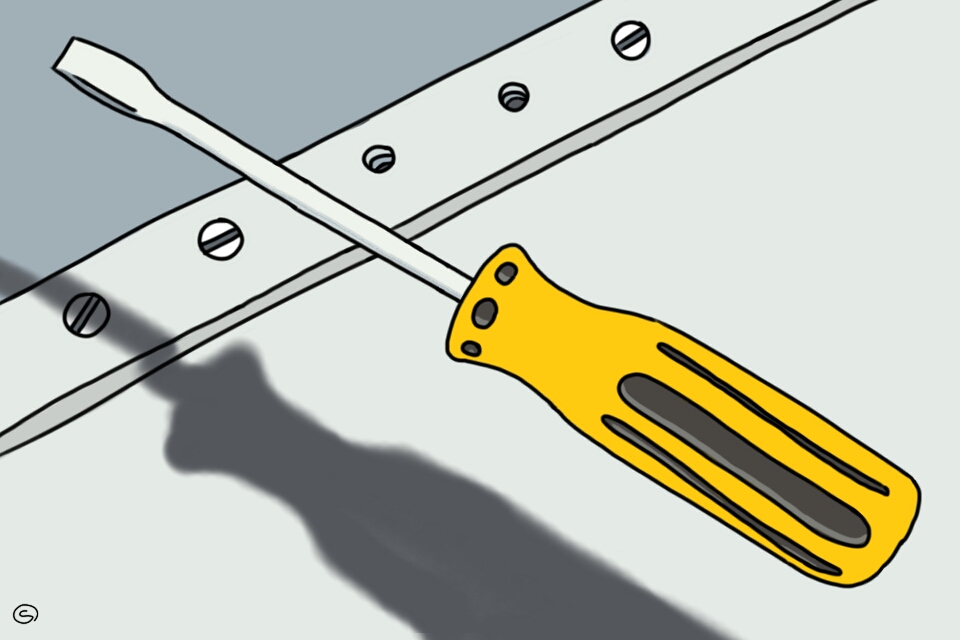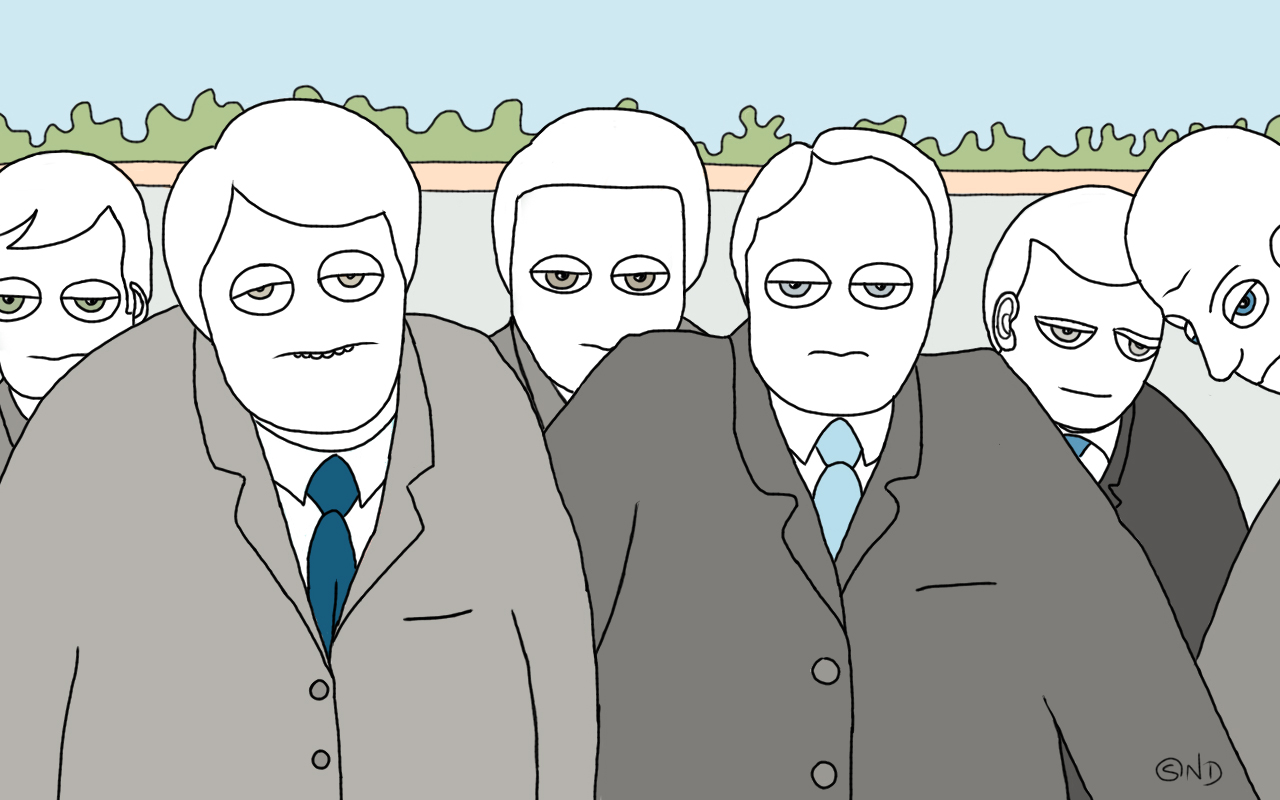di SANDRO MEZZADRA.
Intervento a C17 – La conferenza di Roma sul Comunismo, 21 gennaio 2017
1. Qual è oggi il potere della parola comunismo? È una domanda che dobbiamo porci alla luce dello straordinario successo di C17, dopo che per giorni, centinaia e centinaia di persone hanno seguito con un’attenzione e una partecipazione stupefacenti una serie di dibattiti in cui il comunismo è stato nuovamente messo in gioco dal punto di vista della storia e della critica dell’economia politica, delle pratiche estetiche e della politica tout court. Si tratta forse di tornare a usare il termine comunismo nei volantini, nei manifesti e nei blog? Non mi pare che sia questo il punto. Quanti tra noi hanno continuato in questi anni a definirsi comunisti lo hanno fatto con la necessaria “sobrietà”, consapevoli del fatto che su quella parola grava il peso di una storia tanto entusiasmante quanto terribile – e che solo nuovi movimenti di massa possono rinnovarne radicalmente il significato, incardinandola nella lotta politica e sociale del XXI secolo. Anche a Roma abbiamo ascoltato appelli alla costruzione di un nuovo “partito comunista” (Jodi Dean), senza che di questi problemi, nonché della nuova composizione del lavoro vivo e delle nuove modalità operative del capitale, si tenesse conto. È facile rispondere che ad esempio in un Paese come l’Italia non si contano i “partiti comunisti”, in litigiosa contesa per il monopolio della corretta linea politica senza che la loro azione faccia in alcun modo avanzare un movimento reale di riappropriazione della materialità del comunismo.
È dunque in un senso meno immediato che dobbiamo interpretare il successo di C17. Il comunismo, a differenza di quel che è accaduto in altre occasioni (ad esempio al convegno di Londra del marzo 2009), non è stato qui in ogni caso assunto prioritariamente come un’“idea”. Tanto gli interventi quanto la partecipazione hanno determinato una sostanziale ri-politicizzazione della questione comunista. E a me pare che in buona sostanza tornare a interrogare politicamente il comunismo oggi, anche da parte di una nuova generazione di attivisti e attiviste, corrisponda alla percezione di alcuni limiti di fondo dei movimenti degli ultimi anni. A esprimersi è una tensione ad andare oltre quello che Enzo Traverso ha chiamato il “presentismo” dei movimenti – nel senso di guadagnare tempo e “orizzonte” alla loro capacità di trasformazione, distendendola progettualmente al di là dell’“evento” del loro insorgere, senza che questo significhi in alcun modo svalutare il radicamento nel presente dei movimenti.
Questa tensione va collocata all’interno della specifica congiuntura politica che stiamo attraversando. L’insediamento di Trump alla Casa Bianca corona infatti un ciclo politico di gestione della crisi a livello globale caratterizzato dall’egemonia di una destra che – in India come in Turchia, in Egitto come in Ungheria – assume non di rado caratteri specificamente fascisti. Si tratta certo, lo ha ricordato Paolo Virno, di un fascismo diverso da quello storico, contro cui occorre inventare forme di lotta innovative: ma il rifiuto verso i migranti, l’odio verso chi viene costruito come inassimilabile, la retorica nazionalista, l’attacco ai diritti (in primo luogo delle donne) sono tratti che è difficile definire altrimenti che come fascisti. Contro questi sviluppi, a smentire ogni loro interpretazione in termini “apocalittici”, sono in campo formidabili movimenti – a partire, ancora una volta, da quello delle donne. Resta comunque il fatto che questo ciclo politico, al cui interno rientrano anche gli sviluppi in Paesi latinoamericani come il Brasile e l’Argentina, esprime a livello globale la modalità specifica di gestione di quella crisi capitalistica che dal 2008 non ha cessato di circolare e di produrre i suoi effetti.
A me non pare che la tendenza disegnata da questo ciclo sia quella verso la “de-globalizzazione”, il protezionismo e il semplice “ritorno” in campo degli Stati nazionali come assoluti protagonisti della politica e dell’economia: i nazionalismi che contano, oggi, sono quelli che si organizzano attorno a spazi continentali (o quelli che a essi puntano ad agganciarsi); e in questi spazi possono senz’altro riorganizzarsi le operazioni globali del capitale contemporaneo e le dinamiche dell’interdipendenza. La nazione è oggi la figura attorno a cui si esprimono specifici progetti capitalistici di stabilizzazione e di gestione di una crisi che ha liquidato i caratteri espansivi e promissori del “neo-liberalismo” riproducendone in forme esasperate la razionalità di governo e disciplinamento. Tornare a interrogare politicamente il comunismo in queste condizioni significa in primo luogo indicare un terreno di lotta e azione politica radicalmente diverso – per il modo in cui costruisce i suoi soggetti, prima di tutto – da quello della nazione, di cruciale importanza anche per qualificare un’iniziativa politica che si propone di incidere all’interno degli spazi nazionali. E in secondo luogo significa indicare una prospettiva per la lotta contro la destra: questa lotta non può essere efficace se rimane meramente difensiva, se non si collega – in forme da inventare e sperimentare – alla ricostruzione di un orizzonte di trasformazione radicale dell’esistente. Mi pare un punto fondamentale, anche per la differenza che segna rispetto alle modalità con cui sono stati fronteggiati i fascismi storici.
2. Il comunismo, nella discussione romana, è stato il nome di questa necessaria ricostruzione di un orizzonte di trasformazione radicale dell’esistente. E si può dire che la straordinaria complessità dell’esperienza storica comunista, nel suo dipanarsi tra rivoluzioni e regimi, tra partiti e movimenti, tra resistenza e repressione, tra lotte di liberazione e geopolitica della guerra fredda, sia stata consapevolmente e seccamente ridotta a una dimensione essenziale. L’eredità comunista è apparsa in molti interventi coincidere con una politica intesa come capacità collettiva di trasformazione degli sfruttati, resa stabile ed efficace da forme specifiche di organizzazione. C’è qui una prima traccia di lavoro sul tema dei “poteri comunisti”: quel che oggi occorre recuperare e ripensare è proprio quella capacità politica, quella pratica che – anche quando è stata assoggettata alle forme più violentemente gerarchiche dell’organizzazione di avanguardia – ha mantenuto tratti di autonomia. La storia dei comunismi deve essere ricostruita oggi anche da questo punto di vista, individuando e valorizzando questi momenti di autonomia della politica di massa degli sfruttati e dei dominati, spesso in violenta contraddizione con le ragioni del partito, del regime e dello stesso “internazionalismo”, quando quest’ultimo è stato interpretato come mera copertura di specifici interessi geopolitici. Ma la capacità collettiva (il potere collettivo) di trasformazione, nella sua autonomia, è soprattutto il contrassegno di una politica comunista nel presente. Ed è il criterio fondamentale su cui deve essere commisurato il dibattito sulle forme di organizzazione e sulla questione del potere.
D’altro canto, l’enfasi sulla capacità collettiva di trasformazione non è certo caratteristica esclusiva della politica comunista. Ne esistono, tanto sul piano teorico quanto su quello dell’esperienza storica, infinite varianti democratiche, socialiste, anarchiche. Che cosa rende dunque peculiare l’esperienza comunista? Dal punto di vista storico la risposta è semplice: il fatto di essere collegata a una rivoluzione vincente, alla costruzione di quella che è potuta apparire un’alternativa radicale – e inimmaginabile fino a quel momento – all’organizzazione capitalistica del lavoro e della vita. Mentre ricorre il centenario della rivoluzione sovietica, questo aspetto – con tutto quel che contiene di appena abbozzato, di incompiuto, di bloccato e di pervertito – dovrebbe tornare al centro dell’attenzione. E dovrebbe essere rivendicato per il presente e per il prossimo futuro. Tra i grandi protagonisti dell’Ottobre, forse nessuno seppe coglierlo ed esprimerlo con la drammaticità e l’intensità di Victor Serge, un perseguitato dallo stalinismo, un anarchico che si era unito a Lenin senza in fondo cessare di essere anarchico. Nelle sue memorie, contemplando alla fine degli anni Trenta lo spettacolo di una moltitudine di uomini e donne in fuga dal nazismo e dallo stalinismo (di una moltitudine di sconfitti), su un battello in pieno Oceano Atlantico, Serge fissa lo sguardo sui compagni con cui ha condiviso l’esperienza della lotta e della persecuzione. E un po’ sorprendentemente scrive: “abbiamo saputo vincere, non bisogna dimenticarlo”. “I russi e gli spagnoli tra noi sanno che cosa vuol dire prendere il mondo in mano, far funzionare le ferrovie e le fabbriche, difendere le città bombardate, stabilire i piani di produzione, trattare secondo i loro meriti i potenti miserabili della vigilia”.
Credo che questa capacità di vincere, di “prendere il mondo in mano” rientri negli aspetti dell’eredità comunista che dobbiamo oggi rivendicare, certo tenendo conto di che cosa è diventato il mondo e di come può essere costruito il soggetto della sua trasformazione. Ma la capacità collettiva di trasformazione che definisce la politica comunista trova in questo obiettivo, in questa ambizione, la misura della propria efficacia e il criterio regolatore della qualità del potere che punta non solo a conquistare, ma prima di tutto a costruire.
 3. Di una politica comunista per il nostro presente ho indicato fin qui alcuni elementi caratterizzanti, di tipo per così dire “formale”. È una politica in cui l’organizzazione ha come obiettivo di fondo il potenziamento dell’autonoma capacità collettiva di trasformazione degli sfruttati. Questo significa che è una politica ostile alla delega e alla rappresentanza, ovvero che – anche quando in circostanze determinate ricorre a questi dispositivi – tiene sempre aperto lo spazio per la loro critica. Inoltre, è una politica che punta alla conquista e alla costruzione di un potere che garantisca l’efficacia della trasformazione sul piano dell’organizzazione del lavoro, della cooperazione e della vita – una politica interamente immersa in queste dimensioni. È possibile ora aggiungere qualche determinazione materiale a questa prima definizione, in particolare per avanzare nella discussione della questione del potere. La politica comunista, si può affermare in termini molto generali, è una politica che assegna un ruolo costitutivo alla lotta di classe e che punta all’abolizione della proprietà privata attraverso la costruzione di un potere altro rispetto a quello dello Stato borghese, che alla proprietà privata è legato a doppio filo.
3. Di una politica comunista per il nostro presente ho indicato fin qui alcuni elementi caratterizzanti, di tipo per così dire “formale”. È una politica in cui l’organizzazione ha come obiettivo di fondo il potenziamento dell’autonoma capacità collettiva di trasformazione degli sfruttati. Questo significa che è una politica ostile alla delega e alla rappresentanza, ovvero che – anche quando in circostanze determinate ricorre a questi dispositivi – tiene sempre aperto lo spazio per la loro critica. Inoltre, è una politica che punta alla conquista e alla costruzione di un potere che garantisca l’efficacia della trasformazione sul piano dell’organizzazione del lavoro, della cooperazione e della vita – una politica interamente immersa in queste dimensioni. È possibile ora aggiungere qualche determinazione materiale a questa prima definizione, in particolare per avanzare nella discussione della questione del potere. La politica comunista, si può affermare in termini molto generali, è una politica che assegna un ruolo costitutivo alla lotta di classe e che punta all’abolizione della proprietà privata attraverso la costruzione di un potere altro rispetto a quello dello Stato borghese, che alla proprietà privata è legato a doppio filo.
Vorrei proporre, nella parte rimanente di questo intervento, un primo svolgimento di ciascuno degli elementi di questa definizione generale. Parlare del ruolo costitutivo della lotta di classe significa rinviare alla posizione essenziale della critica dell’economia politica per la fondazione di una politica comunista. Nel suo intervento a C17, Brett Neilson ha presentato a questo proposito alcuni dei temi di fondo di un nuovo libro che insieme abbiamo appena terminato, intitolato The Politics of Operations. Excavating Contemporary Capitalism. Brett ha insistito in particolare sull’esigenza di tenere aperta l’indagine sulle condizioni che consentono al capitale di porsi come “attore politico”, indicando al tempo stesso una prospettiva teorica che insiste sulla dimensione operativa del capitale per fare emergere le logiche essenziali di un capitalismo che è definitivamente uscito dall’epoca industriale. Una politica comunista non può che tenere fino in fondo conto del modo in cui il capitale contemporaneo opera, dei cambiamenti radicali che da questo punto di vista si sono determinati rispetto a precedenti epoche nella storia del capitalismo. Al tempo stesso, la critica dell’economia politica, per come la intendiamo, approfondisce l’analisi di quella che abbiamo chiamato “moltiplicazione del lavoro”, mostrando come oggi il terreno della produzione di soggettività sia investito direttamente dallo sfruttamento capitalistico, che punta a sollecitare tutte le potenze vitali del “lavoro”.
È la cooperazione sociale a essere ormai al centro dei processi di sfruttamento. Ma questa cooperazione è ben lungi dal presentarsi come un soggetto “omogeneo”: un insieme di gerarchie e differenze divide piuttosto il “lavoro vivo” dalle potenze comuni che si esprimono nella cooperazione. Se assumiamo come riferimento concetti come quello di genere e quello di razza, possiamo ad esempio ricostruire alcuni aspetti di questa produzione di gerarchie e di differenze. Ma possiamo anche vedere come essi abbiano funzionato e continuino a funzionare come piani di soggettivazione, come terreni di affermazione di un diverso significato della “differenza”, che una politica comunista non può che assumere come propria essenziale determinazione. In particolare, non esiste una “contraddizione principale” rispetto a cui questi terreni possano essere definiti come “secondari”. Attorno al genere e alla razza si definiscono piuttosto i criteri fondamentali attraverso cui i soggetti entrano in rapporto, in modi differenziali, con la propria “forza lavoro”, una questione – e un terreno di lotta – fondamentale per la più generale definizione della composizione di classe contemporanea.
La “classe”, con la sua caratterizzazione di parte, continua oggi a differenziare la politica comunista non solo da qualsiasi forma di “populismo”, ma dalla stessa democrazia (senza che questo significhi in alcun modo liquidare il problema della formazione di una volontà comune e dell’assunzione di decisioni coerenti con questa volontà: si tratta, al contrario, di rendere produttiva la tensione tra politica comunista e politica democratica). Ma la classe si presenta oggi come radicalmente diversa rispetto a quella che ha sostenuto lo sviluppo del comunismo nel Novecento. E’ un campo di differenze, su cui agisce lo sfruttamento capitalistico e in cui una politica comunista deve contribuire a impiantare dispositivi di lotta, organizzazione, coalizione e “traduzione”. La mobilità e la “femminilizzazione”, in particolare, sono elementi decisivi della composizione di classe contemporanea, a diverse latitudini: una politica comunista non potrà dunque che essere una politica femminista e migrante.
Che cosa significa, in queste condizioni, rilanciare l’obiettivo dell’abolizione della proprietà privata? A me pare che continui a essere questo l’elemento qualificante di una politica comunista. Certo, non si tratta di immaginare la rivoluzione come l’evento che rende possibile l’abolizione “per decreto” della proprietà privata. E per “abolizione” converrà intendere un radicale spiazzamento della proprietà privata, una contestazione puntuale della sua posizione di centro indiscusso attorno a cui si organizzano i rapporti sociali all’interno del capitalismo. Lungi dall’essere un mero dispositivo giuridico, la proprietà privata si caratterizza infatti, oggi più che mai, come cristallizzazione del comando, del potere di disposizione sulla vita altrui. La lotta contro la proprietà privata è dunque al tempo stesso lotta contro la coazione al lavoro che segna materialmente l’esistenza dei soggetti espropriati della capacità di disporre del proprio futuro per via della posizione subordinata che occupano all’interno dei rapporti proprietari.
Ho parlato in precedenza del genere e della razza. Proprio riflettendo attorno a questi concetti, alla loro rilevanza tanto dal punto di vista della definizione dei criteri del dominio quanto dal punto di vista delle pratiche di soggettivazione, emerge pienamente quella che si può definire la dimensione “antropologica” della proprietà privata (lo ha sottolineato nel suo intervento anche Michael Hardt). Il movimento globale delle donne, dalla Polonia agli Stati Uniti, dall’Argentina all’Italia, si presenta anche come espressione di un potente anelito di liberazione dalla determinazione proprietaria dei rapporti tra i generi, che ha continuato a riprodursi nonostante le sfide del femminismo. Black Lives Matter, d’altro canto, lotta contro la violenza della polizia, individuando nella “distruzione dei corpi neri” che si ripete quotidianamente negli Stati Uniti gli effetti di un razzismo definito da un duplice rapporto proprietario – secondo cui la “bianchezza” in quanto proprietà privata costruisce i corpi non bianchi come potenzialmente appropriabili. Tornare a porre l’abolizione della proprietà privata come obiettivo strategico di una politica comunista non ha senso oggi se non assumendo fino in fondo questa dimensione “antropologica” della proprietà – e dunque senza dare un rilievo costitutivo all’insieme delle pratiche che la contestano (che sono pratiche interne alla costituzione della classe). Quel che ne risulta è un essenziale arricchimento della stessa nozione di liberazione che costituisce il cuore di una politica comunista.
Dello stesso istituto giuridico della proprietà privata, del resto, sono state ampiamente discusse negli ultimi anni le radicali trasformazioni. Vorrei soffermarmi brevemente, qui, su quelle che ha descritto nel suo intervento Kaushik Sunder Rajan, parlando del modo in cui le operazioni del “biocapitale” rideterminano il significato di un concetto come quello di “salute”. Il dispositivo della proprietà privata si fa qui interno al soggetto, lacera tessuti e ricombina materiale genetico, configura la salute stessa (il “benessere”) come appropriabile da parte di poteri privati. Si vede bene qui, mi pare, come la lotta contro la proprietà privata si disponga immediatamente, ancora una volta, sul terreno della produzione di soggettività. Non diversamente stanno le cose quando si prenda in esame la questione dal punto di vista dei big data e delle tecniche di data mining sulla cui base opera in particolare il cosiddetto “capitalismo di piattaforma”. Nel momento in cui si produce un evidente salto di qualità sul piano dell’integrazione tra soggetto umano e macchine, è ancora una volta la proprietà privata a comandare questo passaggio – presentandosi come proprietà di quei dati che compongono i molteplici profili al cui interno trovano definizione tanto la singolarità quanto la molteplicità dei suoi rapporti con il mondo. La riappropriazione di questi dati si presenta qui come riappropriazione delle condizioni che rendono possibile non solo l’interazione con il “macchinico” ma, attraverso questa interazione, il dispiegarsi di reti allargate di cooperazione sociale.
Ancor più in generale, la proprietà privata è oggi un formidabile dispositivo estrattivo. Questo vale in particolare per le operazioni della finanza. È un punto su cui io e Brett insistiamo particolarmente in The Politics of Operations, ma anche Saskia Sassen ha presentato una tesi analoga nel suo intervento (e altri, ad esempio Michael Hardt e Toni Negri, si stanno muovendo su questo terreno). Riassumo, semplificando drasticamente: la finanza costituisce oggi una gigantesca accumulazione di titoli di proprietà su una ricchezza da produrre in futuro, da cui “estrae” appunto valore. La questione del “debito” è qui indubbiamente centrale, ma penso che si debba evitare di generalizzarla e soprattutto di presentarla come condizione “omogenea”: i soggetti che contraggono un debito con il capitale finanziario si fanno carico, come anticipavo, di una essenziale coazione al lavoro, sancita dai rapporti proprietari che organizzano il mondo della finanza. Per ripagare il debito, si impegnano a lavorare (e dunque a entrare in specifici rapporti di sfruttamento) in futuro, ma questa coazione al lavoro agisce in modi differenziali sui soggetti indebitati, a seconda della loro posizione nei rapporti proprietari e delle risorse di cui dispongono. Non diversamente stanno le cose, mi pare, quando a indebitarsi sono gli Stati, che distribuiscono poi in modo differenziale gli oneri connessi a questo debito. Quel che rimane valido è il fatto che la finanza, attraverso la mediazione dei rapporti proprietari che la organizzano, funziona secondo modalità estrattive e pone potenti ipoteche sul futuro. Siamo qui di fronte a un formidabile elemento di blocco rispetto alla possibilità di una politica comunista, mentre più in generale le operazioni del capitale finanziario – nella nuova qualità che le contraddistingue oggi – condizionano e limitano le stesse possibilità di intervento regolatore degli Stati. Come è possibile rimuovere questo elemento di blocco, facendo agire la critica della proprietà privata sul livello più alto su cui quest’ultima manifesta la propria efficacia?
 4. Un problema che qui si pone immediatamente, e su cui si continuano a registrare profonde differenze nel dibattito, è la possibilità di utilizzare lo Stato come leva per la trasformazione sociale e come strumento di contrasto della violenza del capitale finanziario. Mentre spesso chi assume questa possibilità presenta le proprie posizioni come caratterizzate da realismo politico credo che sia necessaria in primo luogo proprio un’analisi realistica delle trasformazioni che negli ultimi anni hanno investito e radicalmente riconfigurato lo Stato. È uno degli obiettivi più importanti che io e Brett ci poniamo in The Politics of Operations: e quel che cerchiamo di dimostrare è che la logica estrattiva delle più rilevanti operazioni del capitale contemporaneo è penetrata in profondità all’interno delle strutture istituzionali dello Stato, ne ha tendenzialmente posto in discussione l’unità (sincronizzando secondo la propria razionalità le funzioni esecutive, di sicurezza e finanziarie e separandole dalle funzioni in senso lato “sociali”) e ha in particolare esercitato una formidabile pressione sul ruolo di mediazione sociale che lo Stato ha esercitato in una fase storica determinata sotto la pressione delle lotte operaie. Lo Stato contemporaneo continua a essere un attore chiave (ancorché non esclusivo) nell’articolazione delle operazioni del capitale, nella produzione degli spazi al cui interno si dispiegano i processi valorizzazione e di accumulazione del capitale, ma tende a ritrarsi laddove viene investito da rivendicazioni connesse al piano della riproduzione della forza lavoro, sempre più decisamente affidata a logiche di mercato che configurano come residuale l’intervento pubblico.
4. Un problema che qui si pone immediatamente, e su cui si continuano a registrare profonde differenze nel dibattito, è la possibilità di utilizzare lo Stato come leva per la trasformazione sociale e come strumento di contrasto della violenza del capitale finanziario. Mentre spesso chi assume questa possibilità presenta le proprie posizioni come caratterizzate da realismo politico credo che sia necessaria in primo luogo proprio un’analisi realistica delle trasformazioni che negli ultimi anni hanno investito e radicalmente riconfigurato lo Stato. È uno degli obiettivi più importanti che io e Brett ci poniamo in The Politics of Operations: e quel che cerchiamo di dimostrare è che la logica estrattiva delle più rilevanti operazioni del capitale contemporaneo è penetrata in profondità all’interno delle strutture istituzionali dello Stato, ne ha tendenzialmente posto in discussione l’unità (sincronizzando secondo la propria razionalità le funzioni esecutive, di sicurezza e finanziarie e separandole dalle funzioni in senso lato “sociali”) e ha in particolare esercitato una formidabile pressione sul ruolo di mediazione sociale che lo Stato ha esercitato in una fase storica determinata sotto la pressione delle lotte operaie. Lo Stato contemporaneo continua a essere un attore chiave (ancorché non esclusivo) nell’articolazione delle operazioni del capitale, nella produzione degli spazi al cui interno si dispiegano i processi valorizzazione e di accumulazione del capitale, ma tende a ritrarsi laddove viene investito da rivendicazioni connesse al piano della riproduzione della forza lavoro, sempre più decisamente affidata a logiche di mercato che configurano come residuale l’intervento pubblico.
Questi processi, qui evocati molto schematicamente, sono ben lungi dal risultare “accidentali” rispetto a una “sostanza” della statualità che non ne risulterebbe scalfita e attenderebbe soltanto di essere riattivata da politiche di “sinistra” o al limite “comuniste”. La stessa lettura del neoliberalismo come dispositivo di “corruzione” dell’autonomia del politico attraverso una contaminazione con la logica dell’“economico”, per quanto diffusa (si pensi, per fare un solo esempio, ai lavori di Wendy Brown), non coglie a mio giudizio la profondità di una trasformazione che ha complessivamente ridefinito tanto il significato dell’“economico” quanto quello del “politico”. Questa trasformazione ha alterato (e certo anche “corrotto”!) la stessa figura dello Stato, inscrivendovi una serie di elementi di blocco con cui è costretta a misurarsi qualsiasi politica della trasformazione che passi attraverso l’uso dello Stato (sia che si presenti come “riformista” sia che si presenti come “rivoluzionaria”). La politica comunista di cui sto presentando alcune linee di fondo, nella sua lotta contro la proprietà privata, si tiene tuttavia a distanza di sicurezza da quella che Michel Foucault ha chiamato “statofobia”. Si ispira piuttosto, secondo una formula di Rosa Luxemburg ripresa nel suo intervento a C17 da Mario Candeias, a un essenziale “realismo politico rivoluzionario”. In circostanze determinate, è possibile e necessario puntare all’occupazione delle strutture statali (dotandosi degli strumenti necessari a questo fine). Ma per rimuovere gli elementi di blocco che immediatamente si incontrano all’interno di queste strutture, per trasformarle e renderle disponibili per nuovi ruoli e funzioni, è necessario fare leva su un altro potere, radicato al loro esterno. È solo questo doppio movimento a garantire l’efficacia di un’azione antagonistica rispetto alle modalità operative del capitale contemporaneo.
A me pare in particolare che sia questa la lezione da trarre dalle più significative esperienze di occupazione e uso dello Stato per costruire una politica “progressista” in questo inizio di XXI secolo – ovvero dalle esperienze latinoamericane. Mentre è diffusa un’interpretazione di queste esperienze che esalta l’efficacia del “populismo di sinistra”, credo che sia più che mai necessaria una lettura che assuma come angolo prospettico la loro attuale crisi, evidente negli sviluppi brasiliani e argentini non meno che in quelli venezuelani e ecuadoriani. I governi “progressisti” latinoamericani dimostrano certamente, sia pure in condizioni che occorrerebbe valutare in modo molto più circostanziato, l’efficacia di politiche che hanno utilizzato le istituzioni statuali per avviare processi di trasformazione sociale. Ma mostrano anche i limiti che queste politiche hanno incontrato non appena si sono chiuse all’interno di queste stesse strutture, dal momento che la loro efficacia e la loro forza dipendevano in misura decisiva da una duplice apertura al di là dello Stato nazionale: da una parte da un processo di integrazione su scala regionale che in qualche modo era stato prefigurato dal ciclo di lotte e insorgenze dei primi anni Duemila; dall’altra dalla persistenza e dall’autonomia di dinamiche di mobilitazione e auto-organizzazione sociale assunte come riferimento essenziale dalle stesse politiche pubbliche. Il ripiegamento sulla dimensione nazionale e la centratura del processo di trasformazione attorno alla figura dello Stato sono due momenti essenziali dell’attuale crisi dei governi “progressisti” latinoamericani: il “populismo di sinistra”, da questo punto di vista, è assai più parte del problema che della soluzione.
Le esperienze latinoamericane sono straordinariamente importanti per ripensare il rapporto che una politica comunista deve oggi intrattenere con lo Stato e più in generale con il potere. Se da una parte un’analisi realistica dello Stato oggi conduce a diffidare della possibilità di un eccessivo investimento di aspettative nelle sue strutture per fronteggiare le operazioni del capitale e guidare processi di trasformazione sociale, dall’altra è necessario un bilancio delle esperienze storiche comuniste (ma anche dei regimi anti-coloniali e della stessa politica socialdemocratica nel Novecento): queste esperienze hanno avuto proprio nella centratura della politica attorno allo Stato i propri essenziali momenti di crisi, involuzione e degenerazione. Dall’insieme di queste considerazioni deriva necessariamente la conclusione che oggi una politica comunista non può che essere una politica non centrata attorno allo Stato – ovvero una politica che sappia, in specifiche condizioni, occupare lo Stato o alcune sue strutture mantenendo tuttavia aperto lo spazio per l’autonomia di una capacità collettiva di trasformazione capace di dotarsi di proprie strutture organizzative e di vere e proprie istituzioni. Analogamente a Bruno Bosteels (ma anche a Fred Jameson) sono convinto che da questo punto di vista sia opportuno e necessario rivisitare la teoria del dualismo del potere come chiave essenziale di una politica comunista.

È evidente che nel marxismo, e in modo particolare in Lenin, il dualismo del potere si presenta come condizione transitoria, da spezzare per avviare la transizione. Io credo che oggi si tratti di ripensare la stessa categoria di transizione a partire dall’ipotesi di una stabilizzazione del dualismo del potere, che non può che voler dire stabilizzazione delle condizioni che rendono possibile il movimento costituente che costituisce la ragion d’essere di quel dualismo. Mi sembra necessario, in questo senso, avviare una ricerca sulle forme storiche in cui il dualismo del potere si è prodotto nelle rivoluzioni moderne, in vista di una definizione tanto del concetto del “secondo potere”, prodotto autonomamente all’interno delle lotte e delle dinamiche di insorgenza, quanto del tipo di rapporto che tra i due poteri può instaurarsi. Il soviet costituisce indubbiamente un modello che continua a interpellarci, come ha sottolineato Toni Negri nel suo intervento. Ma una ricerca ad ampio raggio sulla dimensione globale della lotta proletaria non potrebbe che accumulare altri esempi di auto-organizzazione e di fissazione di un autonomo potere dei “subalterni” (dalle pratiche degli schiavi fuggiaschi nella rivoluzione di Haiti alla politicizzazione dell’organizzazione comunitaria indigena nella rivoluzione messicana e in quella boliviana, per fare solo due esempi). Ma, soprattutto, si tratta di cartografare il nostro presente alla ricerca di forme embrionali di auto-organizzazione che possano tradursi in istituti di contro-potere. Dal punto di vista di una teoria del dualismo del potere quel che conta è propriamente individuare i punti in cui processi di lotta e organizzazione possono tradursi nell’istituzione di organismi capaci di esprimere e stabilizzare dinamicamente istanze di potere.
Queste istanze di potere sono caratterizzate da una sostanziale asimmetria rispetto al potere dello Stato, con cui possono intrattenere una molteplicità di rapporti – dall’antagonismo alla negoziazione. In condizioni determinate questi rapporti possono assumere, senza negare l’elemento della asimmetria, una figura dialettica, nel senso che i due poteri possono “incitarsi” e rafforzarsi reciprocamente pur mantenendo la propria autonomia. Una politica comunista opera necessariamente nel senso di creare le condizioni per una dialettica di questo tipo, al cui interno la lotta per l’abolizione della proprietà privata può dispiegarsi con il massimo di efficacia e la stessa occupazione delle istituzioni esistenti consente di avviare un processo di profonda trasformazione di queste ultime. È tuttavia importante sottolineare che quella di cui sto parlando è una dialettica molto particolare, proprio perché si fonda sulla asimmetria tra i due poteri. Una rottura è comunque necessaria perché questa dialettica si avvii, e la politica comunista ha come obiettivo fondamentale proprio questa rottura, che può prodursi in diverse forme e con una profondità variabile. Ma una volta che questa rottura si è prodotta, qual è il compito di una politica comunista come quella che ho cercato qui di presentare nelle sue linee generali? Pensiamo alle situazioni in cui, sempre in forme coerenti con gli istituti della democrazia rappresentativa, il “potere” (o più realisticamente il “governo”) è stato effettivamente conquistato negli ultimi anni. Pensiamo ancora all’America Latina, ma anche alla Grecia o a città come Barcellona e Madrid. “Che fare?”, all’indomani delle vittorie elettorali? La mia risposta è questa: dividere il potere per moltiplicare la potenza dei processi di trasformazione, consolidare e praticare come nuovo terreno di azione politica l’asimmetria tra il potere statale (o municipale) e un sistema di contropoteri e autonomie che soli possono assicurare l’efficacia e la continuità della lotta contro la proprietà privata, tenendo aperta al tempo stesso la possibilità di una rottura del rapporto di capitale. È all’interno di questa teoria del dualismo del potere che una politica comunista può essere oggi rinnovata e ricostruita.