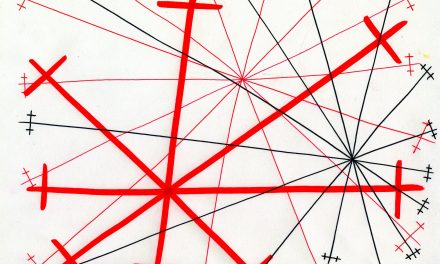di LORENZO COCCOLI.
(Il saggio che qui presentiamo, anche per il buon anno dal nostro collettivo, è contenuto in A. Quarta e M. Spanò (a cura di), Beni comuni 2.0. Contro-egemonia e nuove istituzioni, Mimesis, Milano-Udine 2016, pp. 23-34. Il comune è libertà. Una libertà che viene obliterata ogni volta che l’istanza collettiva che si vuole contrapposta all’<<individualismo possessivo>> assume coloriture comunitarie e invoca l’avveramento del bene comune. Che si tratti di una comunità ristretta – il borgo, i cittadini <<attivi>> di un quartiere metropolitano, ma anche il collettivo politico – o invece ampia – il popolo, la nazione – l’affermazione forte della propria identità e di valori comuni, vincolanti per i propri aderenti, da una parte consolida la comunità al suo interno, dall’altra marca il suo perimetro, ne fa un’entità pronta a rifiutare l’estraneo. Col risultato di declinare in forma collettiva quella coazione ad escludere propria dell’individualismo proprietario borghese che si intendeva contrastare. Ed è qui che la promessa del comunismo utopico, così bene narrata da Lorenzo Coccoli nel saggio che segue, si infrange, sostituendo pulsioni identitarie alle originarie istanze libertarie, e sovrapponendo alla possibile multiformità dei legami sociali l’univocità di un solo legittimo codice morale. E infine rivelandosi incapace di proiettare la propria virtù (e il proprio modello) al di là dei confini della sua dimensione comunitaria.
Perciò, come in passato l’ortodossia di pensiero e pratiche coltivata dentro comunità chiuse non è valsa a sconfiggere le relazioni di sfruttamento che strutturano le società capitaliste, così oggi non è invocando un ritorno al popolo sovrano che si risponde alla frammentazione della soggettività in mille identità diverse, destinate a popolare di nuove figure di consumo i mercati globali e di nuove forme di cittadinanza ‘debole’ le carte dei diritti neoliberali. Per quanto ci riguarda, le soggettività del comune, nella concreta materialità dei loro corpi, non possono che avere fisionomie ‘mosse’, plasmate dalle molteplici relazioni in cui sono immerse, dall’aggregarsi in dimensioni collettive sempre fluide e dinamiche. Queste ‘singolarità comuni’ rispecchiano l’eterogeneità costitutiva del lavoro vivo nelle metropoli. Il rapporto tra eterogeneità delle singolarità e comune si radica nella cooperazione sociale che esse stesse producono. Solo a partire dall’eterogeneità che vive nella cooperazione sociale possono darsi istituzioni del comune non identitarie e chiuse. Luoghi di costruzione e di esercizio di libertà. – Collettivo Euronomade)
«Le utopie non saranno mai lodate abbastanza per aver denunciato i misfatti della proprietà, l’orrore che rappresenta, le calamità di cui è causa. […] Questo mondo di proprietari [è] il più atroce dei mondi possibili»
(E.M. Cioran, Storia e utopia)
1.«Ben presto la lotta politica si svolgerà tra coloro che possiedono e coloro che non possiedono: il grande campo di battaglia sarà la proprietà»[1]. La nota profezia tocquevilliana, che precedeva di qualche mese la rivoluzione del febbraio ‘48 e la pubblicazione del Manifesto del partito comunista, può nuovamente essere eletta a divisa del nostro tempo. Certo, le parti in conflitto non sono più le stesse di un secolo e mezzo fa. Ma che la proprietà – meglio, l’espansione continua dei processi di privatizzazione del mondo materiale e immateriale – sia ancora un enjeu fondamentale dello scontro politico, sociale ed economico che attraversa e divide il presente, questo ha per noi l’evidenza di un fatto. È quasi superfluo, in questa sede, nominare gli opposti schieramenti che – per quanto fluidi, per quanto mutevoli – si contendono la partita: da un lato, i nuovi regimi di accumulazione originaria[2] e il «secondo movimento di enclosures»[3], elementi chiave di un più ampio dispositivo neoliberale e della sua affermazione su scala planetaria; dall’altro, le mobilitazioni, le resistenze, gli antagonismi che, dai movimenti altermondialisti degli anni Novanta e dei primi anni Duemila fino ai più recenti cicli di lotte globali, hanno cercato di contrastare l’avanzata della «nuova ragione del mondo».
Superfluo è anche ricordare il ruolo che la pratica e la teoria dei beni comuni hanno giocato nell’articolazione di questo fronte oppositivo. In prima battuta, la bandiera dei commons ha funzionato da «significante vuoto» capace di catalizzare energie e forze sociali eterogenee, innescando dinamiche feconde di soggettivazione[4]. Non solo. Il «benicomunismo» non si è limitato a servire da polo aggregatore di iniziative resistenziali, ma si è spinto fino a elaborare e proporre un progetto di società radicalmente alternativo a quello capitalistico, sfidando la pretesa egemonica del discorso neoliberale. Muovendosi insieme sul piano della tattica e della strategia, del costituito e del costituente, il movimento dei beni comuni è riuscito a riavviare il motore ingolfato dell’immaginazione politica, ideando e dando vita a nuove forme istituzionali orizzontali, partecipate e inclusive, in esodo dall’isomorfismo moderno di pubblico e privato[5].
Ora, non di rado i benicomunisti hanno attinto dal passato il carburante immaginario e simbolico per questo slancio in direzione del possibile. E ciò perché, scrivono Dardot e Laval, «quel che appare come l’aspetto più innovativo delle lotte emerge in un contesto e si iscrive in una storia. È l’esplorazione di questa lunga storia che permette di uscire dalle banalità, dalle confusioni e dai controsensi»[6]. Lo scavo archeologico e l’indagine genealogica hanno così permesso al discorso dei beni comuni di costruire il proprio archivio, di riallacciare i fili dei sentieri interrotti dal trionfo solo apparentemente pacifico dell’individualismo possessivo. Dalla Charter of the Forest alla guerra dei contadini, dalle comunità monastiche al mutualismo operaio, da Spinoza a Proudhon a Marx, pezzi di teorie e di prassi sono stati volta a volta convocati allo scopo di decifrare il palinsesto di una «altermodernità»[7] forclusa dall’avvento del paradigma proprietario. Ciò che mi propongo di fare, nello spazio di questo breve contributo, è aggiungere un ulteriore tassello a questa operazione contro-egemonica di memoria collettiva, recuperando una tradizione di pensiero che proprio sulla contestazione di quel paradigma ha costruito parte della sua plurisecolare fortuna. Mi riferisco a quelle scritture utopistiche che, da Platone in poi, hanno messo il comune al centro di un disegno di reinvenzione e (talvolta) di trasformazione delle strutture giuridico-politiche esistenti[8]. Per sgombrare subito il campo da dubbi: quel che mi interessa non è la démarche chimerica che in molti di questi testi separa nettamente l’essere dal dover essere, rendendo impossibile qualsiasi ricomposizione di reale e ideale. Piuttosto, si tratterà qui di analizzare il nodo concettuale che stringe assieme abolizione della proprietà privata, forme di vita comune e immaginazione istituzionale, distillandone le risorse di senso che, al di là e spesso anche contro le intenzioni dei singoli autori, possono essere messe a disposizione dell’oggi, segnalandone però al contempo le possibili derive regressive.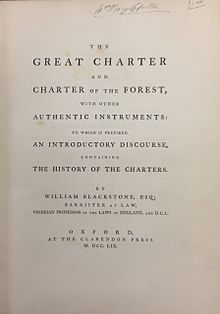
2. Nella sua monografia su Saint-Simon, risultato del ciclo di lezioni tenute a Bordeaux tra il 1895 e il 1896, Durkheim individua nell’insistenza esclusiva sulle conseguenze morali della proprietà lo specificum del comunismo utopistico: «La loro [dei comunisti] idea fondamentale, che ritorna sempre sotto forme leggermente differenti, è che la proprietà privata è la fonte dell’egoismo e che dall’egoismo deriva l’immoralità. […] In sostanza, nel suo insieme, il comunismo consiste in un luogo comune della morale astratta che non è propria di nessun tempo e di nessun paese»[9]. Difficile, anzi impossibile negare la predominanza dei toni moraleggianti nel discorso utopistico, in particolare per tutto ciò che riguarda la costellazione del proprium: avarizia, ambizione, invidia e ipocrisia sono i frutti avvelenati dell’«empia Proprietà, Madre di tutti i crimini che inondano il Mondo»[10]. Ed è anche vero, a contrario, che la forma di vita comunitaria – che d’altronde ha spesso a modello la Chiesa primitiva e il cenobitismo – è puntualmente descritta ricorrendo al lessico della virtù, della santità, della perfezione: «Per quanto riguarda il genere di vita, si è detto e provato con l’esperienza che essa è possibile, in quanto è più conforme a natura vivere secondo la ragione e la virtù che secondo la sensualità e il vizio, […] e questo lo provano i monaci e al giorno d’oggi gli Anabattisti, che vivono in comunità»[11]. Ciò detto, resta tuttavia da chiarire quale sia il passaggio logico che consente di riconoscere nella proprietà la fonte di ogni male e nel comune la precondizione di una possibile palingenesi individuale e collettiva. Che cosa permette di attribuire all’una e all’altro un potere performativo tale da indirizzare in due direzioni in tutto e per tutto opposte i destini dell’uomo e della società?
Il punto – che vorrei avanzare almeno in via di ipotesi – è che quei due principi figurano nelle scritture utopistiche non solo e non tanto come semplici dispositivi di regolazione del rapporto tra le persone e i beni, ma come scaturigine di due processi distinti di soggettivazione. Il soggetto non è qui qualcosa che interamente preesiste all’appropriazione (privata o comune) delle cose, ma è invece almeno in parte l’effetto dell’istituzionalizzazione di quell’appropriazione. È l’istituzione della proprietà privata, o viceversa la sua negazione, che letteralmente fa l’uomo buono o cattivo. Ecco l’intuizione implicita nel comunismo utopico: il comune è potenza produttiva di soggettività radicalmente altre rispetto a quelle esistenti, modellate sul paradigma dell’individuo possessivo. E ciò rimane valido indipendentemente dai differenti contenuti morali di cui ciascun autore decide poi di sostanziare questa alterità. Di qui, l’impossibilità stessa di misurare con i nostri parametri proprietari esseri così diversi da noi: «Essi non hanno né le nostre passioni, né le nostre inclinazioni, né i nostri desideri»[12]. Sarebbe perciò inesatto parlare, a proposito della letteratura utopistica, di un’antropologia ingenuamente positiva. Piuttosto, almeno in prima istanza, quel che pare emergere è una concezione plastica della natura umana, la quale può essere modellata in un senso o in un altro a seconda del contesto istituzionale in cui è inserita. «L’uomo» scrive Morelly «non ha né idee, né tendenze innate»[13]. Sono i legislatori, coloro cioè che hanno dato vita al diritto civile fondato sulla proprietà privata, che «hanno precisamente fatto tutto quanto occorreva per gettare e far schiudere nel cuore dell’uomo il seme di vizi che non vi erano mai stati e per soffocare quel poco di virtù che pensano di coltivarvi»[14]. Ciò spiega perché «la vita e i beni in comune» non siano solo un elemento tra i tanti dell’invenzione utopica, ma «ciò che forma più che mai il massimo fondamento di tutta la loro [degli Utopiani] organizzazione sociale»[15]. Il comune disancora i soggetti dall’esistente – a cui sono legati dal «peso dei loro possessi»[16] – li deterritorializza e fa di questa deterritorializzazione la condizione di un altro mondo possibile. Esso è dunque la leva di scambio che devia l’utopia dai binari del reale e ne aziona la prolifica e spesso dettagliatissima immaginazione istituzionale, la quale investe fin nei particolari ogni aspetto dell’organizzazione materiale e simbolica delle comunità umane.
3. È proprio questo primo momento di fluidificazione dei rapporti sociali, liberati dalle rigidità del «mio» e del «tuo», che appare come massimamente minaccioso agli avversari del comunismo utopico, consapevoli della sua dirompente carica sovversiva. Già More, anticipando forse in via cautelativa alcune possibili obiezioni al suo progetto, rilevava che «con questa sola cosa si rovescerebbe dalle basi ogni nobiltà, ogni magnificenza e splendore e maestà, che formano, secondo l’opinione pubblica, la bellezza e l’ornamento dello Stato»[17]. Una ventina d’anni più tardi, un altro umanista amico di More, Juan Luis Vives, in un opuscolo scritto per condannare la rivolta di Münster, darà voce a preoccupazioni analoghe. La communio rerum che gli anabattisti hanno proclamato nella loro «Nuova Gerusalemme» è «assurda, empia e perversa» perché sottrae il terreno su cui poggiano le gerarchie sociali, economiche e politiche che reggono l’ordine della società. Senza differenze nella distribuzione di ricchezze e onori, niente più ranghi, niente più ceti, niente più status, ma solo una «ingiustissima eguaglianza tra inferiori e superiori»[18]. Senza il pungolo della povertà, niente più ripartizione funzionale dei compiti e obbligo al lavoro: «Perché se ora, con tutta l’urgenza della necessità e l’ammonimento dell’indigenza, si trovano così tanti indolenti che preferirebbero morire piuttosto che lavorare, cosa pensiamo accadrà una volta imposta l’eguaglianza e la comunità di tutte le cose?»[19]. Ma soprattutto, l’utopia comunitaria dei ribelli anabattisti esclude alla radice qualsiasi distinzione politica dei ruoli, qualsiasi regime di governo, qualsiasi relazione di comando e obbedienza: «Vi sembra bene che nessuno sia padrone e nessuno servo? […] Pensate forse che tutti debbano essere magistrati o, al contrario, che tutti debbano essere privati cittadini? La legge di Cristo distingue tra padroni e servi, magistrati e privati. Non sovverte quell’ordine grazie alle cui prescrizioni ogni cosa sussiste […]. Come sarebbe possibile immaginare una Repubblica in cui nessuno governasse e comandasse nessun altro, quasi un corpo senza testa, una nave senza timone e senza timoniere, un uomo senza ragione?»[20].

È precisamente questa presunta impossibilità che il discorso utopistico prova a mettere in figura. Il soggetto del comune, sciolto dalla dimensione del proprio, diventa – o almeno tende a diventare –soggetto nomade indisponibile alle tradizionali strutture familiari, sociali, politiche. L’abolizione della proprietà (privata) e l’uso (comune) delle cose dissolvono la solidità delle forme trascendenti che organizzano l’ordine stabilito e aprono uno spazio di immanenza in cui i singoli possono muoversi liberamente senza fissarsi in identità predeterminate. Come vedremo, non è questa l’ultima parola degli utopisti sull’argomento: nella quasi totalità dei casi, infatti, un’altra trascendenza interviene a richiudere nuovamente quello spazio. E tuttavia, resta il fatto che molta parte della vita comunitaria da loro descritta si colloca sotto il segno del dinamismo, della circolazione, della mobilità. Mobilità letterale: nelle città ideali si viaggia, alle città ideali si arriva viaggiando. Le loro architetture sono pensate per ottenere «spazio e libertà di movimento»[21], e lì non vige la legge della fissa dimora: «Nessuno possiede una casa in proprietà privata, ma tutte sono concesse e assegnate in uso, e, se lo Stato vuole, cambiano con facilità di abitazione»[22]. Ma soprattutto, è una mobilità soggettiva che attraversa e invalida i confini tracciati dalla verticalità gerarchica degli apparati che bloccano la fluidità dei rapporti e limitano gli incontri e gli scambi. L’amore non è costretto nelle maglie della «eterna schiavitù» del matrimonio: «Sì, dicono gli amanti, fintanto che ci ameremo saremo inseparabili»[23]. L’ineguale distribuzione di ricchezza, dignità e sapere/potere non destina più una parte consistente della società alle fatiche di un’attività ingrata e sempre identica a sé, e la divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale sembra venire meno: «Ma tra loro, partendosi l’offizi a tutti e le arti e fatiche, non tocca faticar quattro ore il giorno per uno; sì ben tutto il resto è imparare giocando, disputando, leggendo, insegnando, camminando, e sempre con gaudio»[24]. Il cacciatore-pescatore-allevatore-critico dell’Ideologia Tedesca non è poi così lontano.
Soprattutto, date queste premesse, è la stessa distinzione tra governanti e governati che tende, almeno potenzialmente, a dileguare. Tutto è comune, anche il potere: e il governo sfuma, sia pur con gradazioni diverse a seconda degli autori, nell’autogoverno. Persino lì dove si riconoscono ancora magistrati, funzionari e ufficiali, principi di eleggibilità, sorteggio, rotazione delle cariche sono intesi ad assicurare un’eguale distribuzione della facoltà decisionale su tutto il tessuto sociale. Ma il punto limite resta quello della cancellazione totale di qualsiasi separatezza nella gestione del potere. Non si tratta tanto, si badi bene, del passaggio saint-simoniano dal governo degli uomini all’amministrazione delle cose, quanto di una saldatura perfetta tra forma di vita e regole che disattiva ogni dispositivo di autorizzazione. Nell’Inghilterra futura di Morris, le «regole […] hanno sostituito il governo. […] Sono ormai centocinquanta anni che viviamo più o meno in questo modo e in noi si è andata sviluppando una tradizione o, per meglio dire, un sistema di vita, che ci spinge ad agire sempre per il meglio»[25]. Il mostruoso corpo senza testa paventato da Vives diventa qui una paradossale «realtà».
4. Questa però, come accennavo, è solo una parte della storia: una linea di tendenza, una virtualità quasi sempre destinata a rimanere tale. Il punto è che quel primo movimento deterritorializzante, i cui effetti concettuali abbiamo sopra tentato di delineare, risulta nella stragrande maggioranza dei casi propedeutico a un nuovo movimento di riterritorializzazione. Il soggetto è sottratto alla sfera del proprium solo per essere consegnato a un proprium più autentico, più originario. La metafisica proprietaria viene rimpiazzata da un’altra metafisica, altrettanto letale: la metafisica della comunità. Il comune non gioca più allora il ruolo di moltiplicatore di differenze e di incubatore di soggettività mobili, ma al contrario serve a garantire la fusione indifferenziata dei singoli in una comunione immediata, assoluta, totalizzante. A sua volta, questa comunità sostanzializzata si costituisce in potere separato che trascende il corpo sociale e assegna a ognuno compiti e ruoli in nome di una finalità collettiva. I beni comuni si riducono all’unum di un bene comune che, sia pur su basi diverse, ripristina la verticalità della classificazione gerarchico-funzionale[26].
Il testo platonico della Repubblica – che, com’è noto, rappresenta uno tra i più importanti punti di riferimento delle scritture utopistiche – esibisce questa dinamica con straordinaria evidenza. Non serve ricordare che la forma di vita comune della kallipolis non è affare di tutti i suoi membri ma solo della classe dei custodi[27]. Eppure, anche all’interno di questo ambito di applicazione ristretto, sono chiari gli scopi a cui essa è chiamata ad assolvere. Si tratta, innanzitutto, di istituire quella «comunanza di piacere e dolore» che lega la città fino ad assimilarla «alla condizione di un solo uomo»[28]. Il problema dell’attrito possibile tra gli interessi privati e della loro eventuale composizione è risolto azzerando del tutto la dimensione dell’idiosis (privatezza), nel tentativo di ottenere una comunità epurata da ogni striatura conflittuale, in cui tutti pronuncino all’unisono il «mio» e il «non mio»: «Questo li rende del tutto estranei a quei motivi di conflitto che vengono agli uomini dal possesso di ricchezze, figli, parenti»[29]. Per esserne espressione adeguata, anche il potere che una tale comunità esercita su sé stessa e sugli altri deve essere sottoposto a un analogo processo di es-propriazione. La sfida a cui rispondere è quella lanciata da Trasimaco: «È che tu pensi che i pastori e i bovari cerchino il bene del gregge o dei buoi, e li ingrassino e li curino avendo di mira qualche altro motivo che non sia il bene dei padroni e il loro proprio. E così anche coloro che detengono il potere nelle città […]»[30]. Il comune serve allora a riportare il governo «pastorale» dei custodi alla sua verità, trasformando questi ultimi da lupi famelici in cani fedeli al servizio della polis. Senza beni o affetti familiari in proprio, nessuna utilità personale interviene a distrarre i governanti dai loro doveri: «E così potranno salvarsi e salvare la città. Ma allorché essi possiedano privatamente terre e case e denaro, diventeranno amministratori di un patrimonio e agricoltori invece che difensori, padroni ostili anziché alleati degli altri cittadini»[31]. La rottura dell’equazione ricchezza/potere svuota il politico di ogni contenuto sociale o economico, elevandolo così a una trascendenza che disallinea il comune dalla sua traiettoria immanentista e lo cattura all’interno di un’altra linea genealogica, quella del «servizio pubblico»[32]. Solo eliminando proprietà e interesse personale si può sperare di rendere «magistrati, grandi di una Repubblica, monarchi […] semplici ministri designati a prender cura della felicità» dei loro popoli[33].
Infine, questa riconfigurazione degli assetti di potere consente a chi governa di svolgere al meglio il proprio officium: assegnare a ogni membro della macchina comunitaria una posizione e un compito, non più sulla base del censo o del ceto ma in considerazione esclusiva dell’inclinazione, del talento, del merito. Incarico principale del re-filosofo è quello di riconoscere le qualità naturali dei suoi concittadini – l’oro, l’argento, il bronzo – e di armonizzarle in un tableau vivant in cui a ciascuno è affidata una e una sola mansione, avendo sempre di mira il fine superiore del bene comune della città[34]. All’interno di questa operazione di ripartizione e classificazione funzionale, il comune gioca un duplice ruolo di veridizione: dal lato dei governanti, esso garantisce che il loro giudizio non venga fuorviato da simpatie o tornaconti personali, riducendo così al minimo le possibilità di errore; da quello dei governati, esso fa sì che ogni natura si mostri nella sua verità, senza potersi più nascondere sotto il velo fittizio delle differenze sociali. Com’è forse intuibile, la forza centripeta di questo dispositivo teorico non è ridotta ma amplificata dall’estensione della «comunità di vita» a tutto il corpo sociale. Prendiamo, all’altro capo della letteratura utopistica, l’Icaria di Cabet. Di nuovo, il comune è veicolo non di singolarità mobili ma di reductio ad unum comunitaria: «La Comunità non ha gli inconvenienti della Proprietà; perché essa fa sparire l’interesse particolare per fonderlo nell’interesse pubblico, […] l’individualismo e il particolarismo per far posto all’associazione o al socialismo, alla devozione e all’unità»[35]. Di nuovo, esso si costituisce in potere trascendente che si piega sulla società per governarla, organizzarla, potenziarla: «Padrona di tutto, [la Comunità] centralizza, concentra, riduce tutto all’unità; ragiona, combina, dirige ogni cosa; e così facendo, essa sola può ottenere al meglio il vantaggio incommensurabile di evitare i doppi incarichi e gli sprechi, di realizzare appieno l’economia, […] di sviluppare continuamente la perfettibilità dell’uomo»[36]. Di nuovo, infine, questa amministrazione centralizzata assegna a ciascuno la parte da svolgere nel suo piano di razionalizzazione economica: «Senza dubbio, la Comunità impone necessariamente vincoli e obblighi; perché la sua principale missione è di produrre la ricchezza e la felicità» e, affinché possa adempiervi, «occorre che sottometta tutte le volontà e tutte le attività alla sua regola, al suo ordine, alla sua disciplina»[37]. La lezione è perspicua: ogni volta che il comune imbocca la strada metafisica della comunità, la singolarità è sacrificata al totem/totum dell’interesse pubblico, il piano di immanenza sussunto sotto la verticalità dell’organizzazione. Il corpo ha di nuovo una testa.
 5. Per tirare le fila. Quel che le scritture utopistiche pensano e consentono di pensare è il comune inteso come principio di soggettivazione alternativo a quello proprietario. È questa l’«ipotesi comunista» che, credo, può mettere conto recuperare, collocandola al cuore di un progetto di reinvenzione e trasformazione dell’esistente. Il comune deve produrre i suoi soggetti. Solo che questa produzione si attiva sempre sull’orlo di un paradosso: una volta liberati dalla gabbia d’acciaio della proprietà, i singoli rischiano ancora di essere restituiti all’immobilità di un proprium che ritorna sotto forma di appartenenza comunitaria, (ri)diventando «i proprietari del loro comune»[38]. È il fantasma della comunità che trasforma le città ideali in incubi totalitari. Di qui la tensione tra presupposto egalitario ed esito gerarchico del comunismo storico[39], di qui la «cattura burocratica del comune» all’interno del socialismo reale[40]. Se allora il benicomunismo vuole restare fedele alla sua vocazione «strategica» e autenticamente rivoluzionaria, è tra la Scilla della proprietà e la Cariddi della comunità che deve continuamente navigare. La concettualità del comune si distingue da quelle rivali del privato e del pubblico come l’immanenza dalla trascendenza, come la condivisione diffusa di sapere/potere dalla separatezza degli apparati tecnocratici, come la mobilità nomade dalla fissazione in ruoli stabili e stabiliti. Compito dei benicomunisti deve essere quello di difendere il primo momento contro le pretese del secondo, preservandone sempre l’apertura e facendone la falsariga per una riscrittura radicale della società e delle sue istituzioni. In questo senso, qualche proposta concreta può già essere avanzata: diritto al movimento e alla circolazione, reddito di base sganciato dall’obbligo al lavoro, creazione di spazi di autogoverno a livello locale, ripensamento in chiave federalistica delle strutture politiche nazionali e sovra-nazionali. Non sono che titoli di un programma necessariamente più vasto, e che proprio nel comune potrebbe avere il suo punto di capitone. Un programma che, per concludere senza concludere, vorrei porre sotto il segno del giovane e «indisciplinato» Béasse di Sorvegliare e punire:
5. Per tirare le fila. Quel che le scritture utopistiche pensano e consentono di pensare è il comune inteso come principio di soggettivazione alternativo a quello proprietario. È questa l’«ipotesi comunista» che, credo, può mettere conto recuperare, collocandola al cuore di un progetto di reinvenzione e trasformazione dell’esistente. Il comune deve produrre i suoi soggetti. Solo che questa produzione si attiva sempre sull’orlo di un paradosso: una volta liberati dalla gabbia d’acciaio della proprietà, i singoli rischiano ancora di essere restituiti all’immobilità di un proprium che ritorna sotto forma di appartenenza comunitaria, (ri)diventando «i proprietari del loro comune»[38]. È il fantasma della comunità che trasforma le città ideali in incubi totalitari. Di qui la tensione tra presupposto egalitario ed esito gerarchico del comunismo storico[39], di qui la «cattura burocratica del comune» all’interno del socialismo reale[40]. Se allora il benicomunismo vuole restare fedele alla sua vocazione «strategica» e autenticamente rivoluzionaria, è tra la Scilla della proprietà e la Cariddi della comunità che deve continuamente navigare. La concettualità del comune si distingue da quelle rivali del privato e del pubblico come l’immanenza dalla trascendenza, come la condivisione diffusa di sapere/potere dalla separatezza degli apparati tecnocratici, come la mobilità nomade dalla fissazione in ruoli stabili e stabiliti. Compito dei benicomunisti deve essere quello di difendere il primo momento contro le pretese del secondo, preservandone sempre l’apertura e facendone la falsariga per una riscrittura radicale della società e delle sue istituzioni. In questo senso, qualche proposta concreta può già essere avanzata: diritto al movimento e alla circolazione, reddito di base sganciato dall’obbligo al lavoro, creazione di spazi di autogoverno a livello locale, ripensamento in chiave federalistica delle strutture politiche nazionali e sovra-nazionali. Non sono che titoli di un programma necessariamente più vasto, e che proprio nel comune potrebbe avere il suo punto di capitone. Un programma che, per concludere senza concludere, vorrei porre sotto il segno del giovane e «indisciplinato» Béasse di Sorvegliare e punire:
Il presidente: – Si deve dormire a casa –. Béasse: – Ma io ho una casa? – Voi vivete in un perpetuo vagabondaggio. – Io lavoro per guadagnarmi la vita. – Qual è il vostro stato? – Il mio stato: prima di tutto ne ho almeno trentasei; poi non lavoro da nessuno. È già da un po’ che vivo coi miei soldi. Ho degli stati di giorno e degli altri di notte. Così per esempio, di giorno distribuisco foglietti stampati gratis a tutti i passanti; corro all’arrivo delle diligenze per portare i pacchi; mi dò arie nel viale di Neully; la notte ho gli spettacoli; vado ad aprire gli sportelli, vendo le contromarche; ho molto da fare. – Sarebbe meglio per voi essere sistemato in una buona casa, e farvi un apprendistato. – Già…una buona casa, un apprendistato, che barba. E poi dopo il padrone, quello rogna sempre, e poi, niente libertà. – Vostro padre non vi reclama a casa? – Niente padre. – E vostra madre? – Niente madre, né parenti, né amici, libero e indipendente[41].
[1] A. de Tocqueville, Una rivoluzione fallita. Ricordi del 1848-1849, Laterza, Bari 1939, p. 9.
[2] Accuratamente cartografati in S. Mezzadra e B. Neilson, Confini e frontiere. La moltiplicazione del lavoro nel mondo globale, il Mulino, Bologna 2014. Ma cfr. anche D. Sacchetto e M. Tomba (a cura di), La lunga accumulazione originaria. Politica e lavoro nel mercato mondiale, ombre corte, Verona 2008.
[3] Cfr. J. Boyle, The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain, «Law and Contemporary Problems», n. 66, 2003, pp. 33-74.
[4] Cfr. M. Spanò, Who’s the Subject of the Commons? An Essay in Genealogy, in S. Bailey, G. Farrell e U. Mattei (a cura di), Future Generations and the Commons, Publications of the Council of Europe, Strasbourg 2013, pp. 44-59.
[5] Cfr. U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Laterza, Roma-Bari 2011; e Id., Il benicomunismo e i suoi nemici, Einaudi, Torino 2015.
[6] P. Dardot e C. Laval, Del Comune, o della Rivoluzione nel XXI secolo, DeriveApprodi, Roma 2015, p. 21.
[7] Sul concetto di altermodernità cfr. M. Hardt e A. Negri, Comune. Oltre il privato e il pubblico, trad. it. Rizzoli, Milano 2010, pp. 75-124.
[8] Per ragioni di concisione, non potrò qui addentrarmi nella spinosa questione della definizione del genere «utopia», dibattuta in lungo e in largo nell’ambito dei cosiddetti Utopian Studies, né potrò soffermarmi, se non di passaggio, sulle pur rilevanti differenze di contesto storico-politico che separano le opere che prenderò in esame. Su entrambi i punti mi limito a rimandare a R. Levitas, The Concept of Utopia, Philip Allan, New York-London 1990; e a G. Claeys (a cura di), The Cambridge Companion to Utopian Literature, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
[9] É. Durkheim, Il socialismo. Definizioni, origini, la dottrina saintsimoniana, Franco Angeli, Milano 1973, p. 211. Nella loro ricostruzione del comunismo pre-marxiano, Dardot e Laval (Del comune, cit., pp. 52-60) fanno sostanzialmente loro la lettura durkheimiana, pur aggiustandone qua e là il tiro.
[10] É.-G. Morelly, Naufrage des isles flottantes, ou Basiliade du célèbre Pilpai, Messina 1753, vol. I, p. 5.
[11] T. Campanella, Questione quarta sull’ottima Repubblica, in Id., La città del Sole, Rizzoli, Milano 20073, p. 119.
[12] B. de Fontenelle, La République des philosophes, ou Histoire des Ajaoiens, Genève 1768, p. 51.
[13] É.-G. Morelly, Codice della Natura, Einaudi, Torino 1952, p. 54.
[14] Ivi, p. 53.
[15] T. Moro, L’Utopia, Laterza, Roma-Bari 201017, p. 134.
[16] J.V. Andreae, Descrizione della repubblica di Cristianopoli e altri scritti, Guida, Napoli 1983, p. 170.
[17] Moro, L’Utopia, cit., p. 134.
[18] J.L. Vives, De communione rerum ad Germanos inferiores, Köln 1535, fol. A 2v.
[19] Ivi, fol. B 7r.
[20] Ivi, foll. B 3r e v.
[21] W. Morris, Notizie da nessun luogo ovvero un’epoca di riposo, Guida, Napoli 1978, p. 168.
[22] Andreae, Descrizione della repubblica di Cristianopoli, cit., p. 115.
[23] Morelly, Naufrage des isles flottantes, cit., p. 28. Tocchiamo qui, necessariamente di sfuggita, uno degli aspetti più problematici del comunismo utopico: la comunità delle donne, tratto ricorrente in quasi tutti gli autori e presente nelle due principali fonti della letteratura utopistica (la Repubblica di Platone e il Decretum di Graziano). Sarebbe interessante studiare la persistenza dell’ordine simbolico patriarcale anche in quelle scritture che tentano di immaginare un’alternativa radicale rispetto all’organizzazione sociale dominante: ma il discorso meriterebbe una trattazione a sé che qui, per ragioni di spazio, devo purtroppo sacrificare. Cfr. però C.S. Ferns, Narrating Utopia. Ideology, Gender, Form in Utopian Literature, Liverpool University Press, Liverpool 1999.
[24] Campanella, La città del Sole, cit., p. 65.
[25] Morris, Notizie da nessun luogo, cit., p. 179. Di indistinzione tra regola e forma di vita parla G. Agamben in Altissima povertà. Regole monastiche e forme di vita, Neri Pozza, Vicenza 2011. Non a caso, come si è già avuto modo di notare, il cenobitismo monastico costituisce uno dei modelli ricorrenti del comunismo utopico.
[26] Sulla distinzione beni comuni/bene comune cfr. M.R. Marella, Bene comune. E beni comuni: le ragioni di una contrapposizione, in F. Zappino, L. Coccoli e M. Tabacchini (a cura di), Genealogie del presente. Lessico politico per tempi interessanti, Mimesis, Milano-Udine 2014, pp. 25-39.
[27] Sul «comunismo» nella Repubblica platonica, e in generale in tutto il pensiero greco antico, cfr. D. Dawson, Cities of the Gods. Communist Utopia in Greek Thought, Oxford University Press, New York-Oxford 1992.
[28] Platone, La Repubblica, V, 462b4 e c9, Rizzoli, Milano 2007, p. 677.
[29] Ivi, V, 464e1-2, p. 687.
[30] Ivi, I, 343b1-5, p. 305.
[31] Ivi, III, 417a6-b1, p. 535.
[32] Cfr. sul punto P. Napoli, Indisponibilità, servizio pubblico, uso. Concetti orientativi su comune e beni comuni, «Politica & Società», n. 3, 2013, pp. 403-426.
[33] Morelly, Codice della Natura, cit., p. 103.
[34] È questa, secondo Rancière, l’ingiunzione che regge la Repubblica e che dà senso al comunismo platonico: che ciascuno faccia la sua parte e si attenga rigidamente al suo ruolo. Siamo qui agli antipodi di quel comune «nomade» di cui si è detto sopra. Cfr. J. Rancière, Les philosophe et ses pauvres, Flammarion, Paris 2007, in particolare pp. 15-85.
[35] É. Cabet, Voyage en Icarie, Paris 18452, p. 397.
[36] Ivi, p. 398.
[37] Ivi, p. 403.
[38] R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Einaudi, Torino 2006, p. IX.
[39] Cfr. J. Rancière, Comunisti senza comunismo?, in C. Douzinas e S. Žižek (a cura di), L’idea di comunismo, DeriveApprodi, Roma 2011, pp. 191-201.
[40] Cfr. Dardot e Laval, Del Comune, cit., pp. 50-75.
[41] M. Foucault, Sorvegliare e punire. Nascita della prigione, Einaudi, Torino 19932, pp. 321-322.