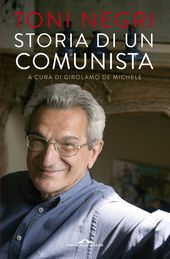di GIROLAMO DE MICHELE.
Per il segno che ci è rimasto non ripeterci quanto ti spiace
Non ci chiedere più com’è andata
(F. De André)
1. Una storia da basso Impero
Il quarantennale del sequestro e omicidio di Aldo Moro e degli uomini della scorta sembra essere segnato più dalle mancate occasioni di riflessione, che da un reale sforzo di riflessione sulla figura di Aldo Moro, il ruolo di DC e PCI, il periodo segnato da una crisi che all’epoca parve potesse mettere il punto conclusivo alla storia del capitalismo industriale, e che invece segnò l’avvio di una feroce ristrutturazione. Come un treno che si porta le rotaie verso casa, la macchina della commemorazione oscilla fra luoghi comuni e complottismi di una certa storiografia tipo Flamigni, riscritture agiografiche della storia brigatista per giustapposizioni, cancellazioni e qualche franca bugia [cfr. ⇒ questo intervento di Lanfranco Caminiti], esaltazioni acritiche del “grande statista” che non fu né l’uno né l’altro. Ricostruzioni concordi nella ripartizione dei rispettivi monopoli: quello del diritto e della ragione, impugnato dallo Stato che “resiste al terrore” (e a eventuali “centrali oscure”); e il monopolio, o quantomeno l’egemonia, dell’opposizione allo stato di cose presenti e della rivolta, che si vorrebbe appaltato alle BR.
 Bene ha fatto, dunque, l’editore Cairo a ripubblicare a distanza di 10 anni Un affare di Stato. Il delitto Moro 40 anni dopo di Andrea Colombo; che vi ha aggiunto un capitolo riassuntivo del girare a vuoto della macchina dei sospetti che, nel suo moto perenne, trasforma il presupposto aprioristico «che nulla sia andato come sembrerebbe», con buona pace di sentenze e atti parlamentari, nella «la certezza dell’esistenza di un aspetto sconosciuto ma tale da modificare la lettura storica». Certezza fondata sulla natura misteriosa, e dunque inattingibile per definizione (il permanere del mistero è la prova stessa dell’esistenza del mistero), di ciò che fonda la «misteriologia del caso Moro», e al tempo stesso ne deriva.
Bene ha fatto, dunque, l’editore Cairo a ripubblicare a distanza di 10 anni Un affare di Stato. Il delitto Moro 40 anni dopo di Andrea Colombo; che vi ha aggiunto un capitolo riassuntivo del girare a vuoto della macchina dei sospetti che, nel suo moto perenne, trasforma il presupposto aprioristico «che nulla sia andato come sembrerebbe», con buona pace di sentenze e atti parlamentari, nella «la certezza dell’esistenza di un aspetto sconosciuto ma tale da modificare la lettura storica». Certezza fondata sulla natura misteriosa, e dunque inattingibile per definizione (il permanere del mistero è la prova stessa dell’esistenza del mistero), di ciò che fonda la «misteriologia del caso Moro», e al tempo stesso ne deriva.
Misteriologia alla quale non è sfuggito neanche Gotor, autore di una monumentale ricostruzione fondata sulla punta di spillo del presupposto che uno degli esiti della sequenza storica – il cosiddetto Memoriale – debba esserne lo scopo, la causa finale che spiega l’intero processo (un po’ come spiegare, come fece Pisanò, la cattura e fucilazione di Mussolini a partire dal fantomatico oro di Dongo): deducendo quindi la struttura delle BR dall’ipotetico identikit intellettuale del presunto inquisitore di Moro, che nel giro di poche righe passa dall’essere «soggetto collettivo dai multiformi e imprevedibili contatti» a «docente di livello universitario» con «appropriate conoscenze della politica italiana in tutti i suoi risvolti». Oscillando, come pezze d’appoggio, fra «una riflessione acuta» di Claudio Signorile ripetuta tre volte (seguendo una nota legge di Lewis Carroll: I have said it thrice: What I tell you three times is true), una inverosimile affermazione del brigatista pentito Cianfanelli (che per essere più credibile viene trasformato dallo stesso Gotor in dissociato), e la capacità di Cossiga di produrre «sorprendenti ritratti».
2. Una storia un po’ complicata
«Se può essere, perché dobbiamo cercarne altre più complicate, e che complicano?», scriveva in conclusione di Todo modo Sciascia attraverso il suo commissario.
Non avendo l’ambizione di proporsi come intellettuale di riferimento né consigliere del Principe (posto che talvolta i principi hanno i consiglieri che si meritano, e viceversa), Andrea Colombo aveva già fatto giustizia di questa macchina complottistico-paranoica ex ante, con un esercizio di ricostruzione empirica e talora “minimalista”, che ha il pregio di misurare ogni passo non solo sull’evidenza che giustifica ciò che si può dire, ma anche sulla consapevolezza che ciò che “non si può dire” è spesso il prodotto di una costruzione: un’astrazione determinata tutt’altro che neutra. Esemplare, da questo punto di vista, è il capitolo iniziale (della prima edizione) che ricostruisce l’agguato di via Fani e l’assassinio degli uomini di scorta. Colombo dimostra infatti che non ci fu, in via Fani, quella geometrica potenza la cui evocazione infiniti addusse lutti a un movimento già in crisi profonda: la percezione di una macchina infallibile, a seconda degli interpreti in grado di guidare e rilanciare la lotta armata alzando sempre più il livello di scontro, ovvero prova provata della presenza di killer espertissimi e infallibili, servizi segreti di mezzo mondo e romanzeschi criminali dai quattro angoli d’Italia, era per l’appunto una percezione. Dietro la quale c’erano mitra vecchi e malmessi che si incepparono, decine di colpi andati a vuoto, bersagli mal scelti (non a caso l’autista Ricci era quasi riuscito a disincastrare l’auto di Moro): insomma, un agguato che andò a buon fine solo per la mancanza della blindatura delle auto, per la leggerezza degli uomini di scorta che non avevano in pugno le armi, per la prevedibilità del percorso. Quella scorta che Moro definisce, con sbrigativo cinismo, «per ragioni amministrative del tutto al di sotto delle esigenze della situazione» (lettera a Zaccagnini del 4 aprile).
L’insensibilità di questo cenno, l’unico alla scorta fatto da Moro nel suo epistolario, ha fornito il la per la tesi che l’autore di queste parole non potesse essere nel pieno possesso delle sue facoltà: che queste parole non fossero «moralmente a lui ascrivibili».
E invece lo erano. Un anno addietro, durante il suo intervento dell’11 marzo 1977 in parlamento sul “caso Lockeed” – quello del «noi non ci faremo processare» [leggibile ⇒ qui] – Moro (alla pari degli altri democristiani intervenuti) non sentì il bisogno morale di spendere una sola parola di cordoglio per i 44 avieri morti nello schianto di un aereo Lockeed il giorno stesso dell’apertura della discussione. Né mai ne spese per i morti sul lavoro (in quegli anni il doppio di quelli attuali) o per le morti per eroina che veniva usata come arma politica contro il movimento – si muore di eroina, si muore di lavoro diventerà uno degli slogan più gridati nei cortei: con buona pace di ⇒ Marco Damilano, che fa di una frase estrapolata dalla lettera a Misasi («datemi un milione di voti e toglietemi un atomo di verità e io sarò perdente») l’emblema di un Moro glorificato e santificato, le parole di Moro e la verità erano divergenze parallele.
Fatto è che, per tornare al silenzio sulla scorta, nominare la strage non era una mossa politicamente opportuna, nell’aprire e condurre una trattativa: quei 5 morti costituivano un macigno sulla strada di un possibile accordo fra Stato e BR (e il primo a gettare quel macigno fu Luciano Lama). Perché – è il cuore del libro di Colombo – alla strage via Fani e al sequestro segue una lunga trattativa, della quale possono non essere noti aspetti e ruoli, ma il cui senso è del tutto evidente: alle BR che chiedevano in prima battuta la liberazione dei prigionieri politici, e che alla fine si sarebbero accontentati di un gesto anche formale – come la liberazione di Paola Besuchio, o di Alberto Buonoconto, la cui morte è anch’essa parte della tragedia che inizia il 16 marzo 1978 – la DC risponde con l’intransigente rifiuto di un riconoscimento politico delle BR; salvo percorrere fino in fondo, spinta in ciò dall’azione di Paolo VI, la strada del pagamento di un cospicuo riscatto (col quale le BR avrebbero potuto finanziare la propria azione armata per anni); strada alla quale il PCI, intransigente sul riconoscimento politico – che avrebbe significato ammettere l’esistenza di un’opposizione a sinistra –, diede il via libera con togliattiana doppiezza: con le parole di Pecchioli, «fatelo, ma non ditecelo».
 È nel corso di questa trattativa che Moro, per usare una pregnante lettura di Sciascia, tentando «di dire col linguaggio del nondire, di farsi capire adoperando gli stessi strumenti che aveva adottato e sperimentato per non farsi capire», ovvero comunicando «usando il linguaggio dell’incomunicabilità», diventa maschera nuda: come un personaggio pirandelliano si scioglie dalla forma «perché tragicamente è entrato nella vita. Non si tratta di una boutade, tanto meno della «rabdomantica sensibilità del letterato di vaglia», come scrive con rancorosa gelosia Gotor: L’affaire Moro è il punto d’arrivo di una quindicinare riflessione di Sciascia sul potere, sulle sue maschere, e sullo stesso Moro come emblematica figura di questo rapporto, che data almeno dal testo teatrale L’onorevole del 1965 fino al complesso rapporto fra Todo modo e il suo prolungamento filmico. Una riflessione, quella di Sciascia, sempre condotta sotto il duplice emblema di Pirandello e Don Chisciotte, che interseca il rapporto fra l’agrigentino e il cavaliere della Mancia, il personaggio che per primo «parla di sé in quanto personaggio, che reclama in nome della sua esistenza a volte reale e a volte letteraria, e protesta il proprio diritto a non esser trattato in un modo qualsiasi». Un movimento, quello personaggio-uomo solo-creatura, a un certo punto percorso anche da Mario Moretti, che sembra quasi riacquistare una qualche umanità nel momento in cui, procrastinando l’esecuzione del prigioniero, si dilunga in una telefonata alla famiglia di Moro che mette a rischio di intercettazione non solo lui, ma l’intero vertice della colonna romana schierato a protezione della cabina.
È nel corso di questa trattativa che Moro, per usare una pregnante lettura di Sciascia, tentando «di dire col linguaggio del nondire, di farsi capire adoperando gli stessi strumenti che aveva adottato e sperimentato per non farsi capire», ovvero comunicando «usando il linguaggio dell’incomunicabilità», diventa maschera nuda: come un personaggio pirandelliano si scioglie dalla forma «perché tragicamente è entrato nella vita. Non si tratta di una boutade, tanto meno della «rabdomantica sensibilità del letterato di vaglia», come scrive con rancorosa gelosia Gotor: L’affaire Moro è il punto d’arrivo di una quindicinare riflessione di Sciascia sul potere, sulle sue maschere, e sullo stesso Moro come emblematica figura di questo rapporto, che data almeno dal testo teatrale L’onorevole del 1965 fino al complesso rapporto fra Todo modo e il suo prolungamento filmico. Una riflessione, quella di Sciascia, sempre condotta sotto il duplice emblema di Pirandello e Don Chisciotte, che interseca il rapporto fra l’agrigentino e il cavaliere della Mancia, il personaggio che per primo «parla di sé in quanto personaggio, che reclama in nome della sua esistenza a volte reale e a volte letteraria, e protesta il proprio diritto a non esser trattato in un modo qualsiasi». Un movimento, quello personaggio-uomo solo-creatura, a un certo punto percorso anche da Mario Moretti, che sembra quasi riacquistare una qualche umanità nel momento in cui, procrastinando l’esecuzione del prigioniero, si dilunga in una telefonata alla famiglia di Moro che mette a rischio di intercettazione non solo lui, ma l’intero vertice della colonna romana schierato a protezione della cabina.
3. Una storia vestita di nero
Se non ché, mentre Moro passa dalla forma alla vita, la strategia di depotenziamento della sua figura lo riconfigura come personaggio – il Moro folle, politicamente ormai morto, inaffidabile, non più padrone di sé, al quale i suoi amici di partito oppongono un muro di silenzio mentre, decidendo di non decidere, decidono di fatto per la sua morte. Rispetto a questo movimento, le BR dimostrano la loro incapacità politica: incapaci di comprendere le dinamiche e i linguaggi dell’autonomia del politico, e dunque incapaci di insinuarsi nelle crepe del “partito della fermezza”, finiscono per essere speculari a quello Stato al quale si contrapponevano: se i dirigenti del PCI «invocarono la più rigida fermezza in nome di un’antica fede in quello Stato forte, seppur democratico, che si preparavano a edificare una volta arrivati al governo», le BR, provenienti dalla cultura statolatrica ereditata da una certa lettura – staliniana, quando non togliattiana – del leninismo, «identificavano se stesse con il nucleo duro del futuro Stato proletario». Sono due stalinismi, come intuì anche Rossanda [⇒ qui e ⇒ qui: «Sono verità sgradevoli. Non è detto che, nei momenti difficili, bisogna astenersi dal dirle»]: quello che «uccide senza processo i servitori del SIM e con processo i dirigenti», e quello «subdolo e sottile che sulle persone e sui fatti opera come sui palinsesti: raschiando quel che prima vi si leggeva e riscrivendolo per come al momento serve».
A questa considerazione di Sciascia riportata da Colombo, si potrebbe aggiungere che anche Moro, che statolatra e statista non era, nondimeno già nel 1947 definiva lo Stato «nella sua essenza, società che si svolge nella storia attuando il suo ideale di giustizia»; e concepiva nell’assorbimento all’interno dello Stato e del «regno del diritto», attraverso l’inevitabile mediazione politica, il destino delle spinte sociali alla libertà e al progresso che altrimenti sarebbero affondate nelle «sabbie mobili dell’irresponsabilità e dell’anarchia» (così nella relazione congressuale del 1959). Se c’è un tratto che accomuna Moro, il PCI e le BR, è l’inestirpabile diffidenza verso la capacità di autogoverno delle masse, la capacità produttiva dell’essere sociale, i processi di soggettivazione delle moltitudini. Assieme all’incomprensione dei processi di trasformazione sociale in corso: le letture diversamente continuistiche, fondate sulla mitologia di un ceto operaio (o popolare) – che fosse la classe che si faceva Stato, o quella fabbrichetta ch’era il logistico dell’impresa brigatista, o quella solo in apparenza indistinta “opinione pubblica” che Moro evocava a difesa della DC (con lessico diverso, Moro sapeva ben analizzare la composizione di classe dei ceti sociali, salvo oscurarla nell’inchiostro del suo linguaggio: vedi ad es. la relazione congressuale del 1962) – non coglievano le trasformazioni del tessuto produttivo come risposta a un quindicennio di lotte: prima fra tutte, l’esternalizzazione e l’allungamento delle filiere produttive sul territorio, inizio della grande deterritorializzazione produttiva che sarebbe seguita.
La monolitica lettura degli apparati di potere nella forma dello Stato Imperialista delle Multinazionali è, dopo tutto, l’esito coerente dell’appartenenza delle BR «a un assetto sociale e a una cultura politica fondati sulla centralità del lavoro»: in questo le BR avevano molto più in comune col PCI che con quel movimento che, al contrario, aveva intuito il declino della forma-partito e della sacralità dello Stato: movimento col quale le BR interagirono pochissimo, senza comprenderne alcunché. Da qui, in breve tempo, sarebbero seguiti l’imbarbarimento delle pratiche, i boia delle carceri, la sostituzione della dialettica col laccetto, il divenire-Caino. Speculare all’imbarbarimento che colse la DC: i dirigenti democristiani che avevano sacrificato Moro in nome di un’astratta fermezza venata di cinismo non esitarono a venire a patti con la camorra, regalandole la ricostruzione post-terremoto, per salvare Ciro Cirillo. L’apparente continuità della cosiddetta prima Repubblica (sostenuta da Marco Clementi) celava invece «una oligarchia sempre più priva di rapporto dialettico con la società reale, svincolata da ogni controllo da parte dei rappresentanti e di conseguenza sempre più corrotta».
4. Una storia sbagliata
 Poche ore prima dell’assassinio di Aldo Moro, a Cinisi veniva assassinato Peppino Impastato: «dalla mafia democristiana», è scritto sulla sua lapide. Mandante dell’assassinio, Gaetano Badalamenti, allora membro di quella maggioranza, all’interno della cupola mafiosa, che si identificava con la DC. La stessa espressione – mafia democristiana – compare nel comunicato brigatista n. 3, ma con un significato radicalmente diverso: dove per le BR “mafia” era un’attitudine, o un mero epiteto, per Peppino Impastato “democristiana” era un attributo che definiva e caratterizzava il soggetto. Molto di quello che è accaduto a partire da quel 9 maggio cade all’interno di questa differenza: come sempre, le parole sono conseguenza delle cose.
Poche ore prima dell’assassinio di Aldo Moro, a Cinisi veniva assassinato Peppino Impastato: «dalla mafia democristiana», è scritto sulla sua lapide. Mandante dell’assassinio, Gaetano Badalamenti, allora membro di quella maggioranza, all’interno della cupola mafiosa, che si identificava con la DC. La stessa espressione – mafia democristiana – compare nel comunicato brigatista n. 3, ma con un significato radicalmente diverso: dove per le BR “mafia” era un’attitudine, o un mero epiteto, per Peppino Impastato “democristiana” era un attributo che definiva e caratterizzava il soggetto. Molto di quello che è accaduto a partire da quel 9 maggio cade all’interno di questa differenza: come sempre, le parole sono conseguenza delle cose.
da questo testo è tratta la recensione al libro di Andrea Colombo Un affare di Stato, pubblicata sul manifesto il 9 maggio 2018