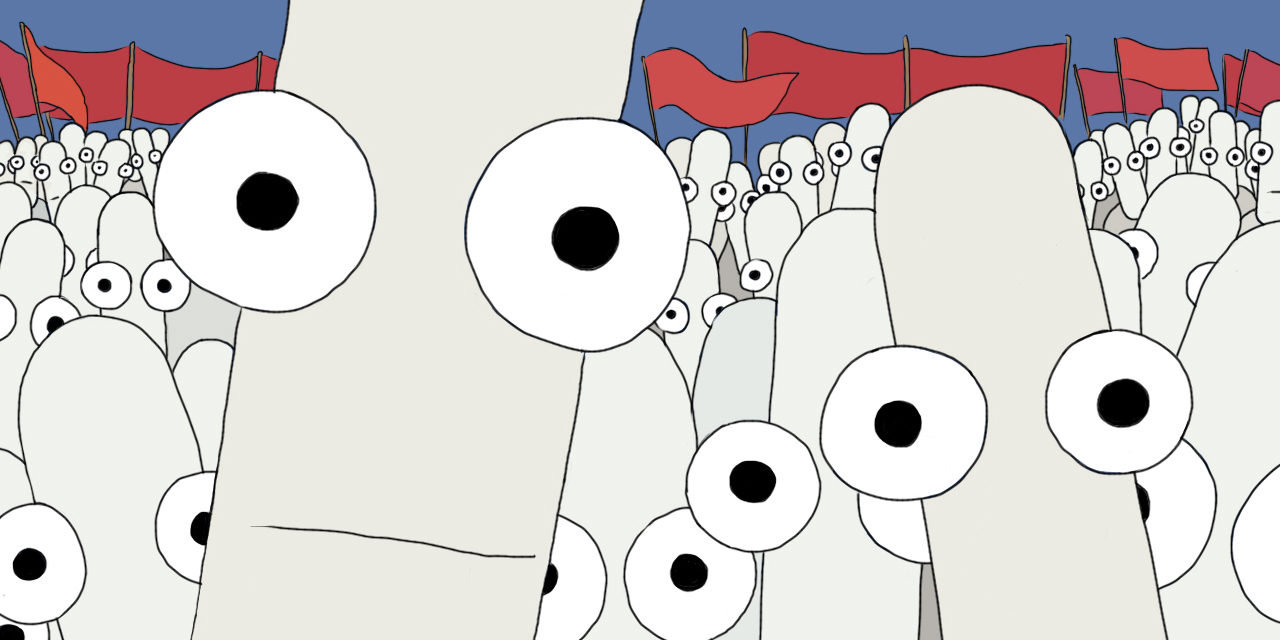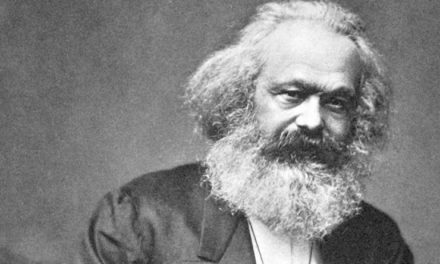di LUCA NIVARRA.
1. «Una delle differenze fondamentali tra la rivoluzione borghese e la rivoluzione socialista consiste nel fatto che per la rivoluzione borghese, che nasce dal feudalesimo, in seno al vecchio regime si creano progressivamente delle nuove organizzazioni economiche, le quali trasformano gradualmente tutti i lati della società feudale. La rivoluzione borghese aveva avanti a sé un compito solo: spezzare, gettare via, distruggere tutte le catene della vecchia società. Assolvendo questo compito, ogni rivoluzione borghese fa tutto quel che le è richiesto: essa stimola lo sviluppo del capitalismo. La rivoluzione si trova in una situazione del tutto diversa. Quanto più è arretrato il paese nel quale, in virtù degli zig-zag della storia, ha dovuto incominciare la rivoluzione socialista, tanto più per essa è difficile passare dai vecchi rapporti capitalistici ai rapporti socialisti. Ai compiti della distruzione si aggiungono qui nuovi compiti, di difficoltà inaudita, i compiti di organizzazione»1. Questo passo di Lenin, tratto da un rapporto tenuto il 7 marzo del 1918 al VII Congresso del PC(b), rappresenta, a mio avviso, un buon punto di partenza per alcune riflessioni su un tema, quello della “transizione”, tanto “inattuale” quanto, in realtà, istruttivo.
Seppur racchiusa in poche righe (ma, in realtà, si tratta di un tema che, o sotto la specie dell’alternativa “collettivizzazione/NEP” o sotto la specie dell’alternativa “socialismo in un solo paese/rivoluzione permanente” accompagnerà tutto il dibattito all’interno del partito russo fino alla svolta del ’28 e alla definitiva presa del potere da parte di Stalin), l’analisi di Lenin, in cui è possibile avvertire l’eco della drammaticità e dell’urgenza dei compiti che il gruppo dirigente bolscevico si trovò a fronteggiare all’indomani della Rivoluzione, presenta, infatti, i tratti di una specifica idea di “transizione” il confronto con la quale porta alla luce una pluralità di significati del termine, apparentati per alcuni aspetti, ma distinti sotto altri profili. L’idea di “transizione” proposta da Lenin, in realtà, è duplice e non è espressamente tematizzata ricavandosi essa, piuttosto, da quella di “rivoluzione”. Quest’ultima si è presentata, appunto, in una duplice veste: “borghese” e “socialista”. Si tratta di nomi che generalizzano, sulla base dell’esperienza storica, due diversi processi di acquisizione del potere politico (“rivoluzione” qui sta ad indicare, sostanzialmente, la conquista del monopolio della forza) da parte delle due classi sociali – la borghesia e il proletariato – che, nel corso dell’epoca moderna, hanno condotto una rivoluzione vittoriosa. Nel primo caso, la “rivoluzione” è l’atto conclusivo di un lungo processo segnato da una lenta, graduale ma inesorabile trasformazione dei rapporti economici; nel secondo caso la “rivoluzione” è l’atto iniziale di un processo che, se tutto andrà per il verso giusto, culminerà nella istaurazione di una società comunista. Si può anche dire che mentre nel primo caso, la trasformazione della struttura precede quella della sovrastruttura, nel secondo accade esattamente il contrario, ovvero il sovvertimento della sovrastruttura politico-giuridica precede quello della base economica. O, ancora, nel primo caso la “transizione” precede la “rivoluzione”, là dove, nel secondo caso, la “rivoluzione” precede la “transizione”.
Come è agevole constatare, questo ultimo schema si discosta abbastanza nettamente dal modello marxiano. Marx, infatti, sembra coltivare un’idea della “transizione” dal capitalismo al socialismo molto più vicina a quella che Lenin propone del passaggio dal feudalesimo al capitalismo che non a quella che lo stesso Lenin immaginava dovesse essere la “rivoluzione” del proletariato. Certamente è estranea a Marx una prospettiva di tipo gradualistico (avvicinabile alla concezione della presa del potere destinata ad affermarsi in seno alla II Internazionale), nel senso che per Marx la “rivoluzione”, con annesso corredo di violenza e coercizione, è inevitabile. Tuttavia, la “dittatura del proletariato”, in definitiva, per quel che poco che Marx ebbe a dire sull’argomento, si presenta più come una misura di polizia, di salute civica, che non come una prolungata guerra di posizione da ingaggiare nei confronti delle ingombranti scorie di un ordine borghese sconfitto ma non debellato. In altre parole, secondo Marx, il proletariato, proprio come la borghesia, conquisterà il potere con una “rivoluzione”, ma questo accadrà solo quando la contraddizione tra privatezza dei mezzi di produzione e socializzazione del lavoro avrà raggiunto un’intensità tale da rendere lo sbocco rivoluzionario, e la sostituzione della vecchia classe dirigente (ormai solo dominante) con la nuova, un passaggio quasi naturale. Dunque, si può dire che per Marx, a differenza di Lenin, anche nel caso del proletariato, come già in quello della borghesia, la “transizione” precede la “rivoluzione”, e le trasformazioni della struttura quelle della sovrastruttura2.
Probabilmente, l’ottimismo di Marx rispecchia, dal punto di vista ideologico, il sotterraneo operare, all’interno del suo pensiero, di un residuo di filosofia della storia; mentre, dal punto di vista storico-sociologico, esso risente di una rappresentazione dualistica del corpo sociale all’interno del quale, anche a seguito delle crisi di crescente intensità che il capitalismo era destinato ad attraversare, la classe operaia sarebbe presto diventata netta maggioranza. Date queste premesse, dovrebbe risultare abbastanza evidente la ragione per la quale la politica, nell’accezione che poi ci sarà resa familiare proprio dalla parabola tardo-ottocentesca e novecentesca dei partiti di massa, occupi qui uno spazio nell’insieme piuttosto marginale, almeno fino alla prima grande “stabilizzazione capitalistica” (quella che fa seguito al fallimento delle rivoluzioni del ’48 nelle quali Marx ed Engels, viceversa, avevano riposto grandi speranze). Il partito marxiano (la “Lega dei comunisti”) è fondamentalmente uno strumento di propaganda e di agitazione, il cui compito principale è quello di fungere da moltiplicatore della forza d’urto della classe. Siamo dunque lontanissimi dai picchi della riflessione leniniana (e gramsciana) sul partito come costruttore di egemonia attraverso il consenso, e chiamato ad operare in contesti sociali resi più complessi – rispetto allo schema semplificato caro a Marx – dalla loro arretratezza (si pensi al problema dei rapporti tra la classe operaia ed i contadini, in Russia ma anche in Italia, dove la questione agraria si intreccia con quella meridionale), o dalla loro tumultuosa evoluzione e stratificazione (si pensi alle tante pagine gramsciane dedicate all’esame del ruolo degli intellettuali, della burocrazia, dei ceti medi).
2. Volendo riassumere, si può dire che mentre in Marx, grazie al lavoro svolto ex ante dalla “transizione”, condizioni per la presa del potere da parte della classe operaia e condizioni per l’instaurazione del socialismo (in primo luogo, la collettivizzazione dei mezzi di produzione) tendono ad identificarsi, in Lenin, il quale propone un modello a “transizione” postuma, le due serie tendono a divaricarsi, lasciando un enorme spazio alla politica, nella triplice, distinta veste di costruzione dell’egemonia, di tattica rivoluzionaria e di governo della trasformazione. Un terzo modello è quello ricavabile dai Quaderni dal carcere dove la “transizione” è sì anticipata, come in Marx, individuando, però, in pari tempo, l’oggetto privilegiato della politica, anzi la specifica ragion d’essere di quel “moderno Principe” a cui Gramsci affida il compito di ingaggiare, e vincere, la lunga guerra di posizione che ormai attende la classe operaia in Occidente all’indomani della seconda stabilizzazione capitalistica.
Per quanto diversi, i primi due modelli (non sono sicuro che questo sia altrettanto vero per il modello gramsciano) condividono un elemento fondamentale rappresentato da una concezione chiusa della temporalità, dove la sequenza “transizione”/”rivoluzione” (o viceversa) individua i due momenti decisivi di un processo storico predeterminato non nell’esito, quanto nelle forme del suo svolgersi (in altri termini: non è detto che le cose vadano in un certo modo, ma se andranno in un certo modo, quest’ultimo si lascerà descrivere secondo lo schema “transizione”/”rivoluzione”). Ora, l’adozione di questa prospettiva permette di istituire una semantica della storia sulla base della quale è possibile stabilire il significato di un fatto, di un evento, di una decisione, a seconda della fase in cui essi si collocano. Ad es., il dibattito sviluppatosi negli anni ’20 in URSS a proposito della ammissibilità di un diritto della transizione ricava il suo senso proprio dalla dislocazione temporale assicuratagli da quella semantica: si potrà poi discutere se il tempo della transizione, e del correlativo diritto, sia un tempo storico, come pensavano Lenin e Stuĉka o un tempo puramente cronologico, come pensava Pašukanis e come, verosimilmente, avrebbe pensato Marx, almeno con riguardo a quella che abbiamo chiamato la “piccola transizione”, ovvero al periodo della dittatura del proletariato: ma in ogni caso la discussione verterà su un oggetto reso attingibile dal pensiero proprio attraverso l’articolazione della temporalità in sezioni connesse le une alle altre in modo non occasionale.
3. Per queste ragioni non credo che sia possibile iscrivere entro l’orizzonte della “transizione” le conquiste ottenute dalla classe operaia e, più in generale, dai ceti subalterni durante i “gloriosi Trenta”3. Una lettura di questo genere, per quanto suggestiva, nasce proprio dalla dissoluzione di quel potente dispositivo di governo della temporalità consegnatoci dalla tradizione marx-leninista e dal conseguente refluire della “transizione” dentro la longue durée delle Annales. Quello che voglio dire è che il discorso di Marx e di Lenin sulla “transizione” è sempre un discorso che assegna all’istaurazione di una società socialista lo statuto di un evento possibile (anche se non necessario) e storicamente attuale. Sconnesso da questo codice, il discorso sulla “transizione” muta completamente di senso e trasforma gli enunciati di cui esso si compone in strani ibridi epistemologici, per metà ascrivibili alla lingua dei giudizi storici e per l’altra metà a quella degli auspici politici (mentre in Marx e in Lenin, proprio a cagione della possibilità e dell’attualità del socialismo, diagnosi storica e prospettiva politica, intrecciandosi e non sovrapponendosi, mettevano capo a costrutti di senso caratterizzati da un inedito, anche se fragile, equilibrio di “descrittivo” e “prescrittivo”).
Della crisi della sinistra sono state fornite innumerevoli spiegazioni. Un’altra possibile spiegazione rinvia proprio alla perdita del governo della temporalità, alla scomparsa dall’orizzonte del pensabile della “transizione” (da intendersi come preparazione, secondo la lectio marxiana, come costruzione, secondo la lectio leniniana) ad un ordine socio-economico radicalmente diverso da quello capitalistico. Smarrito questo architrave, all’ombra del quale, è bene non dimenticarlo, lo stesso ciclo welfarista si è consumato, la “sinistra”, quando non ad una mera oscillazione cromatica della destra (come nel caso dei vari socialismi europei), degrada a spazio del discorso pubblico convenzionalmente occupato da una generica denuncia della crescente diseguaglianza economica e dei suoi costi. Una gigantesca regressione che, in un certo modo, rappresenta l’altra faccia della straripante egemonia neoliberista per sfidare la quale, viceversa, sarebbe necessario ripristinare la pensabilità e l’attualità del binomio “transizione/rivoluzione”. Si può dire, in altri termini, che ad essere venuta meno, insieme a molte altre cose, tra cui lo stato nazionale, è la “prospettiva” della rivoluzione, schiacciata dall’azione congiunta del tempo unico del pensiero unico e dal (giusto) ripudio di un’idea della storia come sviluppo lineare e progressivo. Il “progresso” neoliberale, infatti, è un progresso statico, in cui le variazioni si danno solo all’interno di un paradigma ossificato e immutabile il quale, nella sostanza, ripete sempre sé stesso, non contemplandosi neppure la possibilità di una rottura; mentre, dal canto suo, chi all’ordine costituito si oppone, stenta a riconoscersi come un (almeno potenziale) soggetto unitario anche (non solo, ma anche) perché non riesce a dislocare la propria prassi dentro uno spazio storico in cui il tempo non si esaurisca in una successione puramente cronologica. Restituire un senso al tempo senza ricadere nella trappola della Geschichtsphilosophie rappresenta uno dei presupposti richiesti affinché il discorso sulla rivoluzione non resti prigioniero del solo vocabolario dell’utopia.
W. I. LENIN, Rapporto sulla guerra e sulla pace, in Opere complete, vol. XXVII, Roma, 1967, 73 s. ↩
Il modello marxiano può essere ulteriormente complicato distinguendo una “grande transizione” e una “piccola transizione”. La prima è la “transizione” di cui abbiamo parlato sin qui e che, sostanzialmente, si identifica con il processo storico di lunga durata; la seconda, invece, si identifica con il complesso di misure da adottarsi all’indomani della “rivoluzione” e finalizzate a consolidare il potere operaio (la “dittatura del proletariato”, appunto). Volendo andare oltre, si può osservare come in Marx, oltre alla “grande transizione” prerivoluzionaria e alla “piccola transizione” postrivoluzionaria, sia presente anche una “transizione” endorivoluzionaria, che è quella di cui si parla nella “Critica del Programma di Gotha” a proposito del passaggio dal socialismo al comunismo. ↩
M.BARCELLONA, Sulla teoria marxista del diritto e dello stato. La sinistra e la società “a venire”, in Democrazia e diritto, 2016, 13 s. ↩