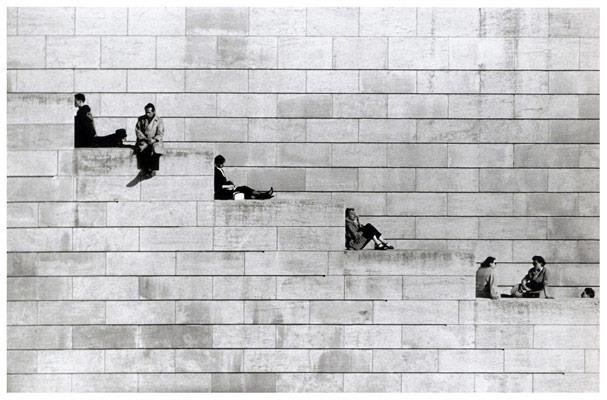di GISO AMENDOLA.
1. Una interpretazione non luttuosa della crisi
Nel recente passato, la nostra riflessione collettiva ha ottenuto qualche risultato analitico non disprezzabile nel cartografare i processi di trasformazione costituzionale. Abbiamo saputo guardare dentro i processi di decostituzionalizzazione, dentro la perdita di forza formativa e normativa della mediazione costituzionale del Novecento, e, allo stesso tempo, indagare le pratiche, gli usi, gli esperimenti che si fanno largo all’interno di quei processi. Di certo, non abbiamo inventato noi la critica del diritto: forse, però, siamo riusciti a non infilarci nella ampia schiera di chi ha fatto della meditazione infinita sulla “fine del diritto” una sorta di ultimo rifugio per celebrare malinconicamente la perduta autonomia del diritto e dei giuristi, proprio nello stesso momento in cui se ne proclama la crisi. Abbiamo preferito – per usare una bella espressione che il collettivo Smaschieramenti, nel suo intervento, ci ha ricordato, estraendola dalla genealogia delle lotte queer – esercitare, piuttosto che il mestiere di custodi del rimpianto, una sana “arte del fallimento” (Smaschieramenti, 2013). Anche perché di quelle tradizioni di cui si canta continuamente la fine, ricordiamo più le infamie che i fasti. In modo piuttosto brutale: la tradizione del diritto pubblico, al cui esaurimento guardano i mille discorsi sulla fine del diritto e sulla decostituzionalizzazione, è stata la matrice tenace di quella costante riduzione all’Uno, all’unità sovrana, di cui la scienza giuridica si è fatta a lungo custode; mentre, dentro il diritto privato, pur storicamente meno influenzato dal dogma statualistico, si è costruita la centralità della proprietà nell’esperienza giuridica moderna.
Piuttosto che chiosare all’infinito l’esaurirsi di queste tradizioni, sarebbe necessario, una buona volta, prendere atto che i processi di decostituzionalizzazione hanno evidenziato definitivamente l’impossibilità di difendere qualsiasi “metodo giuridico” come ultima cittadella fortificata. Ci siamo confrontati utilmente con chi – per esempio, “postfunzionalisti” come Gunther Teubner – ha condiviso con noi sia la diagnosi sull’esaurimento delle geometrie costituzionali della modernità, sia la sana attitudine al rifiuto del rimpianto (Chignola, 2012). Ma dentro quei processi, abbiamo provato a vedere qualcosa d’altro che la possibilità di una qualche nuova possibile regolazione dei rapporti reciproci tra sistemi sociali. Non ci siamo posti il problema di ridare il “giusto” posto al diritto, di “limitare” la voracità del sistema economico, di restituire un seppur riformato e ben temprato scettro al sistema politico. Sia perché l’intensità della trasformazione del capitalismo finanziario ci costringe evidentemente a prendere congedo non solo dalle mediazioni classiche del welfare statuale, ma anche da ogni illusione di poter in qualche modo amministrare la crisi con una più o meno innovativa azione di risistemazione dei confini; sia, soprattutto, perché indaghiamo i dispositivi giuridico-amministrativi sempre tenendo fermo un punto, davvero poco praticato dai giuristi, anche quelli più avvertiti e sensibili alle trasformazioni del postmoderno: che ogni dispositivo normativo funziona, incide, mette in forma, produce ed è prodotto da trasformazioni della soggettività.
La crisi degli ordini costituzionali , la crisi della mediazione welfarisitica, è incomprensibile senza affondare lo sguardo nella crisi e trasformazione della crisi delle figure soggettive che la sorreggevano. Ma allora, proprio in virtù di questa scelta di metodo, dentro quelle trasformazioni soggettive, abbiamo potuto sempre individuare dispositivi di produzione in grado, potenzialmente, di rovesciare il senso degli stessi processi di decostituzionalizzazione, di spingere la nostra ricerca oltre la diagnostica del frammento o l’ingegneria della crisi. Da questo sguardo materialmente impiantato nelle trasformazioni soggettive, la crisi del costituzionalismo classico non ci è mai apparsa semplicemente crisi degli antichi ordini, ma anche tensione e occasione per leggere nuove sperimentazioni, nuove combinazioni, nuovi concatenamenti. Nuove macchinazioni. E proprio in quelle trasformazioni soggettive così spesso esorcizzate dalla scienza giuridica (ma non sempre: qualche interlocutore quantomeno sul piano della registrazione delle radicali trasformazioni della soggettività, comincia a spuntare anche nel campo dei giuristi!), si radica la ricerca sulle istituzioni del comune, su un nuovo e diverso welfare, oltre la crisi radicale e le sinistre nostalgie per le antiche mediazioni e le figure soggettive che reggevano il welfare burocratico e centralizzato degli stati nazionali. Solo questo metodo, che piega l’analisi oggettiva delle trasformazioni dei dispositivi all’impianto soggettivo che le anima, ci può permettere di affrontare i processi di decostituzionalizzazione, il mare del “post-moderno” della crisi del diritto, senza trasformarci in mistici della Fine o in cinici amministratori del Frammento.
2. Della costituzione
Vediamo allora di proporre, animati dall’attenzione alle trasformazioni delle soggettività e dal rifiuto delle interpretazioni luttuose della crisi, qualche problema di fondo che la nostra discussione deve necessariamente affrontare. In primo luogo, come stare dentro le trasformazioni della “costituzione” europea e delle costituzioni nazionali. Il quadro contemporaneo di queste trasformazioni rende molto esplicite alcune linee di tendenza radicate in una durata piuttosto lunga, ma alle quali la crisi ha impresso un’accelerazione radicale. Il dibattito italiano sulla riforma della costituzione ha forse il merito di rendere tutto questo piuttosto esplicito, grazie anche alla sua buona dose di rozzezza. L’imposizione degli adeguamenti della carta costituzionale alle necessità del comando finanziario della crisi segue con monotona precisione, infatti, strade già ampiamente tracciate nei processi sovranazionali: accentramento degli equilibri costituzionali sulle funzioni esecutive, risposta alla crisi della rappresentanza attraverso forme di governo semipresidenziale o presidenziale, costituzionalizzazione sempre più stringente dei vincoli di bilancio, “autonomia” del governo della moneta e così via. L’antico “conservatorismo” costituzionale di una parte della sinistra non ha impiegato troppo tempo a convertirsi al nuovo riformismo internazionale delle nostrane larghe intese: sono tendenze, in fondo, che non da oggi la socialdemocrazia europea concepisce come inevitabili. Piuttosto, a fare un qualche attrito contro questo nuovo attivismo “riformatore”, permane una certa “forza simbolica” delle carte costituzionali nazionali (Marella, 2013), a cominciare da quella italiana: ne è testimonianza – comprensibilissima – la ripresa di mobilitazione sul tema della “difesa della costituzione”, che vede coinvolti ampi settori, per esempio, dei movimenti dei beni comuni. Ma s’affaccia qui la questione cruciale dei piani, dei luoghi, dei soggetti, entro cui una resistenza produttiva a queste trasformazioni può radicarsi, ed avere possibilità di una risposta all’altezza della sfida di questo neoriformismo costituzionale. In primo luogo, e riprendo ancora un’espressione di Maria Rosaria Marella: la “soggettivazione attraverso il lavoro” , l’architrave della mediazione costituzionale classica, si è esaurita. Nessuna opposizione alla “rivoluzione dall’alto” costituzionale può eludere questo piano: allo smantellamento del disegno costituzionale tradizionale, non è pensabile opporre una resistenza che non faccia profondamente i conti con l’esaurirsi di quell’idea di cittadinanza, modellata sul nesso cittadino/lavoratore/maschio/eterosessuale, che fondava non poco della “forza normativa” del costituzionalismo tradizionale, e che è stata completamente spiazzata innanzitutto dalle lotte che, dagli anni Sessanta in poi, hanno fatto emergere un’eterogeneità soggettiva radicalmente irriducibile a quella figura di “cittadino”. L’opposizione al neoriformismo costituzionale può avere qualche senso, e qualche forza, solo se si radica, in modo radicalmente indissolubile, dentro la battaglia per un nuovo welfare, che rielabori una sua effettiva “universalità”, finalmente all’altezza di quella ricchezza di differenze e singolarità. Altrimenti, nessuna difesa della costituzione può sperare di convocare a sé soggettività che già affrontano, nella loro esistenza quotidiana, lotte di resistenza contro dispositivi di assoggettamento e di messa al lavoro radicate su un piano completamente altro rispetto alla mediazione costituzionale classica. Inoltre, se quella mediazione ci lascia indifesi – per quanto ci si possa mobilitare “simbolicamente” a sua difesa – sul piano dei soggetti, allo stesso modo è spiazzata sul piano degli spazi, dei confini entro i quali una resistenza al neoriformismo costituzionale potrebbe essere pensabile. Davanti agli effetti della “rivoluzione dall’alto”, si alzano da più parti voci che – reagendo alla dimensione evidentemente sovranazionale di quei processi – immaginano la praticabilità del piano nazionale come piano di ricostruzione di meccanismi democratici (ad esempio, di recente, Streek, 2013). Eppure, nei processi di riscrittura degli equilibri costituzionali, sono proprio le costituzioni nazionali a risultare, non da ora, già sottoposte a un rilevante svuotamento di senso, all’interno di una radicale trasformazione di spazi e di confini. Nessuna riattivazione di spazi democratici è immaginabile a partire dall’idea che la crisi delle rappresentanze nazionali sia l’effetto dell’attacco della “rivoluzione dall’alto”, e non piuttosto il campo già dissestato su cui quella “rivoluzione” muove la sua paradossale capacità costituente. Semmai, lo scetticismo di molti sulla possibilità effettiva di un nuovo costituzionalismo sovranazionale, andrebbe ricondotto al problema di fondo: la capacità di incidere, immaginare, produrre processi europei di riappropriazione democratica si gioca sull’essere consapevoli, fino in fondo, che il nuovo spazio nel quale questi processi potrebbero darsi non è uno spazio già dato e predefinito, non è un presupposto, come poteva essere il territorio per l’antica dottrina del diritto pubblico statuale. Uno spazio europeo eventualmente “praticabile” per l’invenzione di processi, campagne, azioni con intenzione e portata costituente è esso stesso un prodotto, la creazione di una possibile azione costituente, della capacità o meno delle lotte di uscire dalla nostalgia, rassicurante ma perdente, degli antichi confini e di giocare la scommessa politica della loro generalizzazione.
3. Politica è riappropriazione del welfare
 L’avversario, al solito, può insegnare molto se lo si affronta nei suoi punti di forza. E la forza del neoliberalismo è che ha investito a fondo sulla produzione di soggettività, sapendo gestire, e anche captare attivamente, l’impossibilità di una gestione centralizzata e omogeneizzante di usi e pratiche. Si è ampiamente nutrito di soggettività mobili e indisciplinate, ricatturandole poi attraverso le modalità feroci di rigerarchizzazione e selezione che ben conosciamo, e non disdegnando di tornare a utilizzare, nei nuovi contesti, anche gli antichi attrezzi “disciplinari” e identitari quando potevano venire utili: a cominciare dalla mai tramontata esaltazione dei valori della famiglia, dai rinnovati dispositivi di razzializzazione e genderizzazione, dagli antichi mostri della Patria e della Nazione. Ma, proprio ora che la crisi non produce altra via d’uscita che la prosecuzione autoritaria del neoliberalismo stesso, si apre la possibilità di far un buon uso sovversivo dello stesso fallimento del welfare. Le lotte più innovative degli ultimi anni si collocano, non a caso, sul terreno degli esperimenti di riappropriazione democratica del welfare: persino quando sembrano parlare il linguaggio della nostalgia del “pubblico”, nei fatti sono animate da una tensione all’autogestione e all’autorganizzazione che mostra come il terreno della centralizzazione burocratica del welfare sia oramai non solo impraticabile, ma anche compiutamente detestato. D’altra parte, queste nuove lotte sono sempre meno accostabili alle classiche “lotte sui servizi”, in quanto si collocano sempre più decisamente in una prospettiva che toglie qualsiasi possibilità di confinarle entro ambiti “settoriali”. Quando si estrae valore dalla finanziarizzazione del welfare, e l’intera produttività delle soggettività è convogliata dentro i meccanismi di credito/debito, le “lotte sui servizi” non sono solo più la prosecuzione della lotta sul salario, seppure allargata all’intera fabbrica sociale, ma compiono un vero e proprio salto intensivo: probabilmente, finiscono per essere la forma dell’unica azione politica concretamente praticabile nell’epoca della precarizzazione generalizzata, l’unico spazio politico che si apre all’interno dei dispositivi della compiuta sussunzione reale. La forma attuale della sussunzione reale, infatti, non offre altra possibilità di sganciamento di ritmi e tempi di vita, nessuna altra possibilità praticabile di rifiuto dei dispositivi di assoggettamento, oramai estesi dal “lavoro” a tutta la vita in quanto produttiva, che non si collochi dentro strategie di riappropriazione del welfare. Le soggettività precarie, nel frattempo, hanno incorporato in sé potenzialità di autorganizzazione molto forti, le stesse, in fondo, di cui ha continuamente ha saputo nutrirsi il neoliberalismo. Ed esercitano continuamente, in modalità più o meno esplicite, più o meno organizzate, tentativi di fuga, di sottrazione, o di rottura nei confronti dei dispositivi proprietari che tendono a rinchiudere quelle potenzialità, ad appropriarsene con la continua pressione per rimodellare, rimettere in riga, selezionare le soggettività. Così, l’esercizio di pratiche destituenti sta insieme necessariamente a un altrettanto continuo tentativo di riappropriazione di beni e servizi. In questo senso, per esempio, le lotte sui beni comuni, quando si sono tradotte nelle lotte delle soggettività precarie metropolitane, hanno immediatamente reso esplicita quella tendenza alla rottura con gli equilibri proprietari “costituzionali” che il tema dei beni comuni porta in sé comunque “implicitamente” (Nivarra, 2013). Di conseguenza, la riappropriazione del welfare non è più semplicemente una delle possibili armi della lotta politica, uno tra i tanti punti di un eventuale programma: ma è la forma della possibilità stessa del darsi di una politica oggi. E, per converso, molte esperienze precarie hanno una forza e una carica politica che l’occhio allenato alle lotte “politiche” tradizionali non è in grado di scorgere, e rischia magari di trascurare come irrimediabilmente impolitiche. Chi vuole oggi porsi il problema della politica, deve imparare che preziosi atti di sabotaggio e di riappropriazione si trovano in forme, modi, esperimenti completamente eterogenei, e per nulla assimilabili a quelli posti in essere del lavoratore/cittadino. Per questo, dentro le lotte delle soggettività precarie, è diventato progressivamente indistinguibile il piano del mutualismo dal piano dell’organizzazione politica: sovrapposizione di certo non esente da rischi, per la facilità con cui il mutualismo può essere agganciato e riassorbito nelle strategie neoliberali della sussidiarietà e dell’amministrazione neutralizzante delle stesse forme di autorganizzazione. Ma, per la riflessione sui possibili “modi di far politica”, questo dato va egualmente assunto fino in fondo. Non c’è, da un lato, il problema “strutturale” del costruire organizzazione politica, e dall’altro, l’obiettivo “programmatico” di costruire un welfare finalmente adeguato a soggettività non uniformate, non disciplinabili, a differenze ricche di capacità produttive, innovative, autonome: organizzazione politica, riappropriazione dei servizi, invenzione del welfare del comune, sono, ora, un solo, indissolubile movimento. Quel che questo significa sulle modalità di conduzione delle lotte, sul senso della militanza “politica”, sul nesso stesso tra militanza e vita, siamo forse in grado per ora solo di intuirlo, ma è, probabilmente, il passaggio cruciale per riuscire a passare dalle “lotte per i servizi” alla sperimentazione di una politica del comune.
L’avversario, al solito, può insegnare molto se lo si affronta nei suoi punti di forza. E la forza del neoliberalismo è che ha investito a fondo sulla produzione di soggettività, sapendo gestire, e anche captare attivamente, l’impossibilità di una gestione centralizzata e omogeneizzante di usi e pratiche. Si è ampiamente nutrito di soggettività mobili e indisciplinate, ricatturandole poi attraverso le modalità feroci di rigerarchizzazione e selezione che ben conosciamo, e non disdegnando di tornare a utilizzare, nei nuovi contesti, anche gli antichi attrezzi “disciplinari” e identitari quando potevano venire utili: a cominciare dalla mai tramontata esaltazione dei valori della famiglia, dai rinnovati dispositivi di razzializzazione e genderizzazione, dagli antichi mostri della Patria e della Nazione. Ma, proprio ora che la crisi non produce altra via d’uscita che la prosecuzione autoritaria del neoliberalismo stesso, si apre la possibilità di far un buon uso sovversivo dello stesso fallimento del welfare. Le lotte più innovative degli ultimi anni si collocano, non a caso, sul terreno degli esperimenti di riappropriazione democratica del welfare: persino quando sembrano parlare il linguaggio della nostalgia del “pubblico”, nei fatti sono animate da una tensione all’autogestione e all’autorganizzazione che mostra come il terreno della centralizzazione burocratica del welfare sia oramai non solo impraticabile, ma anche compiutamente detestato. D’altra parte, queste nuove lotte sono sempre meno accostabili alle classiche “lotte sui servizi”, in quanto si collocano sempre più decisamente in una prospettiva che toglie qualsiasi possibilità di confinarle entro ambiti “settoriali”. Quando si estrae valore dalla finanziarizzazione del welfare, e l’intera produttività delle soggettività è convogliata dentro i meccanismi di credito/debito, le “lotte sui servizi” non sono solo più la prosecuzione della lotta sul salario, seppure allargata all’intera fabbrica sociale, ma compiono un vero e proprio salto intensivo: probabilmente, finiscono per essere la forma dell’unica azione politica concretamente praticabile nell’epoca della precarizzazione generalizzata, l’unico spazio politico che si apre all’interno dei dispositivi della compiuta sussunzione reale. La forma attuale della sussunzione reale, infatti, non offre altra possibilità di sganciamento di ritmi e tempi di vita, nessuna altra possibilità praticabile di rifiuto dei dispositivi di assoggettamento, oramai estesi dal “lavoro” a tutta la vita in quanto produttiva, che non si collochi dentro strategie di riappropriazione del welfare. Le soggettività precarie, nel frattempo, hanno incorporato in sé potenzialità di autorganizzazione molto forti, le stesse, in fondo, di cui ha continuamente ha saputo nutrirsi il neoliberalismo. Ed esercitano continuamente, in modalità più o meno esplicite, più o meno organizzate, tentativi di fuga, di sottrazione, o di rottura nei confronti dei dispositivi proprietari che tendono a rinchiudere quelle potenzialità, ad appropriarsene con la continua pressione per rimodellare, rimettere in riga, selezionare le soggettività. Così, l’esercizio di pratiche destituenti sta insieme necessariamente a un altrettanto continuo tentativo di riappropriazione di beni e servizi. In questo senso, per esempio, le lotte sui beni comuni, quando si sono tradotte nelle lotte delle soggettività precarie metropolitane, hanno immediatamente reso esplicita quella tendenza alla rottura con gli equilibri proprietari “costituzionali” che il tema dei beni comuni porta in sé comunque “implicitamente” (Nivarra, 2013). Di conseguenza, la riappropriazione del welfare non è più semplicemente una delle possibili armi della lotta politica, uno tra i tanti punti di un eventuale programma: ma è la forma della possibilità stessa del darsi di una politica oggi. E, per converso, molte esperienze precarie hanno una forza e una carica politica che l’occhio allenato alle lotte “politiche” tradizionali non è in grado di scorgere, e rischia magari di trascurare come irrimediabilmente impolitiche. Chi vuole oggi porsi il problema della politica, deve imparare che preziosi atti di sabotaggio e di riappropriazione si trovano in forme, modi, esperimenti completamente eterogenei, e per nulla assimilabili a quelli posti in essere del lavoratore/cittadino. Per questo, dentro le lotte delle soggettività precarie, è diventato progressivamente indistinguibile il piano del mutualismo dal piano dell’organizzazione politica: sovrapposizione di certo non esente da rischi, per la facilità con cui il mutualismo può essere agganciato e riassorbito nelle strategie neoliberali della sussidiarietà e dell’amministrazione neutralizzante delle stesse forme di autorganizzazione. Ma, per la riflessione sui possibili “modi di far politica”, questo dato va egualmente assunto fino in fondo. Non c’è, da un lato, il problema “strutturale” del costruire organizzazione politica, e dall’altro, l’obiettivo “programmatico” di costruire un welfare finalmente adeguato a soggettività non uniformate, non disciplinabili, a differenze ricche di capacità produttive, innovative, autonome: organizzazione politica, riappropriazione dei servizi, invenzione del welfare del comune, sono, ora, un solo, indissolubile movimento. Quel che questo significa sulle modalità di conduzione delle lotte, sul senso della militanza “politica”, sul nesso stesso tra militanza e vita, siamo forse in grado per ora solo di intuirlo, ma è, probabilmente, il passaggio cruciale per riuscire a passare dalle “lotte per i servizi” alla sperimentazione di una politica del comune.
4. Diritti, usi e produzione di soggettività
La riflessione giuridica tradizionale è evidentemente in estrema difficoltà in questi passaggi. Pure, grazie alle spinte del movimento dei beni comuni, abbiamo avuto negli ultimi anni spunti e innovazioni preziose. Che però bisognerà installare all’altezza di quella trasformazione complessiva che può condurci a una complessiva politica per il comune. Prezioso, per esempio, è stato in questi anni il ritorno di attenzione ai problemi e alle risorse degli usi, a lungo schiacciati dalle tradizioni formalistiche imperanti. Ma che senso può avere oggi il richiamo all’uso? E’ evidente che quando i giuristi ritornano alla riflessione sugli usi, poco possono trovare di utile nell’oggettivismo che segnava i richiami tradizionali alle consuetudini. Il ritorno degli usi, oggi, sta esattamente dentro l’impossibilità di contenere dentro la mediazione statuale e classicamente welfaristica la ricchezza potenziale delle pratiche messe in moto dalle soggettività ricche e dense delle nostre metropoli. Usi e pratiche, certo, forzano l’antico disegno astrattamente normativo, proprio come il welfare del comune prova a irrompere nella crisi del welfare centralizzato e organizzato “pubblicisticamente”. Con qualche ironia, potremmo dire che, se l’attenzione tradizionale dei giuristi si rivolgeva agli usi in una dimensione temporale segnata dal passato, e custodita dalla consuetudine, qui l’unica consuetudine di cui queste soggettività fanno continua mostra è, al contrario, quella all’invenzione, alla trasformazione del presente, all’immaginazione delle possibilità aperte. E l’uso di cui parliamo non ha più nulla di oggettivabile: gli usi non sono altro che le pratiche di liberazione dagli assoggettamenti e di costruzione di nuove macchine soggettive. E’ in questo senso che abbiamo insistito, qualche volta, sul non rinchiudere il discorso dei beni comuni all’interno di una semantica dei “beni”, ma aprirlo al comune (al singolare) inteso come attività, cooperazione sociale, produzione di affetti, di linguaggi, di socialità (Baronian-Vercellone, 2013). Lo stesso alfabeto dei diritti attraversa questo processo di soggettivazione. Conserverà il nostro welfare il linguaggio dei diritti, la sua universalità? Più che in un’oziosa discussione, tutta astratta, tra universalismo dei diritti e particolarismo delle differenze, la questione sta dentro la produzione di quest’universalità. Che non si costituisce per nulla sul calco dell’immagine presupposta del “soggetto”, del “titolare” dei diritti: è l’intero linguaggio dei diritti fondamentali, invece, che è riscritto – nello stesso movimento di produzione delle istituzioni del comune – dentro la nuova produzione di soggettività. La forza esemplare che oggi assume la centralità del reddito di base sta esattamente qui: non solo nel suo aspetto strettamente rivendicativo, e retributivo, di riappropriazione del valore prodotto ed estorto, ma soprattutto per il modo in cui, all’interno del reclamare reddito, si intrecciano indissolubilmente i piani dell’universalità (diritto universale al reddito) e dell’incondizionatezza (diritto a vivere “senza condizioni”, a esprimere tutto il proprio potenziale attraverso la liberazione dai dispositivi di cattura della propria soggettività, diritto, in fondo, a vivere senza modellarsi sui modi, tempi e ritmi della vita personale trasformata in impresa). L’universalità del reddito – quale universalità della liberazione dai condizionamenti, della riaffermazione, in tutta la sua materialistica consistenza, dell’irrinunciabilità della libertà – è in fondo anche l’esempio migliore dell’universalismo, materialissimo e situato, del welfare del comune. Un welfare pienamente della persona, della singolarità e della differenza, che rompe lo scambio “sovrano” tra riconoscimento del proprio essere “buon cittadino” – patriota, buon padre di famiglia, onesto lavoratore, e, semmai, madre amorevole – su cui si fondava il welfare centralistico e che, allo stesso tempo, rende possibile la resistenza nei confronti dei nuovi dispositivi di assoggettamento, che tendono a trasformare in impresa la vita stessa. Un welfare che non proclama titolari astratti di diritti astrattamente fondamentali, ma che riporta tanto il tema dei diritti che quello della titolarità alla concretezza del continuo prodursi di soggettività, al continuo sviluppo, potenziarsi e modificarsi delle potenzialità soggettive. Diventa necessaria, alla luce dei possibili esperimenti di riappropriazione democratica della salute, della formazione, dei trasporti, dell’ambiente, una vera e propria riscrittura del contenuto dei diritti fondamentali alla luce della loro “titolarità” non più individuale, né collettiva, ma comune, e del loro esercizio pienamente democratico. Ancora una volta, dentro le nostre metropoli, oltre il vecchio nesso contrattuale tra prestazione e servizi, tra soggetto “titolare” e “riconoscimento” dei suoi diritti, avviene quello che ben sapeva Spinoza: che i diritti del comune sono uguali alla ricchezza della potenza che sanno esprimere le singolarità che quel comune compongono. A noi far vivere questa capacità di unire composizione delle soggettività e diritti dentro progetti di riappropriazione ed autorganizzazione dei servizi dove i diritti non siano più né negati, né “erogati”, ma prodotti dentro una nuova, democratica, “amministrazione” del comune.
Riferimenti
Laurent Baronian – Carlo Vercellone, Moneta del comune e reddito sociale garantito, in uscita per “Terrains/Théories”, autunno 2013.
Sandro Chignola, a cura di, Il diritto del comune, ombre corte, Verona, 2012.
Maria Rosaria Marella, 2013, Pratiche del comune. Per una nuova idea di cittadinanza, in “Lettera internazionale” [qui].
Luca Nivarra, 2013, I beni comuni uni e trini e il capitalismo proprietario.
Laboratorio Smaschieramenti, Spunti di riflessione dalle reti transfemministe/queer.
Wolfgang Streek, Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo democratico, tr. it. Feltrinelli, Milano 2013.