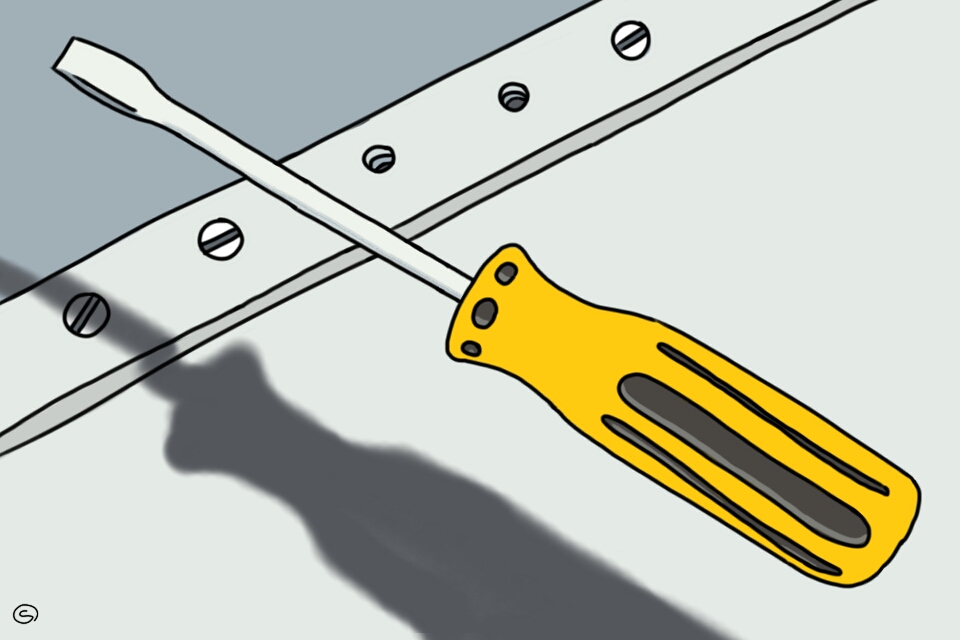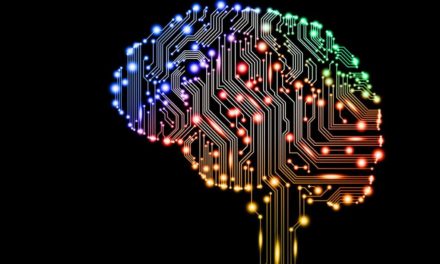Segnaliamo l’intervista di Tania Rispoli a Michael Hardt. Il video dell’incontro di giovedì 18 giugno di Atlas of Transitions può essere visto qui: https://www.facebook.com/dinamopress/videos/694958334399412/
Di TANIA RISPOLI e MICHAEL HARDT
Negli ultimi due anni Atlas of Transitions ha portato avanti una riflessione molto interessante sulle migrazioni e sul paradigma del confine nell’immaginario contemporaneo. Il tema di quest’anno è Performing Resistance e tu e Sandro Mezzadra oggi pomeriggio all’interno delle iniziative di Atlas of Transitions parlerete di una delle esperienze più significative di resistenze degli ultimi anni: Mediterranea. Proprio in questi giorni la nave Mare Jonio riprende le proprie attività nel Mediterraneo, dopo il sequestro dello scorso 3 settembre 2019 per via dei decreti sicurezza. Nel frattempo i naufragi di migranti continuano così come gli accordi tra i paesi europei e la Libia. Come vedi il ruolo di Mediterranea nella fase attuale?
Credo che il progetto di Mediterranea sia molto cambiato in questi due anni, non tanto per il progetto in sé, i cui obiettivi rimangono quelli di salvare i migranti in mare e intervenire sulle politiche genocide degli accordi Italia-Libia, quanto per il contesto. Quasi due anni fa quando si è cominciato il percorso, Mediterranea era un progetto controcorrente, non perché non ci fossero, in Italia, molte persone favorevoli a soccorrere i migranti in mare ma perché il contesto politico istituzionale, soprattutto con Matteo Salvini e la sua retorica governativa, rendevano un progetto di questo tipo se non irrealizzabile, quasi impossibile. Quando si è lanciata in mare la nave Mare Jonio, l’idea di effettuare dei salvataggi di migranti costitutiva una vera e propria sfida rispetto alla retorica politica dominante. Il contesto, oggi, mi sembra cambiato, in particolare nelle ultime settimane, nel momento in cui si punta più decisamente su una politica anti-razzista dei movimenti e su una società che faccia dell’anti-razzismo uno dei suoi obiettivi principali. Se all’inizio Mediterranea ha dimostrato che malgrado la situazione politica orribile si può comunque fare qualcosa – se quindi ci ha dimostrato che è pur sempre possibile resistere – oggi, invece, il suo ruolo è quello di accelerare una serie di processi. Mediterranea può favorire delle forme di resistenza e dei movimenti che stanno di settimana in settimana sempre più crescendo, e questo sia in Europa che negli Stati Uniti. Il ruolo di Mediterranea, in conclusione, si sta quindi adeguando a questo nuovo e potente contesto.

Quello che sta succedendo nelle ultime settimane negli Stati Uniti è eccezionale, assume delle proporzioni enormi e sembra che stia completamente riconfigurando la fase attuale. Come giudichi questo movimento e di che tipo di novità ti sembra essere portatore?
Una delle novità che osservo è che questo movimento ha una coscienza politica molto più profonda rispetto ai movimenti degli ultimi anni su alcune questioni, come per esempio il tema e il metodo dell’intersezionalità. Ma più in generale questo movimento ha una coscienza politica molto più matura. Questa “maturità” può essere intesa in due sensi: da un lato questo movimento è un movimento contro le strutture razziali che è anche molto consapevole delle gerarchie di genere e sessualità e include appieno le istanze dei movimenti trans-femministi (come è avvenuto nella grande manifestazione a NYC di domenica scorsa) – e in questa prospettiva è un movimento che ha piena coscienza dei legami trasversali delle lotte. Dall’altro lato, è un movimento che non è solamente cosciente del fenomeno della violenza ma inquadra questa violenza nella problematizzazione di strutture sociali più ampie e radicate. È evidente che la scintilla di queste proteste e di questo movimento è stato un atto violento della polizia, cioè il brutale omicidio di George Floyd, ma per il movimento è altrettanto chiaro che questa violenza è un epifenomeno e un sintomo di un problema ancora più fondamentale che è la struttura sociale razzista della società americana (e non solo). Ecco, questo mi sembra un formidabile segno di maturità del movimento. Inoltre, si potrebbe dire che anche la retorica, il linguaggio e l’immaginario degli attivisti, che in generale sono molto giovani e hanno 20-25 anni, sia molto prossimo a un tipo di discorso che spesso viene anche portato avanti nelle aule universitarie e che propone un’analisi strutturale del razzismo. Questo movimento utilizza un linguaggio e delle richieste che sono molto sofisticate ed elaborate.
Alcuni analisti sostengono che ci siano anche dei conflitti intra-governativi in questo momento negli Stati Uniti che favoriscono o sostengono i movimenti. Tu che ne pensi?
Indubbiamente in alcune aree c’è un rapporto virtuoso tra manifestazioni e governi locali che si oppongono fortemente alle politiche di Trump. Per esempio sia a Seattle che a Washington – le due città in cui ho anche partecipato attivamente alle manifestazioni – i sindaci hanno dato l’ordine alla polizia di non opporsi alle manifestazioni. A Washington durante l’ultima enorme manifestazione non si vedeva neppure un poliziotto ma a presidiare la Casa Bianca c’era la Guardia Nazionale… I sindaci sia a Washington che a Seattle stanno quindi sostenendo le manifestazioni contro Trump. Bisogna vedere se questo rappresenti un vero e proprio conflitto tra governi locali e Stato federale…
Anche perché spesso storicamente è stato il contrario, cioè gli Stati singoli prendevano delle posizioni più conservatrici mentre il governo federale proponeva delle decisioni più avanzate…
Sì, questo è quello che si diceva a metà degli anni Sessanta ed era grossomodo vero soprattutto per quanto riguardava gli Stati del Sud che non volevano porre termine alla segregazione mentre il governo federale, invece, forzava. Quella attuale costituisce una specie di inversione di tendenza interessante e rappresenta una forma di pressione e messa all’angolo di Trump. Sicuramente c’è un conflitto intra-governamentale che è molto interessante e che vedremo quanto possa essere potente. Una contrapposizione di questo tipo tra governo centrale e governi locali si è data anche in Italia, per esempio quando il sindaco di Riace si è opposto alle politiche anti-migratorie di Salvini. Certo Washington non è esattamente Riace! Negli Stati Uniti una vera novità sarebbe assistere a qualcosa di simile a quello che è avvenuto in Spagna, quando si è dato un movimento municipalista di trasformazione. Siamo ovviamente ben lontani da un processo di questo tipo, ma sono dinamiche da tenere presenti.

In questi giorni stavo pensando che il movimento di Ferguson del 2014-2015 ha svolto quasi un ruolo “formativo” rispetto a un certo linguaggio e forse anche il ruolo dell’università è stato importante perché anche le università hanno contribuito a creare un senso comune sui temi che riguardano il razzismo e il genere considerando l’attenzione che c’è ai dipartimenti di African-American Studies e Gender Studies.
Sicuramente le università hanno svolto una funzione importante, ma c’è anche un ulteriore aspetto di maturità di questo movimento che occorre segnalare: rispetto a Ferguson, per esempio, ci sono molti più bianchi che partecipano alla lotta. E questo non perché prima non fossero solidali ma perché ora hanno una formazione più completa che li rende capaci di partecipare. Credo che ci sia – e anche questa è una novità – tutta una generazione nuova di militanti bianchi che ora sanno come partecipare e come stare in una lotta anti-razzista. E anche questa è una questione di formazione politica all’interno dei movimenti. In queste manifestazioni in cui partecipano oltre agli afroamericani, latinx, asiatici e bianchi è visibile il fatto che non si tratta solo manifestare solidarietà o esprimere un’alleanza, ma di sentirsi pienamente parte del problema. La questione del razzismo è davvero un problema di tutti. Non si tratta solo di essere solidali con le “povere vittime nere” ma di essere pienamente coscienti che una società razzista fa schifo per tutti quanti.

Una delle forze che più colpisce di questo movimento americano è stata la sua capacità di generalizzazione a livello mondiale. Enormi manifestazioni ci sono state non solo in tutte le principali città americane ma anche a Londra, a Berlino, a Parigi e in Italia. Come mai una lotta contro il razzismo strutturale (che negli Stati Uniti ha delle peculiarità molto specifiche) riesce a diventare immediatamente generale?
L’immagine che offre la stampa americana e che ritengo sia completamente falsa è che questi movimenti altrove, in Europa, in Australia e così via siano dei movimenti in solidarietà con gli afro-americani. A me sembra che la generalizzazione e la diffusione delle lotte oltreoceano sia data dalla consapevolezza del razzismo strutturale in ogni paese dell’Europa come in Australia. Il movimento di queste settimane è una scintilla che parte dai movimenti americani e arriva a quelli europei, che si trovano in una situazione altrettanto matura per affrontare la questione del razzismo. Certo, ogni espressione di questo movimento globale avrà delle caratteristiche locali, ma sicuramente in Italia, in Francia oppure in Inghilterra (che tra loro hanno contesti di partenza molto diversi) c’era già una lotta molto sviluppata e avanzata contro le violenze della polizia e più generale contro il razzismo strutturale. Questo evento americano, questa sollevazione così partecipata e diffusa cade, per così dire, in un campo che era già preparato, in una situazione che è già matura dal punto di vista delle lotte e dei discorsi.

In Assemblea tu e Toni Negri avete dedicato diverse pagine alla dimensione “leaderless” dei movimenti attuali. Questo movimento di Black Lives Matter sembra esprimere questa caratteristica in modo particolarmente evidente. Che cosa dice questo aspetto del movimento attuale?
È un fatto assodato che Black Lives Matter sia un movimento non centralizzato e quindi senza portavoce o leader. E d’altra parte tutti i movimenti di questa generazione si devono confrontare con quest’esigenza di organizzarsi senza centralizzazione. Però come tutti i movimenti che riescono a essere efficaci e vincenti necessitano, anche senza una struttura centralizzata, di un notevole sforzo di organizzazione – e questo è un aspetto che si nota moltissimo nelle ultime settimane. Black Lives Matter, come tutti sanno, non è un’organizzazione in senso stretto: manca un comitato centrale e non c’è un leader. Black Lives Matter è un nome comune che ogni gruppo locale può usare e fare proprio. Eppure quello che osserviamo in queste settimane è quanto siano ben organizzati i movimenti negli Stati Uniti. In ogni città le manifestazioni sono perfettamente organizzate, anche per quanto riguarda gli aspetti pratici. Per esempio l’enorme manifestazione a Washington della settimana scorsa che ha raccolto più di 20-30 mila persone è stata organizzata fin nei minimi dettagli: c’era l’acqua gratis per tutti, snack da mangiare, disinfettante e persino protezione solare, perché c’era un sole fortissimo quel giorno. Quello che voglio osservare tramite questo esempio è che anche se un movimento di questo tipo è leaderless non manca di organizzazione, anzi richiede ancora più organizzazione. Ed è quello che vediamo all’opera nel movimento attuale – e sono anche queste le ragioni per cui dura così a lungo e riesce ad avere tanti successi – perché ognuno di questi gruppi locali che prendono il nome di Black Lives Matter hanno una forza e una capacità organizzativa così elevata.

Una delle parole d’ordine delle piazze di Black Lives Matter di questi giorni è stata “defund the police” e in alcuni casi addirittura “abolish the police”. Come vedi questa rivendicazione e cosa pensi che esprima questa attenzione agli apparati repressivi dello Stato? Quale pensi che sia la sua centralità nella fase attuale?
La parola d’ordine “defund the police” è a mio avviso interessante e in parte per la sua ampiezza. Nel senso che da un lato potrebbe persino costituire una richiesta di riforma abbastanza moderata che limita le responsabilità della polizia per dare fondi ad altre agenzie governative che potrebbero essere in grado di gestire delle situazioni che non necessariamente richiedono la presenza della polizia o nelle quali la polizia non sarebbe adatta. Ma dall’altro lato – come si evince dalla parola d’ordine “abolish the police” – si tratta di una rivendicazione piuttosto radicale che deve essere inserita all’interno di una riflessione che va avanti da qualche decennio sull’abolizione del carcere e quindi anche della polizia: l’idea è proprio quella di abolire tutta la struttura carceraria di cui la polizia fa parte. Se per un verso “defund the police” potrebbe sembrare una proposta moderata, l’idea di trasformare tutto il sistema poliziesco e carcerario (l’idea di abolire la polizia) è davvero una proposta rivoluzionaria. Il punto per i movimenti è che la trasformazione del sistema della polizia, anche se in forma minimale, attraverso il definanziamento, è sempre visto come il sintomo di un problema molto più profondo che riguarda il razzismo strutturale e da ultimo la messa in discussione di una società razzista. Certo, riformare la polizia potrebbe anche andare bene ed essere un primo passo, ma l’ambizione dei movimenti è molto più elevata e guarda a una trasformazione più radicale e strutturale. L’obiettivo è trasformare la società in quanto tale. In conclusione tutte queste parole d’ordine (“defund the police” o “abolish the police”) sono come tutte le parole d’ordine molto utili per far avvicinare le persone al tema o al problema generale, però una volta che ci si è avvicinati al problema, il modo di affrontarlo deve diventare più complessivo e generalizzato: si comincia dalla polizia per problematizzare un’intera società razzista e per capire una volta per tutte come trasformarla.
Questo articolo è stato pubblicato per DinamoPress il 18 giugno 2020.