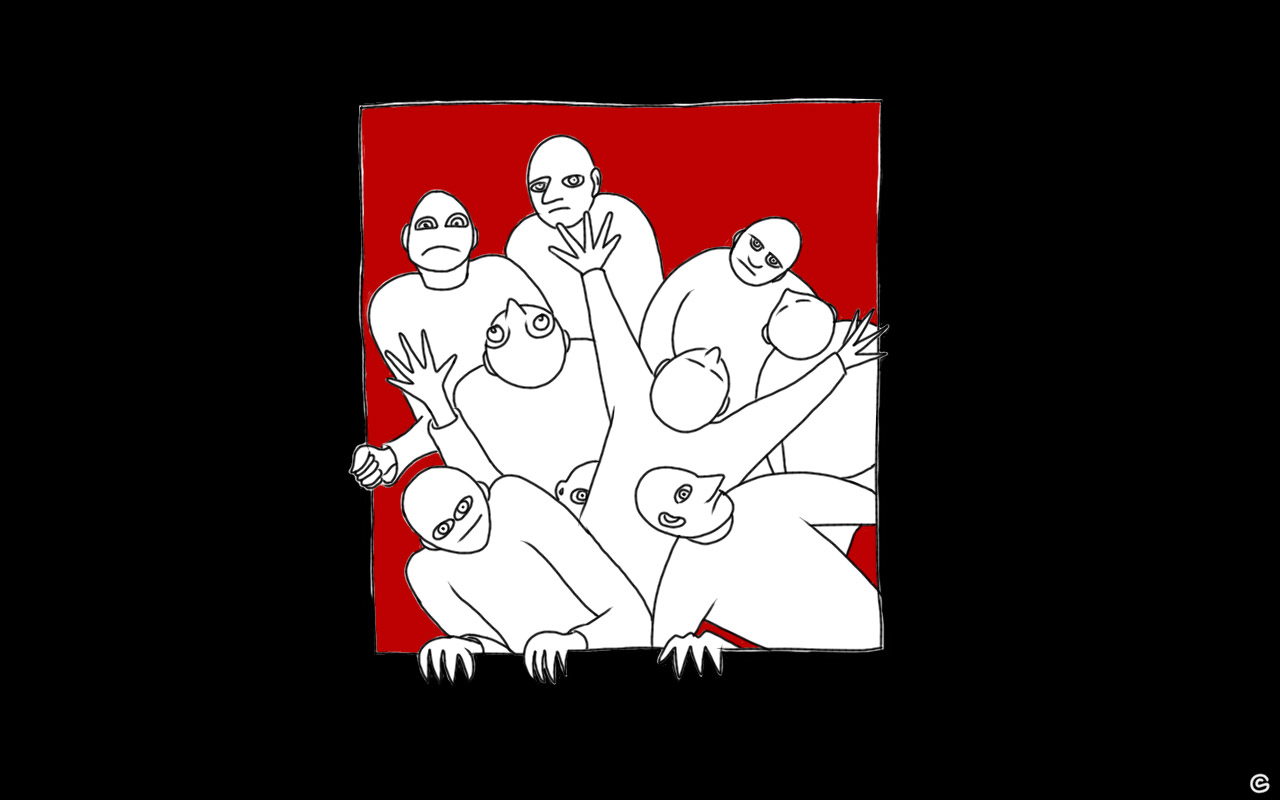di MARCO ASSENNATO.
Una tendenza continentale.
La governance europea sembra destinata a ristrutturarsi in direzione di una relativa cessione di sovranità dal centro verso le macro-aree nazionali, seppure in modo contraddittorio ed in una situazione sempre più instabile. Occorre allora interrogarsi sulla natura politica di questa tendenza: sulla sostanza concreta che potrebbe incarnare le richieste crescenti di decentramento e cessione di sovranità. A prima vista si può affermare che, mentre proliferano filtri, frontiere, muri e controlli, l’integrazione finanziaria e dei mercati resta forte e rivendicata anche da quei paesi che prima degli altri hanno imboccato la strada del nazionalismo. La tanto invocata sovranità, di conseguenza, è da intendersi solo come esercizio di ordine pubblico interno e come forza militare autonoma, per chi dispone di eserciti e truppe, da spendere nello scacchiere geopolitico. Una prospettiva tutta giocata sugli squilibri tra centro e periferia del continente, paesi dominanti e paesi subalterni, che poi, come ha notato di recente Marco Bascetta, «le regole del mercato unico si incaricano di perpetuare».
In Francia, tale processo assume forma politica sotto la pressione crescente del Front National. In vista delle elezioni presidenziali del 2017, commentatori e politologi si sprecano nell’esaminare la droitisation dell’intero quadro pre-elettorale, che viene ridotto alla domanda di nuovo ordine e di autorità riconoscibili, attraversato «oggettivamente» da emergenze xenofobe, retoriche nazionaliste e culto dell’uomo forte. In effetti, tanto a destra quanto a sinistra, non si discute che della forza della Repubblica Francese. Tradita, piegata, oppressa, colpita, questa presunta identità viene declinata all’interno di due macro-narrazioni: neocoloniale e populista a destra, e ideale e universalista, a sinistra.
Certo non è una storia nuova. Mesi addietro Jaques Rancière ha analizzato con precisione la «perversione» progressiva degli «ideali repubblicani», branditi come strumenti di «divisione dei corpi sociali» da almeno un ventennio. In effetti in Francia l’appello ai valori della République – e alla difesa della sua costituzione – costituisce ormai una gabbia più che una risorsa per invertire la dinamica politica. L’ordine del discorso sulla droitisation andrebbe ribaltato. Segnalando innanzitutto quanto lo spostamento a destra dell’opinione pubblica non sia per nulla l’inevitabile conseguenza della domanda di cambiamento che sale da segmenti sociali impoveriti, contrapposti alla minoranza dei garantiti – in uno schema secondo il quale da una parte sarebbero i soggetti nazionali periferici, il popolo, e dall’altra élites globali urbane – quanto piuttosto l’ennesima rappresentazione che deriva da un lungo lavoro ideologico, attraverso il quale i dirigenti politici dei partiti repubblicani e buona parte degli intellettuali mainstream hanno costruito e promosso un mercato elettorale attraversabile solo sul terreno della sicurezza e con il linguaggio dell’emergenza, ma completamente impermeabile alle questioni politiche fondamentali del nostro tempo – le grandi migrazioni, la nuova forma della produzione, la guerra e la pace, la richiesta di nuove istituzioni post-statuali – date per immodificabili o suscettibili solo di aggiustamenti tecnici. Ciò determina una modifica significativa nel sistema politico francese, tanto a destra quanto a sinistra.
La destra e la variante populista
Al primo turno delle primarie dei Républicains hanno partecipato 4 milioni di francesi. Nella ormai canonica miopia dei sondaggisti, che prevedevano un confronto serrato tra Alain Juppé e Nikolas Sarkozy, ha prevalso la proposta di François Fillon – che di Sarkozy era stato primo ministro. Il dato della partecipazione è impressionante, ma non segnala per nulla, come potrebbe apparire, una tenuta della struttura organizzata del partito rifondato da Sarkozy. In questo caso, infatti, l’ex-presidente avrebbe tratto vantaggio dal pressoché totale controllo sugli apparati e dalla frammentazione delle candidature contrapposte alla sua. La forte partecipazione conferma piuttosto l’ordine del discorso nel quale è costretta la partita delle elezioni: ovvero quel mito delle istituzioni nazionali francesi, sovrane e autonome, che ha costituito il ritornello fondamentale degli ultimi anni di governo tanto della destra, quanto dei socialisti. Fillon coagula attorno a se un consenso fortemente classista, composto da elettori benestanti e che si considerano, per vocazione, destinati a dirigere lo Stato in modo autorevole e saldo. Una destra vera – ha notato Denis Pellitier, storico dell’EPHE – che possa finalmente compiere quanto non è stato possibile negli ultimi trent’anni, rivalutando quel patrimonio di valori e strategie liberali che né Sarkozy, né Alain Juppé avrebbero avuto la forza di interpretare.
In chiaro: François Fillon compete direttamente con il Front National attingendo a piene mani dal catalogo di slogan securitari e razzisti sedimentato in questi anni di Stato di Emergenza, cui aggiunge, a differenza di Sarkozy, rapporti stretti con aree di cattolicesimo conservatore e militante che hanno animato le Manif pour tous contro la legge Taubira nel 2012-2013. Ma, a dispetto della retorica sui valori che hanno fondato la Francia, declina la sua proposta in un’inedita forma di neosovranismo in salsa tatcheriana. Ostile a quel che resta del welfare e dei servizi pubblici, pronto allo smantellamento del diritto del lavoro, esplicito nell’attacco ai sindacati, Fillon propone di estendere la durata del tempo di lavoro fino a 48 ore settimanali, la fine delle 35 ore, il passaggio a 39 ore per tutta la funzione pubblica, la soppressione di mezzo milione di posti nella funzione pubblica, la diminuzione della copertura sanitaria, la soppressione dell’ISF (l’imposta sulle grandi fortune), la diminuzione dell’indennità di disoccupazione, della RSA e delle allocations familiales. Come dire: il prezzo per tornare a contare nel mondo è ammettere che la festa è finita, che è tempo di scelte decise, tutte non a caso rivolte a confermare quel sistema impersonale di regole sulla vita che i trattati europei impongono, contrattando tuttavia piena sovranità sul margine interno della vita sociale.
D’altra parte però, Fillon inserisce una variazione significativa nella tradizionale politica estera francese recuperando i positivi rapporti con Putin che aveva coltivato – ancora una volta a dispetto di Sarkozy – durante il periodo in cui guidava l’esecutivo nazionale. Le conseguenze geopolitiche di un allineamento francese all’asse Russia-Turchia nella lotta al terrorismo, non sono difficili da prevedere: la rottura dell’asse Franco-Tedesco lascerebbe via libera a un’Europa dominata dai populismi nazionalisti amici di Putin. Per intenderci, ciò significa ad esempio che i bombardamenti russi contro i ribelli al regime di Assad e l’iniziativa turca contro la Rojava e contro ogni gestione autonoma del territorio curdo, nell’amichevole indifferenza del Presidente-eletto degli USA Donald Trump, non avrebbero più alcun limite. Ma più in generale questa ipotesi svincolerebbe il paese che possiede l’arsenale militare più significativo del continente, da qualsiasi logica di condivisione delle scelte strategiche, mentre segnerebbe una torsione drammatica sulla gestione dei flussi migratori, soprattutto in un quadro che vede progressivamente indebolirsi la posizione di Angela Merkel.
Non a caso, nel discorso di Fillon, l’apertura filo-russa, va di pari passo con una concezione dell’Europa come campo di scontro tra interessi nazionali distinti. Seppure fortemente integrati sul piano finanziario e dei mercati, i nuovi Stati riconquistano quote di autonomia strategica in politica estera e nella gestione interna delle popolazioni. L’Europa dunque viene immaginata da una parte come piazza finanziaria e tuttavia, sul piano politico, si riduce a una coalizione instabile di piccole patrie, governata da un “direttivo” composto dai presidenti degli stati membri e da una presidenza del direttivo a turno. La fine del processo d’integrazione europea va di pari passo dunque con l’emergere di nazionalismi ideologici utili a reagire al disordine dei movimenti soggettivi con il pugno di ferro.
I problemi a destra derivano tuttavia dal fatto che le elezioni dell’anno prossimo si giocheranno – facile previsione – interamente sul secondo piazzato dopo Marine Le Pen. Il tema sarà dunque quello di due fronti repubblicani contrapposti, quello esplicitamente neofascista e quello invece composito, insieme neoliberista e neo-sovranista, cui dovrebbero accedere anche un certo numero di consensi di sinistra. Ora però François Fillon è un candidato difficile da digerire per l’elettorato democratico in fuga dai socialisti. In chiaro: in un ipotetico ma fortemente verosimile secondo turno che oppone il FN a una desta con questo profilo, quegli elettori di sinistra che si sono mobilitati per Alain Juppé alle primarie, difficilmente voteranno Fillon turandosi il naso. Dal canto suo, Marine Le Pen si predispone a una campagna elettorale tutta giocata su temi sociali ed economici per compensare l’impatto della crisi sulle classi medio-basse della società. Sovranità popolare contro le oligarchie finanziarie, uscita dall’euro, difesa dei salari e delle pensioni francesi, chiusura delle frontiere, protezionismo, disegnano il catalogo di una offerta politica anti-casta e razzista ma fortemente orientata a presentarsi come unico contropiede coerente al tardivo tatcherismo della destra. Una contesa che offre, come si vede, un ottimo esempio concreto dell’abecedario della variante populista – e della sua versione rivoluzionaria.
Il crepuscolo della sinistra
Il dibattito a sinistra, in questo quadro, conta davvero poco. Non a caso viene definito dalla stampa – anche quella, per così dire, vicina al PS – crepuscolare. Una guerra tra mezze figure del tutto sradicate dalla società e dedite, ben che vada, ad un confronto tra strategie negative: pentimenti, autocritiche, polemiche segnano il punto più basso della storia dei socialisti francesi, almeno dal 1993, quando dei 257 deputati eletti nel 1988 ne restarono solo 57. Che alle primarie della Belle Alliance Populaire – così recita lo slogan della campagna per il 2017 – possa esserci una partecipazione minimamente comparabile a quella della destra è fuori discussione. Ciò significa che Les Républicains si presentano come ultimo argine contro la vittoria del Front National, mentre il crollo dei socialisti è dato per ovvio. L’apparato del PS sembra infatti implodere tra narcisismi sterili e ambizioni infondate – i candidati sono fin qui una mezza dozzina – assediato a sinistra dalla campagna anti-sistema di Jean-Luc Mélenchon – che invoca una nuova Era del Popolo – e a destra da Emmanuel Macron, ministro dimissionario del governo di Emanuel Valls che ha deciso di recitare la parte del Chicago boys in ritardo di un quarantennio. Una competizione roboante nei toni eppure segnata dall’indifferenza generale del paese, tanto che farne la cronaca precisa non avrebbe molto senso. E neppure è utile ricordare i tanti passi falsi, gli errori e le scelte disastrose dell’ultimo quinquennio. La cronaca è nota e facilmente reperibile.
Piuttosto forse si dovrebbe ragionare su quale ipotesi politica generale ha prodotto questa situazione. Perché in effetti la crisi dei socialisti francesi non è spiegabile semplicemente attraverso la canonica denuncia di una sinistra moderata schiacciata dai diktat neoliberisti e dimentica della sua tradizione e della sua base elettorale. Lo schema di governo di François Hollande è stato più complesso di così. Lo stesso presidente ne ha disegnato i tratti in due occasioni: il 12 settembre, intervenendo al convegno della Fondation Jean Jaurès su La democrazia di fronte al terrorismo e, più di recente, nel breve intervento dall’Eliseo, con il quale annunciava la decisione di non ricandidarsi nel 2017. Il primo era ancora un discorso da candidato naturale, mentre l’altro mostrava piuttosto il lato patetico di un commiato impotente, ma i due discorsi sono assolutamente convergenti.
 A settembre il presidente, inscrivendo il ragionamento in una «lunga» battaglia contro il terrorismo internazionale, si spendeva nell’elogio della Francia come «idea», sprecava toni patriottici e retorica universalistica. Inutile dire che, nelle parole di Hollande, l’Europa valeva solo come estensione di questa proiezione ideale della Francia, vera patria dei diritti universali dell’uomo. Polemizzando contro la propaganda di Sarkozy e contro la strategia del ripiegamento identitario del Front National, Hollande si presentava come rappresentante di una posizione costituzionalista, che combatte la barbarie attraverso il diritto disponibile perciò ad inscrivere nella Costituzione lo Stato d’Emergenza, così da «precisarne l’uso» e ad introdurre la possibilità di privare della nazionalità francese i cittadini condannati per atti terroristici. Due ipotesi, diceva allora Hollande, bloccate essenzialmente «dalla destra».
A settembre il presidente, inscrivendo il ragionamento in una «lunga» battaglia contro il terrorismo internazionale, si spendeva nell’elogio della Francia come «idea», sprecava toni patriottici e retorica universalistica. Inutile dire che, nelle parole di Hollande, l’Europa valeva solo come estensione di questa proiezione ideale della Francia, vera patria dei diritti universali dell’uomo. Polemizzando contro la propaganda di Sarkozy e contro la strategia del ripiegamento identitario del Front National, Hollande si presentava come rappresentante di una posizione costituzionalista, che combatte la barbarie attraverso il diritto disponibile perciò ad inscrivere nella Costituzione lo Stato d’Emergenza, così da «precisarne l’uso» e ad introdurre la possibilità di privare della nazionalità francese i cittadini condannati per atti terroristici. Due ipotesi, diceva allora Hollande, bloccate essenzialmente «dalla destra».
Seguiva poi il catalogo pragmatico delle «scelte difficili eppure compiute»: ben quattro leggi antiterrorismo approvate dall’amministrazione, il rafforzamento della repressione dell’apologia del terrorismo su Internet, il prolungamento dello stato d’emergenza, la chiusura delle moschee considerate radicali, le tante espulsioni di «soggetti pericolosi». E poi: l’aumento del finanziamento delle forze dell’ordine che consegnava un saldo di 9000 posti di polizia in più, contro i 13000 soppressi dall’amministrazione precedente e ovviamente un nuovo vigore nell’interventismo militare, in Iraq, Mali e Siria. Tuttavia, diceva allora Hollande, emergenza sicurezza e crisi sociale sono due facce della stessa medaglia. A questo catalogo dunque faceva da contraltare la difesa decisa del sistema pubblico francese. Qui stava tutta la differenza con gli altri candidati.
Una differenza ribadita nel secondo discorso, quello della rinuncia alla candidatura. Tutto giocato sulla linea della «coesione nazionale», il discorso del commiato socialista, chiarisce il punto: il presidente sostiene di avere essenzialmente difeso, contro gli eccessi dell’austerity, il modello sociale della quinta repubblica. Pur tenendo «i conti pubblici in ordine» l’amministrazione Hollande ha abbassato l’età della pensione, esteso la complementaire santé, ed ha ripreso a finanziare il sistema educativo nazionale, intervenendo in particolare sulla formazione professionale. Mentre parallelamente ha rivendicato l’insieme di norme che compongono la riforma territoriale, la fine del cumulo dei mandati e la trasparenza della condotta degli eletti, insieme alla firma, a Parigi, dell’accordo contro il riscaldamento globale e, sui diritti civili, l’importante risultato ottenuto con la legge che regola il mariage pour tous.
Ma, ha precisato Hollande, il suo impegno principale era stato quello della lotta alla disoccupazione. A questo punto il discorso si sdoppia. Al socialdemocratico si affianca il più grigio dei neoliberali: «ho diminuito le tasse per le imprese – ha detto il Presidente – perché questa è la condizione per creare dei posti di lavoro, ho aiutato le assunzioni, ho investito sulla formazione professionale, sull’innovazione tecnologica, e ho riformato il mercato del lavoro». I risultati, però, tardano ad arrivare. Da qui la sua decisione di non candidarsi. Hollande non vede la precarizzazione e la marginalità sociale, se non come escrescenze inspiegabili del normale processo di integrazione nel sistema socio-economico nazionale. Difetti di un sistema che si governa col pilota automatico. Lo stesso doppio registro si nota sul passaggio che ha voluto dedicare, in chiave polemica rispetto alle paure agitate dalla destra, all’Europa. Il presidente ha ribadito di aver combattuto, nei limiti del possibile, contro gli eccessi delle politiche di «austerità » ad esempio quando ha gestito la mediazione che ha permesso alla Grecia di «restare nella zona euro», per evitare l’implosione dell’Unione. Ma non percepisce neppure l’ipotesi che il limite di fondo della sua condotta sia stato quello di guardare al continente unicamente come campo da gioco dello Stato francese e di immaginare un processo di integrazione dominato dall’asse con Berlino.
Ora, smentire puntualmente questa descrizione non sarebbe difficile. Ben altre cronache del quinquennio hanno attraversato le strade di Francia. Proviamo tuttavia a concentrarci sulle conseguenze di questo stato delle cose a partire da una prima ipotesi: nella crisi francese e con il collasso prossimo venturo del PS, vanno in soffitta le due posizioni che dominano il dibattito delle sinistre. Non è il compromesso ragionevole tra ragioni della crescita e neoliberismo economico, tra coesione nazionale e integrazione finanziaria continentale, che contraddistingue tutto il dibattito del PSE? La storia dell’amministrazione Hollande è tutta attraversata dal continuo incrocio della posizione classica della socialdemocrazia, con quella, diciamo per intenderci, da terza via neoliberista. Ora Il fallimento di questo mandato dimostra insieme l’impossibilità di questo compromesso e il fallimento di entrambe le strade che lo compongono.
Alla insostenibilità delle politiche neoliberiste, ormai sempre più appannaggio di destre reazionarie e autoritarie, fa da contraltare il fatto che la difesa del modello sociale delle costituzioni socialdemocratiche non è più sufficiente: intanto perché non copre più vaste parti dei corpi produttivi e poi perché, se giocato solo all’interno delle frontiere dei singoli stati, viene sistematicamente sabotato da controspinte direttamente derivanti dalla pressione dei mercati finanziari. In due momenti, negli ultimi anni, i socialisti francesi hanno avuto occasione di avvedersene: subito dopo i primi attentati parigini, quando un’imponente e spontanea mobilitazione di massa ha preso parola e incominciato il lungo racconto delle periferie e dei ghetti urbani ma anche di singolarità metropolitane meticce e multiculturali; e poi, ovviamente, nella vasta mobilitazione contro la riforma del codice del lavoro dei mesi scorsi. Hollande e Valls hanno deciso di soffocare nella narrazione nazionalista della patria in lutto il primo evento e di schiacciare a colpi di manganello la seconda insorgenza, spezzando definitivamente ogni rapporto con la società e confinando la sinistra nella fogna dell’autonomia (nazionale) del politico.