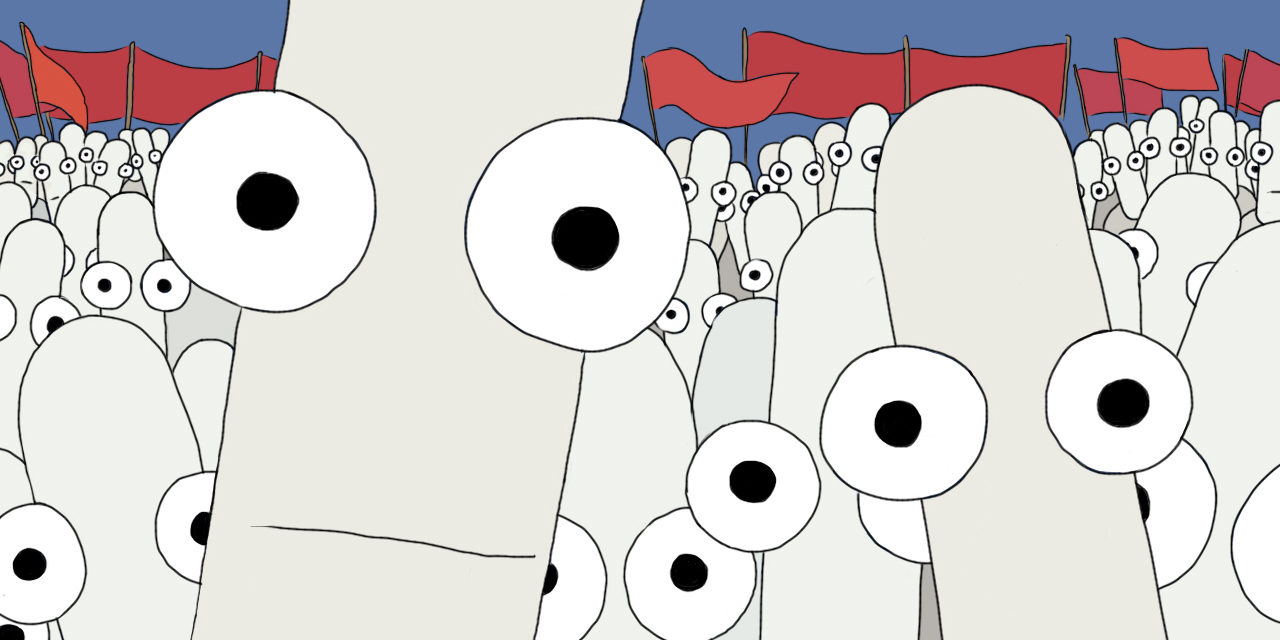del COLLETTIVO EURONOMADE.
Abbiamo scelto di lasciar trascorrere più di una settimana, prima di proporre alcune considerazioni sulle giornate di Amburgo contro il G20, per alcune sostanziali ragioni. Innanzitutto perché abbiamo preferito si diradassero le nebbie mediatiche che, in Italia ma in particolare in Germania, hanno avvolto l’evento condizionando talvolta anche la stessa auto-narrazione di chi c’era.
In secondo luogo perché, a differenza di alcuni che ora sentenziano verità assolute dopo aver ignorato o volutamente snobbato per mesi la mobilitazione, abbiamo attivamente partecipato al processo collettivo che ha costruito quelle giornate, fin dal suo inizio, seguendo il dibattito tedesco e adoperandoci per una “transnazionalizzazione” del percorso. E per questo abbiamo preferito che le nostre stesse impressioni a caldo si sedimentassero in una riflessione più solida, per quanto provvisoria e aperta.
Last but not least (at all!), perché abbiamo ritenuto e riteniamo che l’urgenza di questo dopo Amburgo fosse la liberazione di tutte e tutti gli arrestati – quarantatré dei quali, nel momento in cui scriviamo, sono ancora detenuti – dedicando le nostre limitate forze essenzialmente a questo ed evitando, al contempo e come purtroppo spesso accade, che l’esclusivo dato repressivo condizionasse il giudizio politico da maturare sulle giornate. E il giudizio non può che essere articolato e complessivo. A partire dal riconoscimento della mancanza, fin qui, di un’analisi adeguata di che cosa il vertice dei G20 e il suo esito significhino nell’attuale contesto di crisi della governance planetaria.
Il summit ha infatti avuto il merito di scattare una fotografia istantanea del nostro tempo, che potremmo sinteticamente definire come quello del “disordine globale”, a quasi dieci anni dall’inizio della grande crisi finanziaria ed economica. E in questa occasione si sono visualmente giustapposte diverse opzioni politiche di risposta alla crisi. I vertici dei Sette (o Otto Grandi, dal momento in cui è stata inclusa anche la Russia), nell’“età dell’oro” della globalizzazione, si erano caratterizzati per l’ambizione di definire un “nuovo ordine mondiale” a guida statunitense, nel tentativo di offrire una cornice politica di governo a quella figura storica che avevamo definito come “Impero”. Tale pretesa era allora supportata dall’ottimistica promessa di maggiore benessere per tutti, in grado di accompagnare e conciliare armonicamente lo sviluppo delle nuove macchine produttive e dei nuovi mercati “emergenti” nel quadro di una riorganizzazione integrata e complessiva della divisione del lavoro su scala globale.
Oggi, in particolare nelle “terze vie” clintoniane, blairiste (o uliviste) che avevano accompagnato quella fase dei processi di globalizzazione, il fallimento del modello neoliberale risulta evidente, proprio a partire dalla registrazione del generale fenomeno di impoverimento che ha segnato, nell’ultimo decennio, la condizione di una stragrande maggioranza della popolazione, nel Sud come nel Nord del mondo. E ciò a cominciare da alcune specifiche caratteristiche del rapporto di capitale, la cui affermazione ha preceduto e determinato l’innesco della crisi: la pervasività della forma finanziaria, l’impiego unidirezionale delle nuove tecnologie digitali, l’approfondimento del carattere “estrattivo” del modo di produzione capitalistico su scala planetaria, con una conseguente concentrazione e polarizzazione della ricchezza a livelli mai visti prima.
Ma questo sistema fatica al tempo stesso a trovare una stabile forma di “governance globale”. La crisi sembra essere la cifra permanente di una transizione aperta, che genera crescenti tensioni a ogni livello: economico nello scontro tra potenze mondiali in declino e potenze regionali in ascesa, politico nella definizione dei rispettivi ruoli e sfere d’influenza, finanche militare là dove i conflitti non sono più gestiti da polarità forti. La medesima forma del G20 non è nata come semplice estensione “quantitativa” del G7 o del G8, ma come tentativo – avviato nel 1999 come incontro dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, non a caso all’indomani della prima crisi dei mercati asiatici – di allargare “qualitativamente” ai paesi emergenti la corresponsabilità nella stabilizzazione dell’economia globale, in particolare nella individuazione di dispositivi sistemici capaci di assorbire gli shock finanziari.
In questa chiave il summit di Amburgo ha saputo esibire una vera e propria “parata di mostri”. Ovvero la blindatissima sfilata di quelle figure che, in maniera certo diversificata fra loro ma nel condiviso tentativo di capitalizzare in termini di consenso il diffuso malessere sociale prodotto dalla crisi, stanno combinando la riproposizione di nazionalismo politico, misure di protezionismo economico e dispositivi autoritari di governo, con il mantenimento dei fondamentali pilastri del modello neoliberale. Ai vari Trump e Putin, Erdogan e Temer, Modi e Macri (per non parlare dei petrolsovrani sauditi) si sono, senza soluzione di continuità, contrapposti quanti stanno provando, anch’essi in diverse varianti, da Merkel a Macron, da Xi a Trudeau (fino ai paesi più marginali, Italia inclusa) a rilanciare un disegno di ri-stabilizzazione capace di confermare il business as usual dell’accumulazione capitalistica, governata però dall’esercizio di un multipolare soft power planetario. Ma anch’essi ben intenzionati a non mettere in discussione alcuna tra le determinanti neoliberiste degli ultimi decenni. Il documento conclusivo del summit è, sotto questo profilo, un capolavoro di equilibrismo e rappresenta l’ammissione dell’impossibilità di individuare, nelle condizioni date, una formula unificante le diverse élite e i differenti interessi capitalistici su scala mondiale.
Per gli uni e gli altri è però altrettanto chiaro come i processi di globalizzazione produttiva ed economica non siano affatto reversibili. E come uno dei punti di forza, e al tempo stesso di permanente instabilità, dell’attuale capitalismo risieda proprio nell’attitudine a giocare tutti gli elementi di eterogenità sociale, culturale, territoriale come altrettanti fattori di divisione, sfruttamento e valorizzazione differenziale, in un contesto attraversato da flussi finanziari che sono invece dematerializzati e deterritorializzati.
La gestione emergenziale della città di Amburgo, attraverso la sospensione temporale e spaziale dei diritti costituzionalmente garantiti e un sovradimensionato dispositivo di polizia, avrebbe dovuto assicurare che tale confronto-scontro si risolvesse all’interno degli ovattati spazi della Fiera. E avrebbe dovuto far sì che l’incontro dei principali attori istituzionali del “disordine globale” proiettasse invece all’esterno un’immagine di equilibrio e pacificazione. Anche ad uso e consumo, interno, della campagna elettorale (il prossimo 24 settembre si vota in Germania per il rinnovo del Bundestag) della Cancelliera Merkel, impegnata ad affermare – in particolare dopo l’elezione di Trump – un ruolo guida nella difesa e nell’implementazione dei valori dell’“ordoliberalismo ben temperato” su scala mondiale. E delle ambizioni politiche del Borgomastro della città anseatica, Olaf Scholz, pronto a candidarsi alla leadership di un’esangue socialdemocrazia all’indomani della probabile esplosione della bolla di sapone Martin Schulz.
Le cose, raccontano cronache da tutti ormai conosciute1, sono andate ben diversamente. Ma è, a questo punto, importante sottolineare come queste giornate di luglio ad Amburgo poco abbiano avuto a che fare sia con la ripetizione del noto copione dei “contro-vertici” del ciclo di movimento “no-global”, sia con la riproposizione di modalità e forme che hanno caratterizzato il ciclo dei movimenti delle “piazze” e comunque le lotte contro le politiche di austerità, nel Sud Europa in particolare. Senza pretese esaustive od omniesplicative, ci preme qui indicare alcuni tratti innovativi di questa esperienza.
Innanzitutto l’articolazione della protesta. Ogni singola giornata, ogni singola azione, ogni singolo momento perderebbe di senso se venisse isolato e analiticamente dissezionato. Forme assai diverse, che hanno visto il protagonismo di differenti attori politici e sociali, compongono la potenza che si è espressa nelle strade di Amburgo: solo se assunti come un tutt’uno, come un concatenamento la cui forza risiede nella successione, nella ricombinazione e nell’assemblaggio dei singoli eventi, i diversi momenti di espressione del movimento diventano significativi. Queste giornate – si tratta, su questo punto, di essere molto precisi – non sono state il frutto di un’unica strategia soggettiva, discussa e decisa a priori da un’unica coalizione di forze sociali e politiche organizzate. Intorno a ciascuna delle iniziative che hanno scandito la temporalità della mobilitazione si sono costruite, nei mesi precedenti, singole “piattaforme di scopo”, alleanze temporanee che hanno definito consenso intorno a contenuti e pratiche che i singoli eventi avrebbero dovuto assumere. Tali piattaforme si sono costituite con geometrie variabili, attraverso una flessibile collocazione delle stesse forze organizzate. E hanno tutte – a differenze di quanto accaduto in simili precedenti occasioni – saputo rispettare il perimetro di comportamento tracciato per ciascuna delle iniziative. L’unitarietà della protesta è emersa a posteriori, e costituisce un dato politico essenziale.
In secondo luogo il ruolo giocato dalla città. La specifica storia di Amburgo e dei suoi quartieri (e in particolare di quelli, come St. Pauli, Karolinenviertel e la Schanze, che circondano i padiglioni della Fiera sede del vertice) ha senza dubbio pesato: una stratificata accumulazione di lotte dei portuali nel secolo scorso, di lotte per la casa degli anni Ottanta e Novanta, un consolidato tessuto di cooperazione e impresa, alternativa e solidale, di lotte attuali contro la speculazione edilizia e i processi di “gentrificazione”, di diffuse iniziative di solidarietà e accoglienza dei e con i migranti, tutto questo ha certo determinato il clima di rifiuto generalizzato dell’utilizzo dello spazio urbano da parte dei “potenti della Terra”, e di rigetto del dispositivo di militarizzazione, che si è spinto ad assumere le caratteristiche di una occupazione del territorio da parte di una potenza militare estranea. Ma c’è qualcosa di più. In una logica di rispecchiamento, nella stagione “no-global” dei primi anni Duemila, le città erano in fondo, sia per gli organizzatori dei summit sia per i movimenti che vi si contrapponevano, il “palcoscenico” sul quale rappresentare uno scontro che aveva altrove la sua origine e la sua ragion d’essere. Oggi le cose sono cambiate: è la città stessa, per la valenza produttiva e sociale che ha assunto e per il fatto di costituire in conseguenza lo spazio per eccellenza dei conflitti contemporanei, a divenire la protagonista assoluta delle giornate contro il G20. È la contesa intorno al controllo dello spazio metropolitano a balzare in primo piano come posta in gioco del conflitto stesso.
In terzo luogo l’eccedenza sociale. Se quanto accaduto ad Amburgo si fosse limitato all’iniziativa delle forze organizzate (tutte, nessuna esclusa, da quelle sindacali e partitiche fino ai gruppi “insurrezionalisti”), il risultato non sarebbe certo stato quello della plastica esplosione del rifiuto dei G20 e della sostanziale ingovernabilità del contesto urbano per cinque lunghi giorni. Attenzione, nessuna acritica esaltazione qui di una presunta “spontaneità delle masse”! Se la ricca articolazione delle iniziative organizzate, appena menzionate, non avesse funzionato da fondamentale fattore di costruzione di un contesto favorevole, cioè da vera e propria infrastruttura politica di queste giornate (un’accusa, in fondo non a torto, rivolta dai politici e dalla stampa più reazionaria alle componenti più istituzionali, come il partito Die Linke, o moderate, come la rete di Attac, della mobilitazione), la multiforme composizione sociale di giovani e giovanissimi, che ha letteralmente preso le strade di Amburgo, forte dei suoi tratti nomadici, meticci, metropolitani, difficilmente avrebbe trovato lo spazio e l’occasione per esprimersi. Parliamo di decine di migliaia di persone, in parte abitanti dei quartieri, in parte arrivate da tutta Europa, al di fuori delle reti organizzate (tutte) e spesso alla loro prima esperienza di mobilitazione transnazionale, aggregate in piccoli gruppi di affinità, aperte all’invenzione, momento per momento, delle forme più adeguate per occupare, scontrarsi e contendere il tessuto metropolitano al dispositivo di polizia. E anche in questi comportamenti sociali ritroviamo, si badi bene, quella ricca e diversificata articolazione di cui abbiamo parlato: non tutti hanno fatto tutto. E non sono mancate “sbavature” e contraddizioni, che sono state discusse e, a lungo, saranno discusse.
Ma, a partire dall’assunzione di queste tre coordinate, possiamo provare a riconoscere alcuni elementi omogenei. Uno su tutti: la capacità di sconfiggere la produzione statale e mediatica della paura. È del tutto evidente come il primo obiettivo del temporaneo “stato d’emergenza”, che si voleva imporre nei giorni del summit alla seconda città della Germania, fosse proprio quello di ridurre la contestazione a marginale corollario, nella cornice della rappresentazione post-democratica del dissenso tollerabile e tollerato. Tracciare il confine tra ciò che è compatibile – e ciò che non lo è – è l’effetto voluto della costruzione del “terrore sovrano”, quello alluso, minacciato, esibito. Decine di migliaia di persone, complessivamente 250mila è stato calcolato, si sono in forme diverse e articolate attivamente sottratte a questo meccanismo. E hanno avuto la capacità di rovesciarlo nella rottura della disciplina e del controllo sullo spazio urbano. Nel blocco dei flussi lineari della comunicazione, della mobilità e della produzione (che sono poi la stessa cosa) all’interno di questo spazio. In diffusa e partecipata riappropriazione di questo stesso spazio. Se dovessimo ricostruire – a posteriori – una implicita strategia sociale delle moltitudini in azione nelle strade di Amburgo, dovremmo riconoscervi il prendere concreta forma, in molteplici modalità e al di là di qualsiasi astratta formulazione, di un esperimento di pratica dello sciopero sociale metropolitano.
E se, infine, fossimo capaci di cogliere e di ri-assemblare in ciascuno degli eventi di queste giornate i singoli elementi caratterizzanti, saremmo forse in grado di indicare quale latente potenza ricompositiva venga prefigurata dalla potenziale confluenza di essi. Vi ritroveremmo infatti il segno delle diverse ondate globali che, negli ultimi mesi, hanno visto come protagoniste, di volta in volta, le donne e la forza del “non una di meno”; i migranti e la solidarietà delle Welcome initiatives; le diverse figure del lavoro sfruttato dalle piattaforme logistiche ed estrattive e le sue innovative forme di sciopero; le mille lotte locali che contrastano progetti devastanti per l’ecosistema; le esperienze di conflitto per il diritto alla città che talvolta si sono evolute in governi municipali di cambiamento.
Tutto questo è anche un effetto del ciclo di lotte contro le politiche di austerity, l’impoverimento e la precarizzazione, che hanno contribuito – come nell’esperienza di Blockupy a Francoforte – a disegnare negli anni scorsi un nuovo spazio sociale e politico dell’“Europa dal basso”. Ma quel ciclo – avremo modo di tornarci più approfonditamente nelle prossime settimane – è oggi concluso. Il tentativo di ri-stabilizzazione neoliberale e conservatrice in atto, che si sta dispiegando tra le elezioni presidenziali francesi e le prossime parlamentari tedesche, impone che le domande di giustizia sociale e di libertà, e di necessaria rottura costituente per il nostro continente, cerchino di individuare nuove e più adeguate forme di espressione e di organizzazione. Le giornate di Amburgo, su questo versante, ci consegnano per il momento la suggestione di una possibile riconnessione tra l’Europa e la scala geopolitica globale, in crisi di governance, come tema e terreno rinnovato dello scontro di classe oggi.
In questo senso è del tutto prematuro concludere se le giornate di Amburgo siano state un’eccezione, non riproducibile fuori dal contesto locale in cui sono avvenute, un singolo effimero evento, una isolata “fiammata” di conflitto. Oppure se abbiano indicato i prodromi di un nuovo ciclo globale di lotta e di alternative costituenti2. Solo i prossimi mesi ci diranno infatti se la confluenza di queste diverse ondate sociali possa trasformarsi nella mareggiata politica di una “terza opzione” di cambiamento e liberazione.
Segnaliamo qui, in italiano tra le altre, le cronache quotidiane pubblicate da il manifesto nei giorni 5, 7, 8 e 9 luglio e le corrispondenze in diretta riascoltabili sul sito di Radio Onda d’Urto. ↩
Nelle reti di movimento tedesche e italiane si è, a questo proposito, aperto un dibattito che seguiremo con attenzione. Segnaliamo, tra gli altri, i primi contributi della Interventionistische Linke (http://www.interventionistische-linke.org/beitrag/die-rebellische-hoffnung-von-hamburg) e di UmsGanze! (https://umsganze.org/gruss-aus-der-zukunft/), di DinamoPress (http://www.dinamopress.it/news/da-amburgo-con-amore) e del Centro sociale TPO di Bologna (http://www.tpo.bo.it/azioni/the-power-of-assemblage-tre-ipotesi-a-partire-e-oltre-il-g20-di-amburgo/ ). ↩