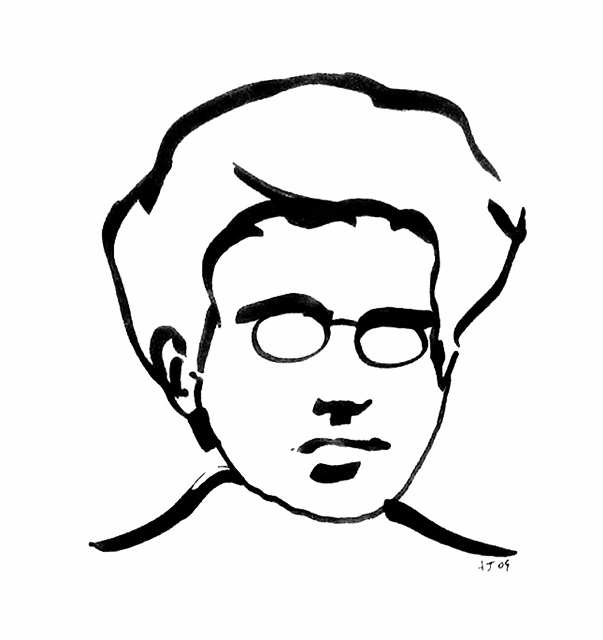di RAFFAELLA BATTAGLINI.
Dichiaro subito la mia parzialità: conosco Toni Negri da quando sono nata, e questa frase va intesa in senso letterale, perché Toni era amico di mio padre. Nella seconda metà degli anni Settanta, anch’io ho fatto parte di quel movimento che Negri in quanto teorico e militante ha contribuito a creare e organizzare. Molto più tardi, nel 2006, ho scritto insieme a Toni un testo teatrale su quegli anni, intitolato appunto Settanta. Anche la mia parzialità quindi va intesa in senso letterale, perché della vicenda che in Storia di un comunista viene narrata faccio oggettivamente parte, come del resto i moltissimi altri che hanno condiviso le lotte di quel periodo.
E così vengo immediatamente alla prima questione: è perlappunto di una vicenda collettiva che qui si narra. Leggendo, devo dire anche con un certo divertimento, la recensione di Simonetta Fiori su Repubblica e, ben peggio, quella di Raffaele Liuzzi sul Sole24ore (che arriva al punto di rispolverare il teorema Calogero…) – in cui la parola ricorrente, oltre alle prevedibili accuse di «mancanza di autocritica», è egolatria – mi vien da chiedere: ma che libro hanno letto? Se il recensore fosse un appassionato di autofiction, e non è certo il mio caso, la critica potrebbe essere esattamente contraria: quella di aver lasciato in ombra (se non nella parte relativa alla formazione, i Lehrjahre diciamo, in cui il vissuto familiare, spesso doloroso, è molto presente) l’autobiografia personale ed esistenziale, per esporre quasi esclusivamente il corpo politico dell’autore. Ma il punto è proprio qui: questa non è un’autobiografia nel senso corrente del termine, ma è anche e direi soprattutto la cronaca di un pezzo di storia italiana, raccontata da chi l’ha vissuta e sofferta in prima persona attraverso un decennio di lotte irripetibile.
Questo punto di vista oscurato e rimosso, quello di coloro che in quegli anni hanno lottato e sono stati sconfitti, come sappiamo è stato da tempo sostituito da una narrazione ufficiale univoca e deformante che ha criminalizzato l’intera esperienza, riconducendo l’antagonismo di un’intera generazione a un problema di ordine pubblico. È contro questo racconto dominante che Negri giustamente e da anni si batte, ed è questo il motivo delle reazioni scomposte che puntualmente si scatenano, peraltro esclusivamente in Italia, ogni volta che prende pubblicamente parola: non si tratta di una reazione ad personam, ma di una damnatio memoriæ dell’intero movimento degli anni Settanta, al quale nulla è stato perdonato né verrà perdonato mai – non perché sia stato più o meno violento, ma unicamente a causa del suo anticapitalismo radicale. I fulmini si scaricano contro Toni Negri perché è di fatto l’unico personaggio pubblico, oltretutto di grande prestigio internazionale, che non solo non ha rinnegato quell’esperienza, ma non perde occasione per rivendicarla.
Naturalmente il libro di Negri – che è diviso in tre parti: Andarsene, Laboratorio veneto, Dieci anni di ’68 – è anche molte altre cose: un’autobiografia intellettuale, il memoir di un filosofo e di un grande studioso, il diario di un militante, e infine il resoconto di un percorso esistenziale costellato di incontri con le personalità politicamente e intellettualmente più interessanti del suo tempo. Inoltre, soprattutto nella seconda e terza parte, è la ricostruzione attenta e minuziosa di una genealogia: di tutta quella filiera di eventi e di passaggi anche concettuali che hanno portato lui e molti altri al progressivo distacco dalle organizzazioni tradizionali della classe operaia (nel caso di Negri, il Partito Socialista) per approdare a nuove forme organizzative, all’inizio ancora vicine, o comunque aspiranti alla forma-partito (Potere Operaio), poi definitivamente affrancate da questa e disciolte nelle pratiche di movimento (l’Autonomia organizzata).
La geneologia non riguarda solo l’organizzazione, ma anche le forme di lotta: particolarmente interessante, a questo riguardo, tutta la parte relativa ai primi anni Sessanta, soprattutto l’incontro con Panzieri e la collaborazione con Quaderni Rossi, e, tramite Romano Alquati, l’iniziazione alla pratica della conricerca, un’analisi sociologica condotta insieme agli operai al fine di organizzare le lotte, che in Veneto verrà messa in atto per esempio a Porto Marghera. È da qui, tra le altre cose, che trae origine in quegli anni la teorizzazione diffusa del sabotaggio, inteso come uso sovversivo delle macchine da parte degli operai, contro il capitale.
Mentre nella prima parte l’io narrante oscilla fra la prima e la terza persona, come ancora alla ricerca di sé, nella seconda e nella terza parte quest’io diventa progressivamente un noi, e il ritmo del racconto si fa più incalzante, in una continua circolarità fra pratiche di lotta e pensiero teorico; dentro questo percorso, e centrale sul piano dell’elaborazione, si snoda la storia delle riviste di movimento, dai già citati Quaderni a Classe operaia, da Contropiano a Potere Operaio, fino a Controinformazione e soprattutto a Rosso, la rivista dell’Autonomia milanese: ognuna segna un passaggio di fase, un salto in avanti nella produzione di teoria e nel processo di organizzazione.
L’esperienza di Potere Operaio nasce nel ’69 e si chiude nel ’73. Lo spartiacque che darà origine alla scissione e poi alla fine del gruppo è quello tra illegalità di massa, sostenuta da Negri e dagli operaisti di Marghera, e militarizzazione del movimento, rivendicata da Piperno e dai «romani». Com’è noto, su quest’asse si spaccherà l’intero movimento, lasciando spazio alla crescita delle Br e del partito armato, che all’epoca sono ancora «un gruppetto». Prima, però, dalle ceneri di Potop si sviluppa la stagione dell’Autonomia organizzata, che caratterizzerà tutta la seconda metà degli anni Settanta: nel ’75 «una nuova generazione di militanti è apparsa sulla scena […] il testimone, dalle lotte operaie bloccate su posizioni di resistenza, era passato nelle mani dei giovani proletari», che escono dalle fabbriche e portano le lotte nel sociale e dentro la metropoli, e qui dal rifiuto del lavoro si passa a quel «riprendiamoci la vita», a quella rivendicazione del diritto alla gioia e alla pienezza dell’esistere che condurranno poi al movimento del ’77.
Nel ’78, con l’assassinio Moro, le Br si prendono la scena, autodelegandosi avanguardia del movimento e mettendo Autonomia nell’angolo. Hanno portato lo scontro a un livello che il movimento non è in grado di sostenere. È a questo punto che parte la repressione, non contro i militanti delle Br che sono in clandestinità, ma contro quelli di Autonomia che agiscono alla luce del sole. Il «teorema Calogero» si occuperà di far quadrare il cerchio, attribuendo un’unità organizzativa a due realtà incompatibili sia dal punto di vista dell’analisi che delle forme di lotta.
Con ottima intuizione drammaturgica, Negri cala di netto il sipario sul giorno dell’arresto, il 7 aprile del ’79. A questo punto vorrei raccontare solo un piccolo pezzo del dopo, cioè la manifestazione che si è svolta a Padova il giorno successivo. Mai potremo dimenticare quell’esodo di massa dal centro della città al Palasport dove si sarebbe svolta l’assemblea, sotto un cielo che ricordo di tempesta – aprile è il più crudele dei mesi… – con i blindati della polizia a ogni angolo di strada, tenuti sotto tiro dai cecchini che si erano appostati sui tetti lungo tutto il percorso. Non eravamo «terroristi», non eravamo armati, non eravamo lì per organizzare degli scontri: eravamo una massa di ragazzi in quel momento più sgomenti che incazzati, increduli di fronte alla gravità di quel che era avvenuto. Mentre gli elicotteri rombavano sopra le nostre teste, continuavamo a ripeterci i nomi dei compagni arrestati: tra i padovani c’era praticamente l’Istituto di Scienze Politiche al completo, non potevamo crederci… Quel giorno per le strade non c’erano soltanto i militanti dell’Autonomia, c’era l’intero movimento veneto, una folla.
Non sapevamo che era l’ultima volta. Non avevamo nessuna consapevolezza della fine: pensavamo di essere di fronte a un inciampo, molto duro, molto violento, ci rendevamo conto che lo Stato aveva «alzato il livello dello scontro», come si diceva allora, in modo inconcepibile, nel tentativo di decapitare il movimento: non pensavamo mai che ci sarebbero riusciti. Forse adesso è difficile da capire, ma noi eravamo cresciuti in un’atmosfera per molti versi esaltante, di grandissima euforia collettiva, e l’euforia derivava dal fatto che collettivo era l’orizzonte. Questo per noi era un fatto scontato, questa era l’aria che respiravamo: non potevamo immaginare che ci venisse tolta.
Non vorrei chiudere su questa nota sconfittista, perché sono sicura che a Toni non piacerebbe, e allora è necessario rilanciare: contro tutti quelli che pensano, e sono tanti, che il tempo delle rivoluzioni sia finito per sempre, noi sappiamo e diciamo che qualcuno raccoglierà il testimone. Forse non ora, ma si ricomincia da qui: proviamo ancora col rosso, Toni…