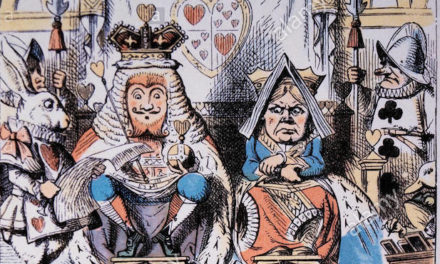di SANDRO CHIGNOLA.
In un recente articolo Marco Bascetta segnalava come la definizione della politica estera europea sia di fatto passata – non è questo un dato riferibile ai soli ultimi mesi – ai ministri degli interni. Al di là del fatto che, si tratti di Horst Seehofer in Germania, di Herbert Kickl in Austria o dell’esagitato Salvini qui da noi, il loro protagonismo speculi in molti casi sul piano delle mere opportunità offerte dal dibattito interno dei singoli paesi, questo ci sembra il dato incontrovertibile sul quale, nel medio periodo, si definisce il terreno di scontro in Europa.
Da un lato, la scomposizione e il riassemblaggio della governance europea in termini di stabilizzazione autoritaria della crisi; dall’altro, la sua possibile reinvenzione forzando i limiti della tecnicizzazione e della amministrativizzazione del comando che questa stessa stabilizzazione autoritaria della crisi segnano.
L’evocazione del popolo è il ritaglio sul quale si produce il primo lato della questione. Il mosaico europeo si rinazionalizza attorno ai suoi confini interni ed esterni. Di questa rinazionalizzazione il popolo sovrano – e cioè: il popolo rappresentato, secondo il paradosso per il quale la sua evocazione coincide con la sua immediata disattivazione politica – è la posta in gioco. E il migrante, lo straniero, parte decisiva per la sua configurazione reattiva.
Il popolo è il doppio speculare del migrante. Un autentico razzismo di governo, sdoganato oltre ogni minima decenza residuale, agisce come sutura dei suoi differenti livelli identificativi: al ceto medio proletarizzato, all’operaio ricattato dal rischio di licenziamento, al disoccupato delle periferie è offerto un nemico sul quale costruire l’illusione di un arresto degli stessi processi che li depauperano.
Molto più di questo, però, è qui ancora in questione. Il migrante, in quanto figura dell’autonoma mobilità del lavoro, è costruito come figura paradigmatica del soggetto da immobilizzare, da disciplinare o da espellere, qualora resista alla sua coatta inserzione nel mercato del lavoro.
Lavori socialmente utili obbligatori, lavoro gratuito, prestazione d’opera ad altissimo tasso di precarizzazione, sono offerti contemporaneamente come dispositivi di integrazione passiva per rifugiati e richiedenti asilo, ma anche come le uniche forme di una divisione del lavoro, che i minilavori previsto dal job act o l’alternanza scuola-lavoro disegnano per i precari europei, come l’orizzonte che, invece di essere attaccato e distrutto, può e deve essere, appunto, difeso. Il migrante è il modello della soggettività extracontrattuale – o oltrecontrattuale, se assumiamo che il soggetto del contratto sociale novecentesco è ormai stato definitivamente esautorato dalla riconfigurazione neoliberale della cittadinanza – che il popolo paradossalmente include come il proprio rovescio.
Nulla vi è perciò da difendere. Né il popolo, che ciascuna delle posizioni presenti sulla scena della discussione pubblica identifica secondo il proprio interesse a rappresentarlo, né il migrante, se con esso si assume la figura vittimaria presa in ostaggio dal razzismo di governo.
È questo il secondo lato della questione che evocavamo in apertura. Possiamo immaginare di dover accompagnare questo spettrale ritorno al passato? Di tornare semplicemente a difendere, anche noi, il richiedente asilo, il clandestino, il lavoratore schiavizzato nei campi, la madre ostaggio sui gommoni – figura contemporaneamente esterna e interna ai confini europei – dal razzismo e dalla stigmatizzazione che le destre (ma non solo le destre, in questo definitivo smottamento del discorso pubblico) agitano contro di lui o contro di lei? Non dobbiamo piuttosto chiederci contro chi o contro che cosa viene completamente riconfigurato il dispositivo multilivello della governance europea, sino ad includere, e non sono state certo le destre a farlo, la costituzionalizzazione delle milizie libiche o delle bande di predoni alle quali vengono di fatte delegate competenze sui confini esterni dell’Europa?
L’autonomia e la mobilità del lavoro sono ciò che da sempre traina la trasformazione dei rapporti di governo. Esse devono essere catturate e irretite, vale a dire, filtrate, gerarchizzate, certo non arrestate, per poter essere messe a valore. Di questo si tratta nelle sconnesse discussioni dei ministri dell’interno e nei balletti con i quali si riapre la discussione per una riconfigurazione dei rapporti di forza in Europa. Il populismo di governo è integralmente succube, certo non alternativo, agli interessi del capitale finanziario globale.
Un’alternativa è possibile solo organizzando autonomia e mobilità del lavoro migrante e precario. È su questo terreno che si dà la possibilità del superamento e della reinvenzione degli schemi sui quali si è storicamente realizzato il compromesso sociale fordista tra capitale e lavoro. Non è certo a spese dei migranti che un reddito di cittadinanza – nemmeno nella forma miserabile per la quale in cambio della sua concessione si dovranno offrire ore di lavoro gratuito – potrà essere conquistato.
Ciò che le lotte dei migranti ci consegnano – tanto sul piano dell’ostinazione con la quale pongono in essere il loro progetto di fuga, quanto su quello della soggettiva capacità di sottrazione alla violenza dei rapporti di produzione – è tutt’altro che un paradigma vittimario. Aprire i porti europei alle navi e costruire istituzioni complici e solidali con il loro – ed il nostro – diritto di fuga significa reinventare spazi e tempi della cittadinanza europea. Possono farlo reti municipali e sanctuary towns. Deve farlo chiunque percepisca come una gabbia il profilo spettrale del popolo.
Uscire dal silenzio significa rifiutarsi di balbettare il lessico della sovranità e del confine. E porsi all’altezza di un desiderio che mai guarda indietro e che cerca piuttosto qualcosa che non c’è mai stato prima.