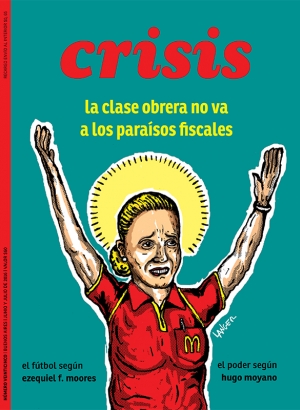Di ALESSANDRO PEREGALLI
La Bolivia è sprofondata in una crisi devastante lo scorso 20 ottobre, data delle elezioni presidenziali e legislative. Si è chiuso così il periodo di maggior stabilità politica della sua intera storia indipendente; le mobilitazioni e proteste in tutto il paese mostrano uno scenario ancora aperto che ha portato, il 10 novembre, alle dimissioni e del presidente Evo Morales e del vice-presidente Álvaro García Linera, e al loro esilio in Messico. Immediatamente, due narrative opposte si sono affermate per leggere gli eventi, tanto in Bolivia come a livello internazionale: da un lato, la sinistra, legata al “primo presidente indio” Morales, o riconducibile ai suoi alleati internazionali (di sinistra o meno, dal Messico al presidente in pectore argentino Alberto Fernández, dalla Cina alla Russia), ha affermato che si sia trattato di un classico golpe de Estado, che ha fatto fuori un presidente legittimo e legalmente rieletto e che è stato orchestrato dal Dipartimento di Stato americano, dalla CIA e dall’oligarchia boliviana. Dall’altra, la destra, tanto interna come internazionale (da Trump a Bolsonaro, e con la complicità dei “sinceri democratici” dell’Unione Europea e del partito democratico americano, con l’eccezione di Bernie Sanders), hanno sostenuto che si sia trattato della rimozione legittima di un “dittatore” che aveva falsato le ultime elezioni per farsi rieleggere.
In realtà, ciò che ha reso più complicato questo tipo di polarizzazione è stato l’emergere, nella sinistra libertaria e di matrice autonomista, di uno spettro di posizioni critiche allo stesso tempo tanto del governo di Evo come delle pulsioni classiste, misogine e coloniali emerse all’interno del movimento di protesta contro di lui. È all’interno di questo ambito che si vuole porre questo articolo, anche se con la consapevolezza che tali espressioni critiche non debbano arrivare a legittimare, come invece sembra che in certi casi facciano, letture negazioniste o tiepide sul colpo di Stato che si sta consumando in Bolivia e che, come ogni espressione di fascismo, è da respingere con forza. Pensiamo invece, piuttosto, che solo una lettura critica e autocritica del cosiddetto “processo di cambiamento” avvenuto sotto il MAS possa rivelarsi utile a una prospettiva realmente anti-imperialista.
Un’elezione illegittima
Le elezioni del 20 ottobre sono avvenute in un contesto particolarmente torbido. La quarta rielezione di Evo Morales, difatti, nasce in una realtà di palese incostituzionalità, visto che la stessa costituzione promulgata nel 2009, durante il primo mandato di Morales, stabilisce che l’elezione presidenziale di una stessa persona è estendibile al massimo per due mandati. Già nell’ottobre del 2014, Evo era stato eletto per la terza volta, ma lo aveva fatto con la giustificazione che il suo primo mandato (2006-9) era stato realizzato sotto la costituzione precedente. Tuttavia, l’incapacità cronica dei populismi latinoamericani di prescindere dalla figura del leader carismatico (il caudillo) aveva imposto, nei calcoli del partito Movimiento Al Socialismo (MAS), la necessità di garantire a Morales di poter essere rieletto a tempo indefinito. Fu così che, il 21 febbraio 2016, si tenne un referendum costituzionale per garantire proprio questa possibilità, nel quale tuttavia Morales venne sconfitto, per la prima volta dalla sua elezione nel 2005, anche se per strettissima misura. Invece di seguire l’esempio del venezuelano Hugo Chávez, che dopo una sconfitta nel referendum costituzionale del 2006 era riuscito a imporre la rielezione in un nuovo referendum nel 2009, Evo ha preferito affidarsi a un ricorso legale alla Corte Suprema, che nel 2018 gli ha garantito, in maniera sorprendente, il “diritto umano” a essere rieletto indefinitamente, violando così in modo clamoroso l’esito referendario.
In questo modo, nonostante una conclamata illegittimità, Morales si è ripresentato alle elezioni dello scorso ottobre, puntando a vincere direttamente al primo turno, per cui era sufficiente raccogliere il 40% dei voti con un distacco di 10% sul secondo candidato, in modo da evitare la situazione di polarizzazione di quasi tre anni prima, che aveva testimoniato che il leader del MAS godeva di un consenso inferiore al 50%. La sera delle elezioni, quando le proiezioni elettorali coprivano l’83.8% del bacino elettorale, Evo Morales era dato al 45.3%, appena 7 punti in più del suo avversario, l’ex presidente Carlos Mesa, al 38.2%. La decisione del Tribunale Elettorale di sospendere la pubblicazione dei dati per 20 ore durante lo scrutinio, ha scatenato le proteste degli elettori della destra che, denunciando frodi, hanno bruciato numerose sedi elettorali, cancellando tuttavia in questo modo numerose eventuali prove. Quando Morales aveva già dichiarato lo Stato d’Emergenza, il Tribunale Elettorale ha reso pubblici i risultati al 95.63% dello scrutinio che davano questa volta la vittoria di Evo con 10.12 punti di vantaggio. Il risultato si è poi stabilizzato con un differenziale di 10.57%. Di fronte alle proteste infuocate dei candidati e degli elettori oppositori, l’argomentazione del governo è stata quella che le ultime schede scrutinate provenissero dalle zone rurali, dove il consenso a Morales è statisticamente molto più alto. Si tratta senz’altro di una giustificazione credibile, tanto più che la stessa opposizione non ha potuto presentare nessun atto di scrutinio con prove di brogli. Tuttavia, il modo poco pulito con cui il governo ha gestito l’intero processo, prima con la rielezione illegale e poi con il lungo blackout del sistema di conteggio, per il quale erano state date quattro spiegazioni diverse e per il quale si era pure dimesso il vice-presidente del Tribunale Elettorale, ha creato un clima di scarsa legittimità al voto. Ed è stato grazie a questo clima che la strategia golpista ha potuto mettersi in marcia.
Il colpo di Stato
Fin dal primo giorno di proteste, il governo del MAS ha denunciato che dietro i moti dell’opposizione ci fosse un tentativo di colpo di Stato. Tuttavia, come nella famosa favola di “al lupo al lupo!”, evocare lo spettro del golpe è diventata una pratica così comune, un dispositivo così “normale” di governo dei progressisti latinoamericani, ogni qual volta vogliono liquidare in maniera sbrigativa una critica interna o da sinistra (“non vorrete mica che tornino al potere quegli altri!”) e far ingoiare i peggiori rospi, da essere diventato un’arma spuntata. Che la “sinistra” gridi al possibile golpe ogni volta che fa una cosa di “destra” è ormai la regola. Resta da capire quando purtroppo di golpe si tratti davvero, fermo restando che l’oligarchia latinoamericana non se ne sta con le mani in mano, e un colpo di Stato rientra, storicamente, nei suoi possibili strumenti e strategie.
Nel caso boliviano, il golpe si è attivato, in origine, quando il candidato oppositore Carlos Mesa, considerato, come ogni neoliberista che si rispetti, un moderato “centrista”, ha rifiutato la revisione del voto da parte dell’Organizzazione degli Stati Americani (OEA, dalla sigla in spagnolo) proposta da Morales, una piattaforma inter-governativa che si è sempre contraddistinta, e ancor più con l’attuale gestione dell’uruguaiano Luis Almagro, per promuovere una politica internazionale fanaticamente anti-bolivariana e strettamente asservita agli interessi americani. La ragione del rifiuto, tuttavia, sebbene sia stata spinta dalla volontà politica di radicalizzare la protesta sociale, è stata in parte giustificata dal fatto che la stessa OEA aveva sorprendentemente legittimato, a suo tempo, la rielezione di Morales. Fatto sta che, considerando illegittimo l’intervento dell’OEA, e nel contesto di una protesta generalizzata, socialmente variegata (non ridotta alle sole classi medie) e sempre più violenta (quasi senza repressione da parte delle forze dell’ordine, ma contrastata dai gruppi organizzati del MAS, che facevano un saldo di tre morti), il salto di qualità della strategia golpista è avvenuto il 2 novembre, quando il neo-presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, un’organizzazione oligarchica e imprenditoriale fino ad allora in accordi con il MAS, Luis Fernando Camacho, ha invocato il “ritorno di Dio e della Bibbia” nel palazzo presidenziale contro il supposto satana indigeno Evo Morales e ha pubblicamente chiesto a polizia ed esercito di ribellarsi al presidente. Solo sei giorni dopo, l’8 novembre, prima la polizia di Cochabamba e poi rapidamente tutta la polizia nazionale, si ammutinava contro il governo. Lo stesso Camacho entrava, con l’aiuto dell’esercito, a La Paz per aizzare la rivolta, mentre i suoi seguaci toglievano le bandiere della whipala (il simbolo dei popoli indigeni della Bolivia), e i poliziotti se le staccavano dal distintivo. Camacho è un imprenditore legato all’agrobusiness e alla finanza, fanatico cattolico ma con molto successo tra gli evangelici, macista (si fa chiamare macho Camacho) e seguace di Pablo Escobar; nel tentativo separatista di Santa Cruz nel 2008 aveva guidato un gruppo neonazista e squadrista chiamatoUnion Juvenil Cruceñista (UJC) ed è considerato il Bolsonaro boliviano.
Due giorni dopo l’ammutinamento della polizia, la mattina del 10, sotto pressione dello stesso Camacho, la OEA emetteva il risultato della sua revisione elettorale, in cui diceva che, nonostante non ci siano prove di frodi elettorali conclamate e capaci di condizionare il risultato, la presenza di varie piccole irregolarità nel voto e il clima sociale particolarmente teso suggerivano di realizzare nuove elezioni. Anche se alcune verifiche extra-ufficiali, come quella del Center for Economic and Policy Research (CEPR), erano intanto giunte a stabilire, invece, la piena regolarità del processo elettorale, la mattina stessa Morales convocava un nuovo suffragio entro il 20 gennaio, data in cui ufficialmente scadrebbe il suo attuale mandato. Ma la dinamica del golpe era ormai attivata: i partiti di opposizione, tanto quelli “centristi” come quelli fascisti, chiedevano ormai la caduta del governo senza se e senza ma, e anche alcuni sindacati di contadini e minatori, fino ad allora rimasti fedeli a Evo, gli suggerivano, per evitare ulteriore spargimento di sangue, di dimettersi; allo stesso tempo, i manifestanti bruciavano le abitazioni e minacciavano le famiglie di ministri e deputati del MAS (cosa avvenuta anche al contrario, da parte dei masisti nei confronti dei politici oppositori) e li costringevano a dimettersi uno dopo l’altro; infine, sotto pressione esplicita dell’esercito, nel pomeriggio di quello stesso 10 novembre Morales e García Linera, abbandonata La Paz e rifugiatisi nella regione cocalera del Chaparé, rinunciavano all’incarico. La sera stessa Camacho, pur privo di qualsivoglia carica instituzionale, annunciava l’emissione di un mandato di cattura per lo stesso Evo Morales, che il giorno dopo, insieme al vicepresidente e alla ministra della Salute, Gabriela Montaño, si esiliava a Città del Messico. L’indomani, 12 novembre, dopo le dimissioni delle maggiori cariche instituzionali del MAS, un parlamento senza quorum, perché privo della maggioranza dei deputati e dei senatori del MAS, a cui l’esercito ha impedito l’ingresso, ha votato l’elezione presidenziale della senatrice di destra, e vice-presidente del Senato, Jeanine Añez, che ha assunto l’incarico al fianco di Camacho e dichiarando che “la Bibbia è tornata nel palazzo”.
Come si è arrivati al golpe? La parabola discendente del governo Morales
Il golpe, infine, siè compiuto. Tuttavia, non si tratta né di un golpe tradizionale, con una sollevazione armata dell’esercito e sotto la completa gestione della CIA e del Dipartimento di Stato americano, come nei colpi di Stato degli anni ‘70 e in generale nel periodo della Guerra Fredda. Né si tratta di un golpe puramente parlamentare, o blando, orchestrato dalle classi padronali assieme a magistratura e parlamento grazie a strategie di lawfare, e con il consenso passivo dell’esercito e degli Stati Uniti, com’è avvenuto nelle recenti rimozioni del presidente dell’Honduras Manuel Zelaya nel 2009, di quello del Paraguay Fernando Lugo nel 2012, e di quella del Brasile Dilma Rousseff nel 2016. Si è trattato, in questo caso, di un golpe “civico-poliziesco-militare”, in cui è ancora poco chiaro il peso specifico, l’intenzionalità e il contributo dei vari attori: partiti d’opposizione, protesta popolare, grande capitale, gruppi paramilitari, polizia, esercito, governi americano e brasiliano, OEA.
Quello che si può affermare è che il golpe non è mai sparito dalle strategie reazionarie latinoamericane, ma che la sua possibilità di attuazione o meno, in un contesto di post-Guerra Fredda e di indebolimento nella capacità di intervento diretto degli USA nella regione, dipende sempre più dal grado di illegittimità sociale che si riesce a costruire attorno al governo da abbattere, com’è risultato più che evidente in tempi recenti in Brasile. Com’è evidente, il governo di Evo Morales si reggeva, a livello formale-instituzionale, su basi di legittimità fragili, ma queste rispecchiavano, ovviamente, condizioni materiali e sociali ancora più precarie.
Nonostante indici economici di crescita che nei quasi 14 anni di governo Morales hanno registrato una media del 4.9% annuo, portando il PIL da 9 a 42 miliardi di dollari, la qualità di questi numeri ha tuttavia aperto sempre più importanti crepe nella base sociale del MAS. In generale, si potrebbe parlare di due fasi del governo di Evo. Durante il primo mandato, pur in mezzo a mille contraddizioni, il MAS ha portato avanti un’agenda di riforme radicali che sono state il prodotto di una sintesi dei diversi settori sociali che prima, con la Guerra dell’Acqua nel 2000 e con la Guerra del Gas nel 2003, hanno aperto una crepa nella gestione governamentale neoliberale, e poi hanno sostenuto e portato al governo lo stesso MAS, partecipando al suo interno. Come infatti segnala Raúl Zibechi, tra 2002 e 2006 si era formato il Pacto de Unidad tra le principali organizzazioni indigene e contadine in appoggio a Evo: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” e associazioni di quartiere di El Alto. Questa felice sintesi, a cui bisogna aggiungere i sindacati dei minatori, aveva portato a quattro grandi traguardi: la convocazione di un’Assemblea Costituente, che sfociò nel 2009 nella creazione della nuova Costituzione dello Stato Plurinazionale di Bolivia; la nazionalizzazione delle riserve di gas; la riforma agraria; e una serie di leggi in tutela della Madre Tierra e dirette a cambiare il regime produttivo del paese in senso ecologico.
Tuttavia, a partire dal 2008-10, questi passi avanti si sono realizzati, concretamente, in vittorie poco più che formali. La causa principale è stata l’esito del conflitto che ha visto contrapporsi il governo e l’oligarchia di Santa Cruz e delle Tierras Bajas, che chiedevano l’autonomia nella gestione dei proventi del gas, contrastavano la riforma agraria e arrivarono sull’orlo di scatenare una guerra civile con milizie paramilitari. Solo con l’intervento del presidente brasiliano Lula da Silva il conflitto si ricompose, ma al patto di un’inclusione del Comité Cívico de Santa Cruz nel MAS e nella piattaforma governativa, e con l’accettazione delle imprese brasiliane di costruzione e di Petrobras per i progetti vincolati all’Iniziativa per l’Integrazione dell’Infrastruttura Regionale Sudamericana (IIRSA). Ma un’altra causa è stata il lento ma inesauribile slittamento dell’asse del “processo di cambiamento” dai movimenti sociali verso lo Stato e le sue logiche di accumulazione di potere e privilegi. La costituzione avrebbe dovuto portare a una messa in discussione dell’autoritarismo statale sulle comunità indigene, ma nei fatti non ha impedito che l’autonomia di queste ultime venisse perennemente violata da politiche statali di estrattivismo, di cooptazione e di burocratizzazione. Nel giugno del 2012 – racconta Zibechi – la CIDOB, che aveva abbandonato l’anno precedente il patto d’unità, si è vista infiltrata e pesantemente divisa dall’azione governativa, mentre nel 2013 dei dissidenti della CONAMAQ, altra organizzazione che aveva rotto con il MAS, affini a quest’ultimo, hanno provato a impossessarsi dell’organizzazione con la forza e con l’aiuto della polizia.
La riforma agraria, dal canto suo, avrebbe dovuto togliere terre ai latifondisti, ma si è poco a poco snaturata: da un lato, i latifondi venivano per lo più preservati, mentre era sempre più incentivata, anche con sussidi statali, la produzione di soia transgenica, giunta nel 2012, secondo Pablo Solón1, al 92% della produzione (contro il 21% nel 2005). La maggior redistribuzione di terra è occorsa invece ai danni dell’espansione della frontiera agricola in Amazzonia, portata avanti da una serie di incendi dolosi ma consentiti dal governo, che hanno favorito tra le altre cose anche il settore dell’allevamento intensivo. Lo scorso agosto questo processo si è reso evidente con gli incendi nella regione di Chiquitanía, con cui la Bolivia ha fatto a gara con il Brasile di Bolsonaro nella distruzione del cosiddetto “polmone del mondo”. D’altra parte, la politica agraria ha beneficiato particolarmente, tra gli indigeni, i coltivatori di coca del Chaparé, il che ha trasformato la produzione di coca, poco a poco, da un giusto diritto dei popoli originari di preservare una tradizione agricola che non deve essere criminalizzata, al trasformarsi di quest’ultima in una vera e propria commodity, assoggettata alle catene del valore del narcotraffico globale, e con importanti ripercussioni nell’estensione della frontiera agricola verso zone a bassa quota, con il conflitto tra gli indigeni cocaleros di origine aymara e quelli amazzonici o delle cosiddette Tierras Bajas.
Anche nel caso del gas, non si può parlare di vera e propria nazionalizzazione, ma piuttosto di una, comunque positiva, rinegoziazione dei contratti, che ha permesso di ridurre della metà i profitti delle multinazionali rispetto alla quota in mano allo Stato, ma aumentando i loro guadagni reali, mentre attualmente il 75% della produzione di gas boliviano è nelle mani di Petrobras e dell’impresa spagnola Repsol2.
Infine, le leggi in difesa dell’ambiente e della Pachamama, come la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, sono rimaste di fatto lettera morta, mentre nuove concessioni minerarie venivano continuamente rilasciate a multinazionali straniere, e venivano promossi progetti di grandi infrastrutture ecologicamente devastanti, come l’autostrada che doveva passare sul Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), fermata da un’imponente mobilitazione popolare nel 2011.
A fronte di queste enormi sconfitte rispetto agli immaginari di socialismo comunitario e di buen vivir suscitati dal governo Morales, alcuni passi avanti innegabili devono essere riconosciuti: soprattutto grazie ai proventi pubblici del gas, passati da 673 milioni di dollari nel 2005 a 5,45 miliardi nel 20133, sono state promosse importanti politiche sociali, che hanno permesso una forte riduzione dei tassi di povertà estrema dal 38 al 15% della popolazione, sono state promosse politiche di accesso massivo all’università, una trasformazione dei piani e metodi di studio di quest’ultima più in linea con le necessità delle comunità indigene, la creazione di una rete di radio comunitarie (che, come segnalato da Adriana Guzmán, sono state tra i primi bersagli attaccati dal colpo di Stato e dalla nuova presidenta Añez), il miglioramento delle infrastrutture nelle comunità indigene e una riforma importantissima che ha garantito l’accesso universale alla salute pubblica. Un altro piccolo passo avanti è stato il fatto che, a fronte comunque di una tendenza all’aumento delle politiche estrattive, c’è stato il tentativo di internalizzare alcuni processi produttivi e di aumentare il valore aggiunto di alcune materie prime esportate. Infine, come ha giustamente affermato il vice-presidente esiliato e intellettuale marxista García Linera, si è venuta a creare, grazie a una gestione corporativa e di inclusione sociale della macchina statale, una nuova classe media di origine indigena, che ha in parte estromesso la classe media tradizionale bianca, causando un forte senso di risentimento sociale e razziale in quest’ultima. Tuttavia, come ha argomentato Solón4, la crescita di questa nuova classe media, se non è accompagnata da un processo di politicizzazione, rischia di produrre solo nuovi gruppi di potere nei municipi, nei ministeri pubblici, nelle imprese, nelle Forze Armate e nei sindacati, più interessati alla distribuzione interna dei nuovi margini di lucro che alla trasformazione sociale radicale.
In sintesi, quello a cui si è assistito in questi 14 anni in Bolivia è stato un lento slittamento dalla centralità di un conflitto di carattere politico-sociale a uno di tipo geo-politico, in cui il governo si è legato sempre più a interessi imperialisti alternativi agli USA (prima il Brasile, poi la Cina) e a piattaforme regionali progressiste come quella guidata dal Venezuela, ma che ha visto la lotta di classe ammorbidirsi sempre più, fino alla fusione tra l’agenda governativa e alcuni interessi oligopolistici come quelli minerari, finanziari e dell’agro-business. Ciò nonostante, sarebbe ingiusto negare gli importanti successi sociali raggiunti sotto il MAS, ed è proprio contro quelli che si è scagliata l’agenda golpista, intenzionata a speculare sul diffuso malessere sociale rappresentato dai limiti governativi per far arretrare le condizioni e i diritti sociali a 14 anni fa.
E ora? Composizione di un conflitto ancora aperto
La crisi in atto in Bolivia si è risolta, almeno per ora, con un colpo di Stato oligarchico e dai connotati imperialisti, simbolicamente rappresentata dalla repentina decisione della nuova presidenta Añez di rimandare a Cuba i medici presenti nelle missioni, di uscire dall’Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) e dalla messa in discussione dell’Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) Tuttavia, sarebbe sbagliato pensare che nel conflitto in corso i settori sociali si siano suddivisi, o si suddividano, lungo una chiara linea sinistra-destra o classi medie e borghesia contro classi popolari. Come ha segnalato ancora una volta Solón, se da un lato è indubbio che i settori della destra reazionaria si sono scagliati contro Evo, e che a Santa Cruz questi settori siano egemoni, in altre zone le proteste contro i brogli hanno visto articolazioni variegate di settori di destra e sinistra: a Potosí l’opposizione al governo si era radicalizzata prima delle elezioni per via di una concessione di 70 anni per la produzione di litio nel salar di Uyuni, dove si è scoperto il maggior giacimento al mondo di questo minerale; queste proteste hanno sia una matrice ecologista che una corporativa da parte dei minatori, intenzionati a mantenere nella regione quote dei proventi per l’esportazione del litio. Nel caso di La Paz, importante è stata la presenza nelle manifestazioni di studenti dell’università pubblica e di gruppi ambientalisti che fino al conflitto del TIPNIS lavoravano per il governo. Infine, la gestione autocratica di quest’ultimo ha fatto in modo che, nella fase di accumulazione di forze dei settori golpisti, le principali organizzazioni sociali di riferimento del MAS o critiche non avessero reagito in maniera efficace, proprio per via del lungo processo di cooptazione, corporativizzazione e indebolimento subito negli anni passati e per la totale mancanza di una prospettiva di emancipazione nella difesa del governo: dopo tanti anni di tradimenti di Morales, in fin dei conti, perché valeva la pena accorrere in sua difesa?
Queste organizzazioni, in primo luogo proprio i cosiddetti Ponchos Rojos della CONAMAQ, le organizzazioni di quartiere di El Alto, le femministe antipatriarcali di Mujeres Creando e i cocaleros del Chaparé e di Cochambamba, sono però insorte in seguito alle dimissioni di Evo, hanno assediato le principali città con blocchi stradali nelle vie d’accesso e hanno chiesto con forza il ritorno dell’ordine costituzionale, il rispetto per la whipala ed elezioni immediate, cercando di frenare e di sabotare il progetto golpista. Ad oggi, a una settimana dal levantamiento indigeno, l’esercito, a cui il nuovo governo ha garantito l’immunità per gli assassini compiuti nell’ambito della repressione, ha risposto con forza, con un saldo di già 24 morti. Fuori gioco (per ora) Evo Morales, consumatosi (per ora) il colpo di Stato, sono ancora una volta i popoli originari, principali artefici del “processo di cambiamento”, a riportare l’asse del conflitto sul terreno della lotta di classe.
1 Pablo Solón, Algumas reflexões, autocríticas e propostas sobre o processo de mudança na Bolívia, em AA.VV., O eclipse do progressismo. A esquerda latino-americana em debate, Rio de Janeiro: Elefante, 2018, p. 67.
2 Ibidem, p. 71.
3 Ibidem.
4 Ibidem, pp. 69-70.