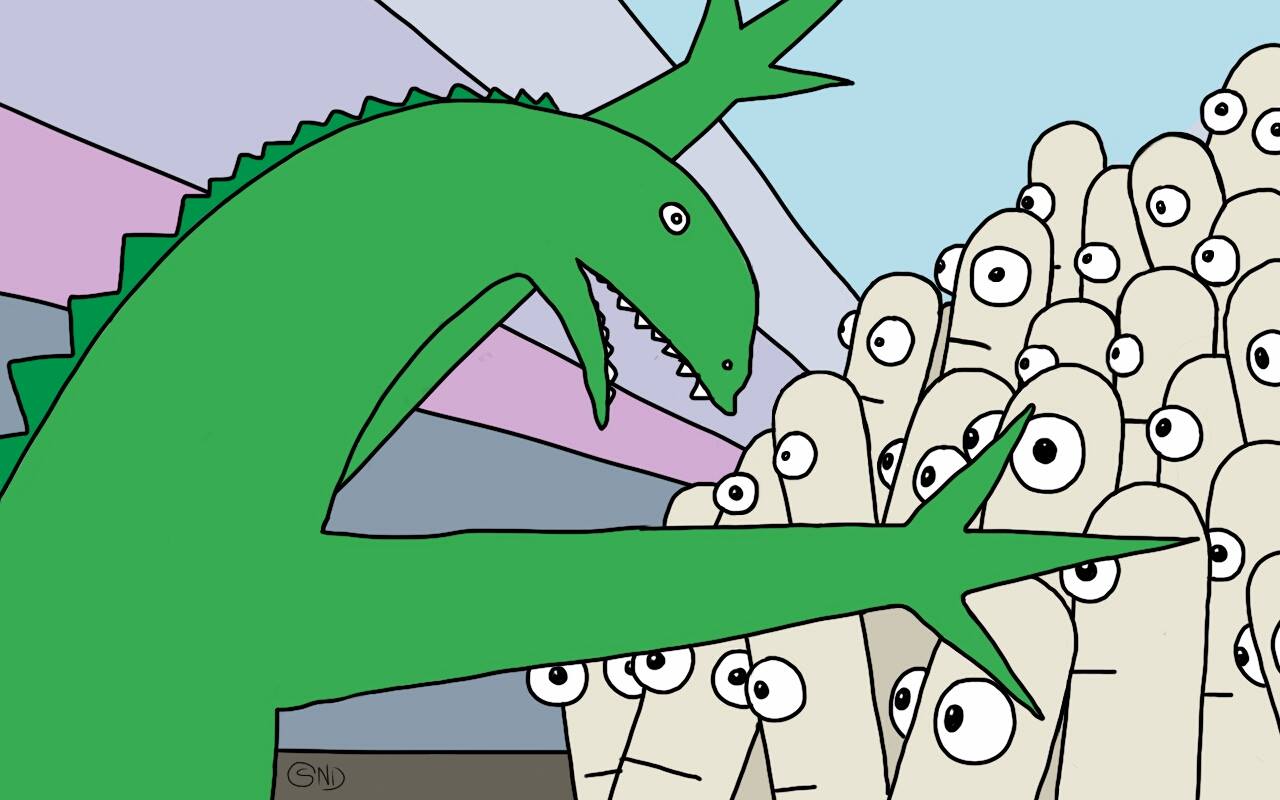di GIROLAMO DE MICHELE.
A mente fredda, per quanto possa esserlo, alcune affermazioni sono necessarie e doverose.
Primo: i palestinesi non sono terroristi, gli israeliani non sono coloni. Sono due popoli, al cui interno ci sono molteplici differenze che non si lasciano rinchiudere in un’etichetta. Identificare un intero popolo con una sua parte, con una fazione, con uno stile di vita, con una posizione politica, è una pratica fascista. Assegnare un’etichetta significa cancellare la vita che si agita dietro il cartellino col nome: una pratica utile a eliminare la vita rimuovendo la responsabilità e il senso di colpa, se si ha la forza di dimenticare la differenza fra un bersaglio e un essere umano. Ma chi non è capace di questa differenza non è un essere umano.
Secondo: per chi ha un’età e un vissuto cui i nomi di Tell-al Zaatar e Sabra e Shatila significano qualcosa, è il massimo dell’orrore vedere i sopravvissuti di quei massacri agire come i massacratori dei loro padri. Tal quale lo è vedere i discendenti degli scampati ai lager e ai pogrom europei costruire lager, compiere pogrom nei villaggi, colpire mercati e abitazioni civili con lo stesso disprezzo per l’Altro dei carnefici europei dei loro avi.
Terzo: chi, davanti alle carneficine in corso, esulta come per un goal della propria squadra, non importa quale; chi segue il crescere delle cifre dei morti, ormai a quattro cifre da ciascuna delle due parti, sperando che l’una sopravanzi l’altra; chi sfrutta il macello in corso per regolare vecchi conti nell’OK Corrall dei social; chi stila liste di proscrizione degli amici di-, non importa se Hamas o Netanyahu, per sovrapporle alle liste degli amici di Putin o Zelenskyj, non è degno di considerazione o interlocuzione.
Non è facile ragionare, nella consapevolezza che mai come in questo momento – ancor più che rispetto alla guerra in Ucraina – le parole sono impotenti davanti al linguaggio delle armi e alla ferocia che muove le dita che tirano i grilletti. Ma siamo della vecchia scuola, quella educata, più che all’accettazione della impossibilità di dominare tutte le maree del mondo del vecchio saggio Gandalf, al giovane filosofo ebreo-olandese: Sedulo curavi humanas actiones non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere, mi sono sempre curato di imparare a non ridere delle azioni degli uomini, non piangerne né non odiarle, ma comprenderle. Con la consapevolezza che per ambedue il fine è la salvezza degli anni nei quali viviamo, per lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare, proviamo a mettere in fila alcuni pensieri.
Che Hamas sia o no un’organizzazione terroristica non è una questione nominalistica, perché i nomi conseguono dalle cose, ma non è mai banale il costituirsi del nesso fra le une e le altre. Non c’è bisogno di usare la parola “terrorismo” per dire che le azioni compiute da Hamas alla festa dei mondi paralleli (il rave party nel deserto del Negev) e nel kibbuz di Kfar Aza hanno toccato soglie di orrore per quali non è pensabile alcuna giustificazione o attenuante, perché non c’è antecedente o causa storica che possa giustificare la concezione della vita, del corpo delle donne, del diritto al futuro che ha mosso i carnefici: neanche, sia chiaro, il fatto che questi diritti sono parimenti negati a un popolo in catene sulla sua terra da anni. Ma “organizzazione terroristica” indica uno status di banda armata capace di azioni terrorizzanti estemporanee, e al tempo stesso sottende una superiore o esterna capacità politica: la longa manus iraniana, per dire. L’azione dispiegata da Hamas, la sua progettazione, il numero di combattenti messi in campo, il quantitativo di razzi usati indicano non una banda, ma un esercito; così come il consenso di cui di fatto Hamas gode indicano un partito politico che agisce come il governo di uno Stato, con una propria capacità politica in grado di interferire in modo significativo con la diplomazia saudita, e anche iraniana. Dire che Hamas agisce come uno Stato non significa legittimarne le azioni o attenuarne la brutalità: serve, piuttosto, a ricordarci che gli Stati sono questo; che gli Stati non sono l’esercizio legittimo della violenza che asciuga e governa il terrore dalla società, ma sono capaci di terrorismo. La differenza fra Stati “democratici” e Stati autoritari, o autarchie, o dittature è meno significativa di quanto appaia agli ingenui: il fatto che Hamas avviava il macello nei giorni in cui in Italia si ricordava l’ecatombe del Vajont, con tutto quello che il Vajont ha significato, dalla secretazione governativa degli atti alla messa in campo di una macchina di propaganda, dall’azione legale dell’ex Primo Ministro e futuro Presidente Leone (il codicillo della commorienza) dovrebbe dire qualcosa. Così come dice tutto il fatto che negli stessi giorni in cui Hamas organizzava lo sfondamento delle barriere di confine i Primi Ministri dell’UE si riunivano per decidere quali restrizioni apportare al diritto di fuga e migrazione nel Mediterraneo, cioè qual è il numero dei naufragi e degli annegamenti da aggiungere a quelli già in atto accettabile come mediazione fra i governi in vista delle prossime elezioni europee.
Nell’interpretare la guerra russo-ucraina come un Risiko nel quale ci si schiera con i “buoni” contro i “cattivi” si finisce per dire che ci sono Stati “buoni”: il farsi Stato di Hamas, e l’esercizio della rappresaglia di Stato di Israele, ci ricordano che nessuno Stato è in sé buono.
La brutalità delle azioni di Hamas nel Negev e a Kfar Aza sono, nella scala degli orrori, una novità: né Hamas, né alcuna altra organizzazione combattente palestinese, avevano finora adottato i metodi dei fascio-jihadisti: il macello al rave parti è un Bataclan 2.0. Questa novità va colta in tutta la sua gravità, all’interno della concorrenza nel consenso che le formazioni jihadiste fanno da tempo ad Hamas, che ha scelto di assumerne i metodi per dimostrare di essere alla loro altezza, per così dire. La preannunciata rappresaglia “senza precedenti” dell’esercito israeliano è costretta entro un doppio vincolo: non può non eliminare, o quantomeno ridimensionare in modo significativo Hamas, ma al tempo stesso non può fare a meno di Hamas, perché l’alternativa alla sua eliminazione sono gli jihadisti. Un analogo doppio vincolo attanaglia i partiti politici israeliani: non è pensabile il permanere dell’attuale governo di estrema destra, ed è sotto ogni aspetto positivo che i fanatici fascio-sionisti che hanno condizionato, con evidente impreparazione politica e militare, la politica israeliana escano dalla stanza dei bottoni. Al tempo stesso un governo di unità nazionale, che inevitabilmente allude a una politica finalmente capace di liberarsi dalla necessita di Natanyahu, non può che formarsi per sostituire al linguaggio della politica quello delle armi, come di fatto sta già accadendo: cioè netanyahuizzarsi, rendendo in parte irrilevante la presenza o meno dello stesso Netanyahu. È però un fatto che una parte dell’opinione pubblica israeliana è concorde nel ritenere Netanyahu il responsabile della crisi in atto. Rimuovere Netanyahu dalla scena politica israeliana è la conditio sine qua non per un’alleanza di governo che sia in grado di porsi la questione della pace. Questione difficile da costruire, perché al di là delle risoluzioni ONU e degli accordi fra le parti, si tratta di affrontare con la necessaria capacità politica il problema degli insediamenti in Cisgiordania, senza il cui allontanamento persino la (peraltro discutibile) ipotesi “due popoli, due Stati”, da alcuni ritenuta ancora possibile, sarebbe impraticabile.
Al momento sembra difficile ipotizzare una soluzione che non sia foriera di ulteriori catastrofi. Nondimeno, qualche flebile segnale può essere colto. In Israele si è manifestata, negli ultimi mesi, una mobilitazione di massa contro la deriva fascisteggiante delle riforme costituzionali portate avanti dal governo di estrema destra. È evidente che questo movimento viene bloccato dall’azione di Hamas e da tutto ciò che ne è seguito e seguirà: tuttavia questo movimento esiste, e può far sentire la sua voce in futuro. Così come lo specchietto per le allodole, o presunto tale, con cui Hamas ha ingannato governo e servizi israeliani, cioè la trattativa per un aumento del numero di operai palestinesi autorizzati a uscire dai confini, indica comunque un dato: l’insostenibilità, all’interno della striscia di Gaza, delle condizioni di vita nei termini in cui Israele e Hamas le costringono. È indubbio che la durissima rappresaglia indiscriminata cui la popolazione di Gaza sarà sottoposta aggraverà il problema, rendendo ancor più difficile la mediazione che Hamas deve esercitare fra esercizio della forza militare e governo delle vite nel quotidiano.
È significativo che nei commenti ricorrano con frequenza le menzioni e le traduzioni di analisi ed editoriali di un quotidiano come “Haaretz”, che talvolta è stato considerato estremista, o addirittura filo-arabo. Così come colpisce che qualche barlume di ragionevolezza traspaia persino sulla stampa mainstream, in passato embedded in modo quasi unilaterale in analoghi frangenti. Senza scomodare malmasticati versi di grandi poeti sulla salvezza che dimora nel pericolo, si può cominciare a tessere qualche ordito, se non una tela, che parta da un rovesciamento dell’ordine del discorso attuale: che un orizzonte sovradeterminato dalla guerra senza alternative, nel quale ci si schiera per necessità abdicando a principi considerati ormai sorpassati, può essere rifiutato cercando di pensare le condizioni della pace come valore non astratto o ideale, ma come condizione materiale di vita dei popoli. Condizioni materiali vuol dire che è ora di finirla di farsi vicendevoli fellatio (cit.) con la geopolitica, come se ci fossero governi o partiti che non abbiano le mani sporche di sangue, e immaginare delle pratiche dal basso in grado di esercitare pressione sui centri decisionali: senza illudersi che questa capacità si possa dare adesso, ma nella convinzione che bisogna cominciare a interrogarne le condizioni di possibilità. Cioè a cercare il futuro possibile all’interno del reale attuale. La constatazione che la catastrofe umanitaria cui andrà incontro la popolazione di Gaza nei prossimi giorni – anche ammesso che non ci siano ulteriori scenari di guerra che si apriranno in una fase successiva – non potrà che ripercuotersi sulla crisi migratoria in atto, aggravando la pressione dei flussi migratori sull’Europa meridionale. Diritto di fuga e di esistenza contro Fortezza Europa: questo è lo scenario più probabile. Su questo terreno, in diversi contesti – compreso quello giuridico, dalla disapplicazione del decreto Cutro al ribaltamento all’assoluzione di fatto di Mimmo Lucano – è possibile, perché di fatto accade, costruire e rafforzare forme di opposizione, alleanze, casamatte resistenziali; è pensabile e possibile estendere reti e alleanze sul piano europeo; è possibile, perché già accade (ad esempio con le missioni di Mediterranea in Ucraina), connettere la solidarietà verso i migranti con la solidarietà verso esseri umani vessati dalla guerra. Su questo terreno è possibile immaginare una costruzione europea delle soggettività resistenti che sappia guardare all’altra sponda del Mediterraneo, interloquendo e creando connessione anche con donne e uomini di Palestina e Israele, fornendo una sponda europea e un orizzonte di senso alle soggettività che sfuggono alla tenaglia Hamas-Netanyahu.
È un compito lungo, faticoso, e tutt’altro che certo nell’esito, di sicuro è molto più facile e immediato fare il leone da tastiera sui social. Possiamo però dire, almeno, che la semplicità che è difficile a farsi è parte della nostra storia e della nostra cultura, è un abito che non intendiamo dismettere?