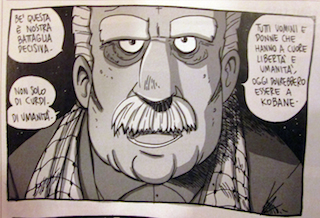di SANDRO CHIGNOLA.
Impiantare la verticalità dell’organizzazione sull’orizzontalità dei movimenti, si è detto. Bene. Forse vale la pena tornare su quest’espressione per provare a chiarirne il senso. Ciò a cui pensiamo non cambia nulla di ciò su cui abbiamo insistito in questi anni. Per dirlo altrimenti, e forse in modo ancor più radicale, il piano della critica della rappresentanza politica su cui ci siamo assestati negli anni – anche in momenti nei quali altri pensava di poter sfruttare il momento favorevole e capitalizzare una rendita di posizione impancandosi a portaparola dei movimenti o di quello che allora si chiamava il «movimento dei movimenti» – definisce per noi un punto inaggirabile. Quando parliamo di verticalità non parliamo di rappresentanza, ma di vettori organizzativi, di forza, di dinamiche costituenti. Vale allora la pena di chiarire un paio di cose. La prima: il processo rappresentativo alimenta processi di spoliticizzazione nell’esatta misura in cui lavora alla produzione di sintesi unitarie. La seconda: è il modo in cui vengono evolvendo equilibri politici e costituzionali che si assestano oltre gli assetti classici della rappresentanza politica a marcare il punto di soglia che ci spinge a confrontarci con la riemersione del fatto di governo.
Il primo punto è essenziale. La logica della rappresentanza politica, sin dai suoi esordi teorici in Thomas Hobbes, muove non già dall’idea di un «mandato» – come invece vorrebbero tutt’oggi i fautori della democrazia diretta –, ma da quella dell’«autorizzazione». Rappresentare significa «personificare» è non già trasmettere un messaggio o portare la parola di qualcun altro. Ciò che si presentifica attraverso l’azione rappresentativa è un assente, perché il rappresentante, autorizzato a ciò da chi lo ha evocato o eletto, è libero di prendere le decisioni che crede, dato che il soggetto rappresentato non ha realtà, né esistenza politica, al di fuori o prima del suo essere, appunto, rappresentato. L’esistenza di una volontà generale è possibile solo nell’operazione che la sintetizza come un Uno; come il prodotto di una fictio giuridica. Può sembrare complicato, ma non lo è più di tanto: una legge viene promulgata «in nome del popolo italiano» dal Parlamento in cui si rappresenta appunto una volontà collettiva, quella del popolo, che esiste solo per mezzo della sua rappresentazione da parte degli eletti – e cioè: dei rappresentanti – che esso ha «autorizzato» a parlare in suo nome, ritraendosi poi in una sfera di esistenza prepolitica o «privata». Come ebbe modo di dire un grande reazionario come Tocqueville: in democrazia si esce in fondo dalla servitù una volta ogni tanto per eleggere il proprio padrone e per rientrarvi immediatamente dopo. Poco varrebbe insistere su questo dato e ricordare che sarebbe per noi ferocemente contraddittorio inseguire i movimenti – movimenti il cui statuto stesso eccede la rappresentanza politica e la cui dinamica costituente si produce sempre, e con maggior potenza ora, al di fuori e di fronte ai governi e alle rappresentanze di partito – per ottenere l’autorizzazione a parlare per loro conto. La verticalità che evochiamo non è e non può essere di tipo rappresentativo.
Vale la pena, piuttosto, insistere sul secondo dei due punti sui quali richiamavo l’attenzione in apertura. Se c’è qualcosa che caratterizza la più recente evoluzione degli assetti istituzionali è il loro assestarsi in direzione governamentale e postrappresentativa. È il modo in cui il comando viene esercitandosi sui molti e differenti livelli che lo caratterizzano nelle sue forme contemporanee, ciò che mi sembra marcare questa tendenza. Sempre di più, e tanto più in Europa, dove esso si ammanta di competenze non delegate e non delegabili, dove esso si caratterizza per profili di alta tecnicità e recluta expertises indipendenti, dove esso opera in termini amministrativi e con richieste o con Diktat che prevalgono sulle scelte e sulle politiche nazionali assegnando un ruolo marginale e residuale ai singoli parlamenti, il potere si ritira e si concentra in istituti e in autorità la legittimità della cui azione si indirizza al futuro (e cioè: sul successo che essa promette di realizzare) e non si fonda sul passato (il modo in cui le decisioni che la mettono in moto si sono formate, secondo le procedure classiche della democrazia rappresentativa). L’autonomia del politico si fa a quest’altezza pura rivendicazione dell’azione di governo. Un’azione di governo sciolta da qualsiasi forma di controllo e commisurata soltanto alla propria promessa di efficacia.
Abbiamo già avuto modo di discutere in altra occasione come questa «governamentalizzazione» del potere sia stata consapevolmente prodotta proprio allo scopo di intervenire su quella che, dopo la grande stagione di mobilitazione degli anni ’60, veniva interpretata come una «crisi» di governabilità della democrazia. I parlamenti erano diventati il recettore di claims e di rivendicazioni che non erano letteralmente più in grado di processare e le maggioranze di governo decisamente troppo difficili da comporre. «Governamentalizzare» le istituzioni avrebbe significato poter sciogliere la situazione di stallo reclutando comitati e competenze all’azione di governo, risignificando il termine democrazia (o quello di riforma) in senso efficientista e tecnocratico. E non è certo un caso che, una volta resosi evidente l’assestamento di questa nuova tecnologia, un autore attento al presente come Michel Foucault, potesse salutare l’ingresso nell’epoca della «governamentalità».
Ciò che però rileva di questo passaggio – ed è ovviamente questo che ci interessa – è che cosa ciò sia venuto a significare sul rovescio di questo processo e cioè sul lato del «governato». In che modo questa figura entra prepotentemente sulla scena tra la fine degli anni ’70 e la prima metà degli anni ’80, marcando la linea di fuga che si tratta di provare a catturare e a ricomporre? In un testo dei primissimi anni ’80 è sempre Foucault a tentare di tracciarne il profilo. Non soltanto le resistenze attraversano come forze il campo che il potere si sforza di perimetrare, ma quelle che si esprimono in quella che egli identifica come l’«epoca dei governati» caratterizzano quest’ultima a partire dal lato soggettivo del genitivo: è cioè l’irruzione del «governato» come figura eccedente le sintesi rappresentative (il falso universale repubblicano del «popolo»; il Partito come macchina organizzativa cui si debba indiscussa fedeltà; i quadri della cittadinanza democratica e il loro fare astrazione dai corpi, dalle differenze di genere, dall’inscrizione dei singoli e delle singole in ambienti di regolazione parziali e stratificati che possano essere immediatamente politicizzati e attraversati da campagne e da lotte) ciò che sospinge alla risignificazione del potere nel senso del «governo».
Vale forse la pena insistere un momento su questo punto. Le lotte che segnano l’epoca dei governati – e sono proprio esse a riorientare la genealogia e l’analitica del potere foucaultiana – mostrano caratteristiche che le rendono molto differenti dalle lotte dell’operaio massa che avevano in precedenza costretto il capitale al compromesso fordista. Ci dice Foucault: sono lotte trasversali e che politicizzano desideri e bisogni: la «vita» in senso largo. Sono lotte an-archiche nel senso che esse sono del tutto disinteressate al tema classico della conquista del potere. Sono lotte – e il riferimento va alle lotte delle donne, del movimento gay, di quello antinucleare e ambientalista che in quegli stessi anni, dopo la crisi petrolifera, sabota i progetti di riconversione della produzione dell’energia, il riferimento va alle lotte dei movimenti radicali in Europa e negli USA – che non cercano un nemico ultimo, ma quello più prossimo e immediato che esse incontrano sui molti ed eterogenei livelli della circolazione del potere. Esse mettono di nuovo di fronte il «governato» – la donna il cui corpo si pretende di trattenere ad una cura di tipo patriarcale, l’abitante di un territorio che deve essere attraversato da un trasporto di scorie nucleari, la potenza destituente esercitata nei confronti della socialdemocrazia e del suo supposto compromesso progressivo tra capitale e lavoro, che si esprime nel rifiuto del lavoro dei giovani proletari, l’esodo dei migranti, il diritto di fuga di quest’ultimi, che riconfigura le geografie coloniali – e il «governo», inteso quest’ultimo come la macchina amministrativa e decentrata che con il primo si confronta.
«Governare» significa in questo senso affrontare in permanenza il «governato» come una resistenza che deve essere vinta e superata, ma della quale non si può fare astrazione come invece è possibile fare quando si proceduralizza la decisione e la si fa parlare per nome e per conto del generale di una volontà per definizione irresistibile. E ancora: «governare» significa dover operare con la consapevolezza che il fatto di governo mai si esaurisce su di un unico livello, né può tagliare l’ellisse che lega nella riproduzione di un confronto aperto governo e governato.
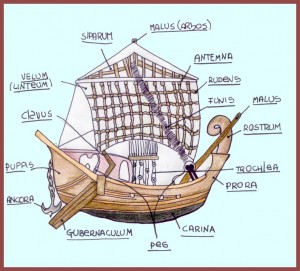 Governo è una parola antica del lessico politico occidentale. Così come l’ellisse è una figura chiave della storia costituzionale. Per secoli, in epoca preassolutista, principe e ceti si affrontano in assemblee che sono, nella ricostruzione di molti storici delle istituzioni, il motore della giuridificazione in Occidente. Si tratta in quel caso di un confronto che convoca governante e governato l’uno di fronte all’altro per misurarne la forza. Le prime carte costituzionali vengono concesse su iniziativa dei ceti e come riconoscimento della loro potenza sociale. Potrebbe allora dirsi: è l’incitamento reciproco – non la neutralizzazione o la spoliticizzazione dei singoli per opera del dispositivo di rappresentanza – a trainare il movimento dell’ellisse di governo. Storicamente sono i ceti, i governati, ad incitare i principi e a costringerli a redarre statuti e carte che riconoscano libertates e immunità. E viceversa, è l’incitamento che i principi esercitano sui ceti, cercando di trattenerli al confronto e di «governarne» l’altrimenti irriducibile resistenza, ciò che concorre a tracciare il contorno dell’ellisse.
Governo è una parola antica del lessico politico occidentale. Così come l’ellisse è una figura chiave della storia costituzionale. Per secoli, in epoca preassolutista, principe e ceti si affrontano in assemblee che sono, nella ricostruzione di molti storici delle istituzioni, il motore della giuridificazione in Occidente. Si tratta in quel caso di un confronto che convoca governante e governato l’uno di fronte all’altro per misurarne la forza. Le prime carte costituzionali vengono concesse su iniziativa dei ceti e come riconoscimento della loro potenza sociale. Potrebbe allora dirsi: è l’incitamento reciproco – non la neutralizzazione o la spoliticizzazione dei singoli per opera del dispositivo di rappresentanza – a trainare il movimento dell’ellisse di governo. Storicamente sono i ceti, i governati, ad incitare i principi e a costringerli a redarre statuti e carte che riconoscano libertates e immunità. E viceversa, è l’incitamento che i principi esercitano sui ceti, cercando di trattenerli al confronto e di «governarne» l’altrimenti irriducibile resistenza, ciò che concorre a tracciare il contorno dell’ellisse.
Torniamo allora alla verticalità e all’orizzontalità dalle quali siamo partiti. Di che verticalità e di che orizzontalità si tratta? Dovrebbe essere ormai chiaro che non si tratta della verticalità propria alla dimensione rappresentativa. E ancora, che quando si parla di orizzontalità dei movimenti non si parla di pratiche radicalmente democratiche votate alla dispersione proprio qualora non si articolino ad una rappresentanza. Al contrario, si tratta di pensare (e di praticare) una relazione organizzativa che faccia leva da un lato sull’autonomia dei movimenti, sulla loro capacità di imporre agende, sulla diffusività dei processi di soggettivazione dei «governati» e sul loro tracimare i perimetri dell’assoggettamento e della codificazione e dall’altro sulla capacità di tenuta di istanze della durata (quello che potremmo chiamare il «governo» dei movimenti, di nuovo nel senso soggettivo del genitivo) senza che il rapporto di «incitamento» venga interrotto o chiuso.
Detto altrimenti, si tratta di pensare in maniera totalmente diversa il rapporto tra movimento e organizzazione: nessuno rappresenta nessuno. Tantomeno sulla base di meccanismi capziosi come quelli già tante volte sperimentati in modo fallimentare: coalizioni, doppie o triple tessere, rappresentanze di associazioni o partiti che si incontrano e decidono di «rappresentare» chi si mobilita proprio perché non si sente rappresentato, né intende esserlo. Ripulire le stalle di Augia, è stato detto. Questa indiscutibilmente l’operazione preliminare. E ripulirla specialmente dei professionisti della rappresentanza dei movimenti. Ma non solo. Iniziare a praticare sino in fondo, piuttosto ed inoltre, l’autonomia costituente dei movimenti sull’unico livello nel quale si incontra oggi il «governo» e cioè l’Europa. Vale forse la pena di sottolinearlo un’ultima volta: non solo i movimenti non si «rappresentano» – tantomeno quando sono in grado, come sarà di qui a poco, di «presentarsi» direttamente da sé all’uscio di chi esercita sull’Europa un’autentica dittatura commissaria –, ma pretendere di rappresentarli relegandoli ad un ruolo di «autorizzazione» o di investitura su scadenzari definiti dalle elezioni nazionali ci sembra, ed è, demenziale e perdente. Non si governa, nemmeno laddove si possa pensare di costruire coalizioni di «sinistra», in nome o per conto dei movimenti. Si governa piuttosto con i movimenti.
Si governa con i movimenti quando si opera nella piena consapevolezza che i movimenti esprimono processi di soggettivazione e agende del tutto autonomi. Si governa con i movimenti quando il rapporto tra governante e governato eccede le maglie dell’identità o dell’identificazione e si riproduce secondo il dualismo – o l’ellisse – che lo caratterizza. Si governa con i movimenti quando il governo, la dimensione verticale, esprime la capacità o la potenza di durata dei movimenti. Quando il costituirsi della moltitudine non viene contratto nel passato mitologico della fondazione (il potere costituente come «eccezione terribile» e sovrana), ma si distende in avanti nel rapporto in tensione e sempre resistito con le istanze che quel processo di costituzione traducono, «governano» e, talvolta, rendono possibile. Si governa di fronte ai movimenti. Attraversando ogni volta il rischio di sconfessione, resistenza o disconoscimemto che la loro presenza, mai dissolta nell’Uno di una rappresentazione, rende possibile come perno dell’operatività della stessa macchina di governo.