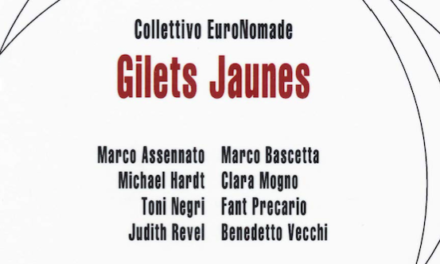Di FRANCESCO FESTA e ANTONIO BOVE
Il Primo Maggio scorso il Centro Sociale Officina 99 di Napoli ha festeggiato trent’anni di occupazione e di autogestione. Guardando al panorama politico attuale e alla disgregazione del tessuto politico antagonista della città (ma non solo), giunto forse al suo punto più alto dopo la sconfitta del 2011 e degli anni successivi, pare giusto celebrare un evento del genere. Quella data rimanda, nello stridio con il presente, a un’epoca lontana nella quale, nonostante la ben più pesante sconfitta dei movimenti rivoluzionari degli anni Settanta, parole come autorganizzazione, rivolta, comunismo tornavano attuali, rompendo la narrazione di regime.

Gli anni trascorsi ci permettono di avere quella maturità giusta per voltare il capo e guardare a quanto avvenuto oltre la stratificazione degli eventi storici e soprattutto nel tentativo di interpellare la storia e le storie oltre «l’estasi del momento», come consiglia Philip Roth. Al di là dei festeggiamenti, quindi, è opportuno immergersi, dopo aver tratto un lungo respiro, nel fiume in piena dei movimenti cui Officina 99 ha partecipato in questi trent’anni, non per fare un bilancio, bensì per provare a capire quello che oggi abbiamo innanzi a noi.
Protagonista della “stagione dei centri sociali”, Officina 99 ha le sue radici ben piantate negli anni Ottanta ed è ancorata al decennio precedente attraverso il lavoro di “ricucitura” con l’arcipelago dell’autonomia operaia: attività svolta in quel “cantiere degli autonomi” costituito all’interno dell’Associazione Risveglio Napoli (ARN), nel cuore del centro antico, composto da studenti, lavoratori, operai, precari: una espressione della complessa geografia umana dell’operaio sociale nella metropoli partenopea. Quel collettivo, punto di convergenza fra stagioni contigue dell’autonomia napoletana e insieme momento di rottura, ha lavorato sottotraccia in anni difficili. Ha mantenuto aperta l’opzione antagonista soprattutto fra gli studenti, covando il movimento che di lì a poco sarebbe esploso, la Pantera del ’90, e nel momento in cui quella stagione studentesca andava rifluendo, ha colto l’occasione per tenere aperta l’opzione rivoluzionaria, rilanciandola con l’occupazione di via Carlo di Tocco.
Officina 99 è segnata fin dall’inizio da un dualismo spazio-temporale: tenere in vita il legame con una stagione finita e allo stesso tempo guardare oltre la conservazione dell’esistente per proiettarsi oltre le sue mura verso lo spazio metropolitano.
Non un “fortino” di resistenza nel grigio della metropoli, quindi, o non solo. L’orizzonte politico di quella struttura, fin dalla sua nascita è stato porsi come riferimento e per certi versi “struttura di servizio” dei movimenti di lotta che a Napoli, dopo il terremoto, avevano trovato modo di sopravvivere nonostante le difficoltà organizzative, l’isolamento e gli schiaffi della repressione.
«Faccio movimento per il movimento», cantavano gli Assalti Frontali e potrebbe essere una sintesi efficace di questi trent’anni ma, detto fuori dai denti, anche lo specchio dei limiti contro cui si è scontrato chiunque, prima o dopo, abbia attraversato quel laboratorio. Crediamo che valga la pena, a questo punto, nel definire il contesto storico e politico dentro cui quei limiti di iniziativa politica si sono misurati, affrontarne i nodi e provare a riflettere oltre e contro questo accumulo di anni e di esperienze.
Officina 99 è stato, innanzi tutto, un laboratorio dell’autonomia e dell’autorganizzazione che ha provato a gettare un ponte oltre le miserie di un presente fatto di carcere, eroina, terremoto, violenza dello Stato e la “fine della storia”, seppellita sotto la coltre disgustosa dello yuppismo, sotto la quale quegli autonomi si misero a scavare come la “vecchia talpa”.
Rifiuto del lavoro, contropotere, autonomia, comunismo, movimento del valore d’uso, ambientalismo radicale, sono stati alcuni rompicapi per provare a riattaccare i cocci dell’autonomia.
Una volta occupata l’ex fabbrica di Gianturco, il passaggio successivo è stato quello di unificare le lotte, dare densità ai movimenti proletari di Napoli e provincia, con i compagni di Acerra – Antonio “Piccolone” Piccolo e Consiglia Terracciano, in primis – a sostenere il progetto ricostitutivo per “organizzare la rabbia” e provare a divenire egemoni culturalmente e politicamente nella città e, poi, nel Sud Italia.
Quella egemonia che, indubbiamente, Officina 99 e dal ’95 il laboratorio SKA hanno esercitato in città, tanto che anche mondi non propriamente “allineati”, come quelli delle numerose tribù urbane che si aggregavano intorno a stili musicali o artistici, risultavano del tutto “contigui” se non interni alla strada tracciata dal Centro Sociale. E questo modo di tener dentro mondi differenti del proletariato metropolitano è stata la prima aspirazione politica per un collettivo che guardava chiaramente alla costruzione di un soggetto politico, oltre che di un “laboratorio occupato”. Aspirazione, beninteso, non a “dirigere” i movimenti, bensì a tenerli aperti senza rinchiuderli dentro simulacri di partiti e partitini, gruppetti o altre forme microidentitarie.

Questo processo si è costruito attraverso passaggi precisi che hanno progressivamente “cortocircuitato” quella che nel gergo borghese si chiama “opinione pubblica”, tanto che numerosi segmenti di essa ce li siamo trovati in più occasioni al nostro fianco. Proprio la forza di quella egemonia, contrapposta alla sua lenta e progressiva ma inesorabile quanto inarrestabile diluizione, costituiscono oggi un tema di dibattito che va affrontato, senza il timore, da parte di chi ha sempre praticato terreni “eretici” (sbagliando spesso) di scomodare un terreno di analisi “classico”.
Questo è un elemento di riflessione politica centrale perché richiama a una riflessione sulle modalità di interazione con i settori della società che si aprono al dialogo pur non condividendo la totalità della tua visione politica. Come interagire? Come strutturare un lavoro politico in grado di rompere gli argini delle differenze senza disperdere il patrimonio di quelle alleanze? Queste sono alcune delle domande essenziali, che peraltro ripercorrono l’intera storia dei movimenti rivoluzionari e che solo compagni poco lungimiranti tendono a ignorare.
Il percorso politico che dall’ARN attraversa gli anni Novanta passa attraverso momenti che saranno sempre segnati da questa commistione fra soggettività autonoma ed elementi magmatici della società.
Il coordinamento dei movimenti di lotta degli inizi anni Novanta, prim’ancora la Pantera, poi il movimento Sabotax del ‘94-‘95, la stagione NoGlobal, le lotte contro i rifiuti. In questi momenti, Officina 99 e soprattutto la fitta rete di relazioni politiche e umane che intorno a essa si riuniva ha tentato di tenere aperte le opzioni di lotta, affinché quei movimenti mettessero in crisi l’ordine costituito in funzione dell’apertura di nuovi processi costituenti.
Senza scomodare l’antologia marxiana, si potrebbe parlare di processi di “transizione” contro e oltre la società borghese e la sua organizzazione capitalistica fondata sul valore di scambio. Basti pensare, ad esempio, che grazie a questi movimenti, generazioni di compagne e compagni hanno dischiuso il proprio mondo alla politica: una sorta di apprendistato alla militanza, per poi investirla in percorsi di vita o in altre realtà politiche. Ciò nondimeno, il desiderio di Officina 99 è stato quello di tenere aperti i vasi comunicanti che da quei movimenti si innervavano nella metropoli.
I frutti di questa “semina” si sono colti in diversi momenti storici, attraversando gli anni fino alle lotte contro i rifiuti in Campania, ultima fase di picco del conflitto sociale nella Regione, in cui la forza della sollevazione, pur dentro il difficile terreno costituito dall’antagonismo scivoloso fra iniziativa di lotta e risposta repressiva che tende alla lunga ad assorbire la complessità del ragionamento politico, sono state veicolate all’interno delle fasi di conflitto parole d’ordine precise: autonomia dai poteri costituiti quale termine di intervento politico e autorganizzazione come metodo. Eppure una volta vinte quelle battaglie, la politica è rientrata nell’alveo della stessa democrazia borghese, come se l’opzione antagonista non fosse credibile di divenire organizzazione e nuovo potere costituente.
È un elemento imprescindibile di riflessione politica questa incapacità a tradurre l’iniziativa di lotta in contropotere organizzato, un limite storico che, insieme alla moltiplicazione di differenze fra le strutture politiche, ha provocato frantumazioni insanabili e incapacità depotenzianti di qualsiasi politica rivoluzionaria.
Repressione poliziesca e inchieste giudiziarie hanno chiuso il cerchio attorno alle forme di contropotere nei territori, e quel vuoto è stato colmato, da una parte, dalle formazioni politico-criminali, e dall’altra dai partiti e dallo Stato, ripristinando il discorso in un ordine già visto: assistenzialismo e clientelismo in cambio di voti e lavoro. Era accaduto alla fine degli anni Settanta, è accaduto con i movimenti successivi.
In questo senso guardare al passato e nel confronto con la mestizia del presente dirsi “avevamo ragione” è un esercizio consolatorio che ha ben poco di politico.
Pensiamo al movimento Noglobal, rispetto al quale la lungimiranza dell’attivo politico di Officina 99/Ska è riuscita a individuare, leggere la fase storica, e forzarla inventandosi un vertice contrapposto a quello disegnato dai burocrati della governance mondiale, all’interno del movimento crescente contro le politiche neoliberiste. Nel giro di due anni, il consenso attorno alle pratiche dei movimenti è andato via via crescendo: dall’angolo del minoritarismo, dell’antagonismo fine a sé stesso, siamo diventati maggioritari, ogni momento di piazza aveva una sua visibilità, nonostante le pratiche non fossero condivise. Il consenso cresceva, i cortei diventavano moltitudinari, mentre anche pezzi di quella società borghese prendevano posizione e scendevano in piazza al fianco di un mosaico di realtà componendo il “movimento dei movimenti”, mentre il fil rouge era tenere dentro “il conflitto e il consenso”: altro modo di intendere quel tenere aperti i movimenti, che in realtà era un lontano ricordo proprio delle radici di Officina 99, nella traduzione operaista di una massima di Raniero Panzieri.
Rispetto a quel processo, giunto all’apice con le giornate di marzo del 2001, per un verso punto di approdo della “stagione dei centri sociali”, per l’altro “canto del cigno” di una stagione politica, che ruolo ha giocato l’incapacità di affrontare il nodo dell’organizzazione?

A dire il vero, questa vexata quaestio non va addebitata alla generazione della Rete NoGlobal. In realtà essa è un rompicapo da far risalire agli anni Settanta, una sorta di eredità lasciata dall’autonomia napoletana, in merito proprio all’incapacità di raggiungere una maturità politica per innestare la pratica del contropotere sul multiforme universo sociale partenopeo e in particolar modo su quella figura dell’operaio sociale, che nella metropoli napoletana ha una sua peculiarità, spesso riduttivamente incorniciata nei “mille lavoretti per sbarcare il lunario”.
Su questa complessa composizione di classe si è provato a innestare a volte forme organizzative mutuate da modelli tradizionali del movimento operaio che poco calzavano alla sua natura, altre volte si è deliberatamente lasciato fare allo spontaneismo, come se l’illusione di aver raggiunto una maturità individuale e collettiva fosse in grado, di per sé, di far compiere le azioni migliori e garantire una maturazione politica. La sfida costituita dalla lettura di una composizione che lasciava intravedere, già dagli anni Settanta, potenzialità e difficoltà di una fisionomia della classe in un’epoca di transizione è stata schiacciata fra dirigismo e determinismo spontaneista. E questo è un enorme limite cui guardare per trovare chiavi di lettura non solo per il passato ma per il tempo futuro.
La Rete NoGlobal esemplifica parte di queste riflessioni. Una maturità in essa si percepì e persino s’individuò la forma organizzativa: la rete fra le differenze che dava sostanza all’idea del “movimento dei movimenti”.
Evocativo, a vent’anni dal movimento NoGlobal, è l’incipit dell’introduzione al libro Zona Rossa. Le quattro giornate di Napoli contro il Global Forum, curato dalla Rete NoGlobal, che riprende il concetto di rizoma di Gilles Deleuze e Félix Guattari di “Mille piani. Capitalismo e Schizofrenia”, come forma organizzativa orizzontale da opporre ai modelli basati sulla concezione di albero in cui è prevista una gerarchia, un centro, un ordine lineare. A differenza degli alberi il rizoma collega un punto qualsiasi con un altro punto qualsiasi: “rispetto ai sistemi centrici (anche policentrici), a comunicazione gerarchica e collegamenti prestabiliti, il rizoma è un sistema acentrico, non gerarchico e non significante”.
Ecco, questa è stata l’intuizione delle Rete NoGlobal, vissuta in forma organizzativa per pochi mesi, fino a Genova o settembre 2001, e poi naufragata nell’immaturità collettiva: le strutture che alzano la voce, le piccole egemonie e le identità che sgomitano rimettendo in sesto le forme gerarchiche e lineari, le micro- o macro-alleanze a livello locale o nazionale per farsi forza. Dal che, nel naufragio si è buttata a mare sia l’intuizione che le pratiche.
Guardiamo oltre, alla stagione delle lotte contro i rifiuti, dei comitati autonomi che hanno puntellato la Campania: non vi era paese o comunità, piccola o grande, che non avesse il suo comitato popolare contro i rifiuti. In quel ciclo di lotte ma anche, derogando al “napolicentrismo”, nella lotta contro il nucleare del novembre 2003 in Lucania, possiamo rintracciare, al di là del valore di quelle mobilitazioni, uno dei punti morti, dei capolinea cui i movimenti di lotta nel Mezzogiorno (e non solo a Napoli) sono giunti. Vale a dire, l’incapacità di tradurre i movimenti destituenti in processi costituenti.
Vi è un passaggio dei Quaderni del carcere, nel Quaderno XXV, intitolato Ai margini della storia (Storia dei gruppi sociali subalterni), in cui Gramsci in maniera tanto abbozzata quanto stenografica analizza proprio l’incapacità dei movimenti subalterni di assurgere a movimenti egemoni in grado di costruire un’altra società: “la storia dei gruppi sociali subalterni è necessariamente disgregata ed episodica. È indubbio che nell’attività storica di questi gruppi c’è la tendenza all’unificazione sia pure su piani provvisori, ma questa tendenza è continuamente spezzata dall’iniziativa dei gruppi dominanti, e pertanto può essere dimostrata solo a ciclo storico compiuto, se esso si conchiude con un successo”.
Dunque, i gruppi subalterni per Gramsci subiscono sempre l’iniziativa dei gruppi dominanti, anche quando si ribellano e insorgono, ciò nondimeno non riescono a unificarsi, non si costituiscono in uno stato unico; e a causa di ciò, sono sotto il potere della cultura egemonica, della cultura borghese, dunque la loro storia è intrecciata a quella della società civile di cui sono una funzione “disgregata” e discontinua.
Questi stralci gramsciani fotografano proprio l’impossibilità dei movimenti proletari di divenire Stato, potere costituente, eppure non ci aiutano a spiegare perché il movimento NoGlobal o i movimenti “ambientalisti” non siano stati in grado di divenire contropotere permanente oppure potere costituente, e siano invece afasicamente rifluiti nell’alveo dei partiti borghesi e dell’ordine costituito. Sicuramente, per un’analisi completa, non possiamo evitare una discussione sincera sui meccanismi decisionali utilizzati all’interno delle assemblee e degli attivi politici, su quanto abbiano influito, nell’acuire i limiti di iniziativa politica, i dispositivi organizzativi e l’ossatura delle decisioni tradotte poi nelle lotte.
In questi momenti, siamo stati di fronte a momenti decisionali in cui le assemblee per una sorta di rispetto di una democrazia sostanziale si sono letteralmente incurvate, bloccate sul diniego di pochi, di minoranze che senza tener conto della volontà maggioritaria – mentre, di contro, questa ne teneva certo conto – hanno inchiodato percorsi di partecipazione, progetti e movimenti. In difesa di un rifiuto tout court della delega, del “centralismo democratico” e della logica dei partiti borghesi, si è invece compiuta un’inversione boicottando la stessa democrazia sostanziale, ossia inchiodando la democrazia alla dittatura delle minoranze. All’oggi, mutatis mutandis, potremmo parlare quasi di una “pratica pentastellata” ante litteram.

Ben oltre il sapore delle celebrazioni, quindi, sono molti e di grande complessità i temi da affrontare. Siamo partiti dalla periferia Est di Napoli, da Gianturco, estendendo l’analisi, poiché la storia di Officina 99 è una cartina di tornasole che attraverso i suoi trent’anni illuminando lo status quo dei movimenti autorganizzati, oggi.
Che quel periodo storico sia finito è un dato di fatto, così come è evidente quanto sia, invece, ancora viva e urgente, la “domanda politica”, ben visibile se solo si prova a staccare lo sguardo dai terminali cui siamo attaccati per la maggior parte della giornata, e guardare quello che accade sotto il proprio balcone.
Il disfacimento del tessuto politico ordito in una trama per tutti gli anni Novanta, manifestatosi nella sua energia e nei suoi enormi limiti nel marzo 2001 a Napoli e nel luglio successivo a Genova, è ormai completo.
Un fattore determinante di quella sconfitta è stato sicuramente la dura repressione “preventiva”, attuata ben prima che quel movimento raggiungesse un livello organizzativo e di proposta politica preoccupante, ma non è possibile nascondersi il ruolo fondamentale che abbia avuto l’inadeguatezza di quell’esperienza al livello di scontro in atto, sulla quale la repressione “successiva” ha chiuso il lavoro: le energie politiche sono state poi impiegate per difendersi dai teoremi orditi contro il movimento, fra i tanti, l’esemplare operazione contro la Rete del Sud Ribelle nel 2002, terminata dieci anni dopo con l’assoluzione degli imputati.
La “stagione NoGlobal” conteneva una visione politica lucida fatta di numerose intuizioni felici, ma anche l’arretratezza di strutture che erano pienamente coi piedi nel terreno sabbioso del peggiore Novecento. È da quella posizione scomoda che sono venute fuori il tatticismo esasperato, la predominanza del ceto politico rispetto all’energia che veniva da interi settori di classe coinvolti in massa per la prima volta dopo anni, e una mancanza di organizzazione che, ancora una volta, ha offerto il petto nudo di quel movimento alla falce dello Stato. I Social Forum sono morti per quello, perché erano diventati parlamentini dentro cui si agiva la tattica camuffata da strategia che ha annacquato un terreno di proposta politica, invece, dirompente.
La situazione attuale è direttamente figlia di quegli errori. Bisogna trovare il coraggio di dire a noi stessi che i morti sono le nostre forme organizzative, in molti casi forme ibride di dirigismo verniciate di “movimento”. È sicuramente defunta la solita vecchia ipotesi “entrista” che si è fatta strada fra ampi settori di quel movimento dopo la sconfitta producendo risultati disastrosi, annacquati dentro la brodaglia della tattica di sopravvivenza come unico orizzonte possibile.
Fuori da tutto ciò il terreno dello scontro è sempre vivo e le condizioni di lotta, che sono numerose, sono il solo ambito nel quale si può scorgere “la linea”. Negli ultimi vent’anni le lotte di classe in tutto il Sud sono proseguite fregandosene delle diatribe tra formazioni politiche. L’autonomia esiste anche senza gli autonomi, è colpa nostra se siamo in ritardo.
Tutte le foto di Carlo Hermann