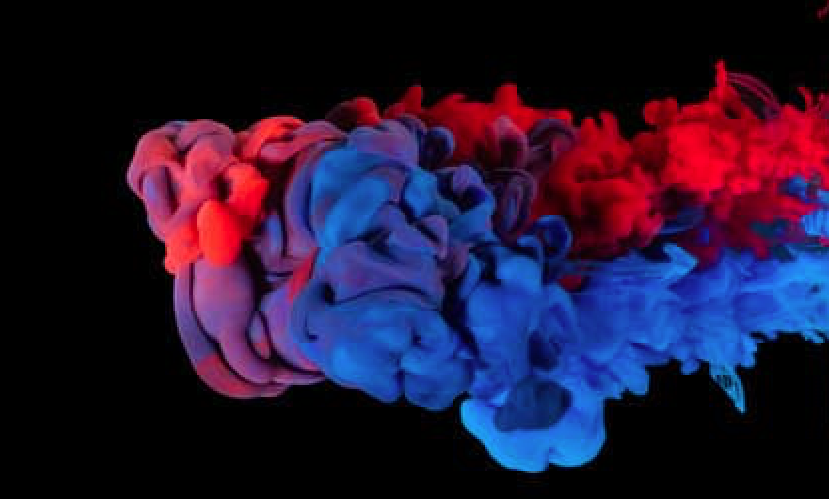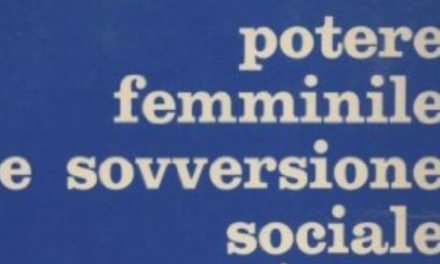Presentiamo qui gli articoli che compongono il Quaderno di EuroNomade dedicato al Contropotere. Il Quaderno può essere scaricato cliccando qui o sull’immagine di copertina in calce.
Di AUGUSTO ILLUMINATI
Contropotere si dice in moti modi, pollakôs légetai. Di almeno uno di questi significati – una fase transitoria ma non istantanea in cui ci fronteggiano due poteri in conflitto e quasi in equilibrio, insomma un dualismo di potere – oggi non abbiamo traccia. All’interno di un esteso ciclo mondiale di lotte abbiamo piuttosto passaggi di contropotere locale, vigenza di controcondotte (per usare un termine più modesto) che si addensano in costellazioni di resistenza e pratiche alternative, prove di contro-egemonia. Possiamo inoltre chiamare controcondotte le forme di vita che si sganciano e fanno attrito rispetto ai modelli imposti dal mercato e dallo stato. Il contropotere si presenta oggi come un qualcosa di plurale, disseminato e virtuale, una potenza non compiutamente realizzata e forse destinata all’incompiutezza che è propria di ogni dúnamis nel passaggio all’atto.
Detto in termini machiavelliani: l’umore del popolo di non essere comandato né oppresso, che incessantemente lo contrappone ai potenti che vogliono comandarlo e opprimerlo, è umore di contropotere. Però, intendiamoci, il popolo o la moltitudine (quale che ne sia il contenuto) non è un soggetto come essenza unificata e unificante e “non è” (ovvero non si identifica) con quell’umore ribelle, ma “lo ha” come un oggetto esterno sia pure affine, se non altro per la posizione occupata dal popolo.
Se x è y, il predicato inerisce al soggetto e ne definisce almeno in parte l’essenza: il ghiaccio è freddo oppure solido. Se x ha y, se Carlo ha un corpo, l’oggetto non concorre a stabilire l’essenza del soggetto, che è più complesso e sussiste anche in caso di mutilazione. Fra i due termini c’è distacco, possibilità di uso o di non uso, e soprattutto di usi diversi. Avere la parola non è prendere la parola o dare la parola.

Fin qui abbiamo ripetuto distinzioni logico-grammaticali che hanno una lunga storia, da Benveniste a Virno. A maggior ragione vale, se x è un soggetto collettivo, quindi composito e aggregato di volta in volta secondo rapporti interni differenti. Gli incontri fra un soggetto mal definito e un oggetto sfuggente generano molteplici combinazioni, alcune delle quali possono essere controcondotte ostili alle condotte dei potenti. Oppure, fin troppo spesso, prevale il mancato uso, la passività, un flop della potenza, il reflusso esofageo del rancore.
Dipende dall’occasione, per il Fiorentino, dal clinamen, per Lucrezio, dalla congiuntura per Althusser. I due cortei degli operai in sciopero e degli studenti rivoluzionari potevano confluire, in quel fine maggio 1968, ma non accadde. Oggi Gilets jaunes e manif sindacali si sono mischiati a più riprese e ne sono nati momenti di contropotere fisico e assembleare nelle strade, nei nodi della logistica, sulle rotatorie e ai caselli, non solo accesi riot urbani.
Se riprendiamo un testo di Laclau–Mouffe in parte ancor valido e interno alla problematica gramsciano-althusseriana[1], potremmo confermare, dopo oltre trent’anni di trasformazione molecolare dispersiva della nomenclatura di classe, alcune sue ipotesi, indipendentemente dall’istradamento operato dagli autori verso la “ragione populista”. Che la radicalizzazione del concetto di “surdeterminazione” ci fornisce la chiave per la logica specifica delle articolazioni sociali, consentendoci la critica di ogni tipo di fissità e l’affermazione dell’indole incompleta, aperta e politicamente negoziabile di ogni identità; che, dunque, l’indecidibilità permea il campo in precedenza ritenuto governato dalla determinazione strutturale e che allora l’egemonia consiste in una teoria della decisione presa su un terreno indecidibile. Di conseguenza, le articolazioni politico-egemoniche creano retroattivamente gli interessi che dicono di rappresentare, ovvero la pratica politica costruisce gli interessi che rappresenta, la lotta di classe definisce le classi in lotta e i loro attori non possiedono un’essenza comune sottostante, ma sono il risultato della costruzione e del conflitto politico.
La stessa egemonia – e pertanto la costituzione di contropoteri dall’opposizione – non
sarà «la maestosa apparizione di un’identità» ma un momento interno di una crisi, di una frattura sul piano fattuale, e il riflesso e il sintomo di una totalità assente, sul piano teorico ovvero di una situazione in cui il contingente sovverte di continuo il necessario e il presunto storico-destinale impedendone la chiusura. Le cose non vanno più “da sé” o quasi, ma occorre intervenire per imprimere un corso diverso e formare un “blocco” sufficiente per operare. Si tratta, a quel punto, di egemonia di soggettività ibride e non identitarie solo in parte suturate da un agire politico che non discende unilateralmente da un’essenza (le rivendicazioni di classe, per esempio) ma si articola con pari legittimità su questioni tanto di “redistribuzione” quanto di “riconoscimento”, meglio ancora se i due aspetti sono interconnessi come accade per lo “sciopero femminista” o le lotte dei migranti che chiedono diritti di cittadinanza e tutela come forza lavoro.
Certo, quel concetto di “democrazia radicale” presentava (al netto della messa fra parentesi del modo di produzione) non poche ambiguità, che si aggraveranno in senso neoliberale e meramente “agonistico” nei testi successivi dei due autori, in particolare di Chantal Mouffe. Resta tuttavia valido il principio che la sua costitutiva pluralità di identità trova al proprio interno il criterio di validità, senza dover cercare legittimazione in un fondamento positivo trascendente o soggiacente, mentre appare discutibile il nesso fra democrazia radicale plurale e liquidazione dell’universale e della rivoluzione, che avrebbe la colpa di configurare un accesso privilegiato elitario alla verità e di favorire la concentrazione del potere e una riorganizzazione presunta “razionale” della società.
Se però adottiamo l’approccio di Rancière, per cui è di volta in volta l’irruzione di quanto prima non-contato (il proletariato, le donne, i precari, ecc.) a costituire l’universale nuovo – che ingloba i precedenti quali casi speciali, come accade per i paradigmi scientifici –, teniamo aperta la possibilità di una rivoluzione per valori fondativi universali replicabili che nulla hanno a che vedere con formule eterne con cui si concluderebbe la storia. Gli universali dinamici non sono trascendenti ma eccedenti i loro rappresentanti-referenti, cioè il gruppo sociale che si presenta come l’escluso che prende parola e si fa carico, per l’ennesima ma non per l’ultima volta, di tutti gli oppressi che esigono riconoscimento.
Riconoscimento e potere stanno insieme e così cade la suddivisione artificiosa fra lotte democratiche e lotte popolari, fra aspetti simbolici e materiali di rivendicazioni e risultati. Qui possiamo cominciare o riprendere a parlare di controcondotte e contropoteri che fissano in un certo arco di tempo emergenze mobili di classe (di esclusi, di ancora non visibili) imponendo riconoscimento e gestendo una quota di potere a titolo prevalente di contesa, di impedimento all’oppressione e invisibilizzazione.

Il movimento delle donne ha fatto emergere e a volte sanzionato parecchi di questi luoghi di stallo del maschilismo e del gap salariale, i Gilets jaunes hanno portato alla luce gruppi sociali vecchi e nuovi, geografici e produttivi, che hanno inceppato i meccanismi correnti e imposto forme inedite di discussione e deliberazione. Lo hanno fatto riqualificando pratiche antiche (dal blocco stradale ai cortei) o riusando, con lo sciopero femminista, una forma sindacale caduta in desuetudine o ridotta a rito innocuo delle centrali maggioritarie. Nella stessa direzione va la sindacalizzazione e mobilitazione extra-confederale dei lavoratori delle nuove professioni non tutelate (rider, partite Iva, sub-appaltati) e del lavoro immigrato in nero – soggetto a svariati ricatti, dalle relativamente più accolte badanti agli schiavi del caporalato agricolo, edilizio, logistico e delle fabbrichette clandestine. Una moltitudine o un segmento di moltitudine la cui centralità e insieme vulnerabilità è stata drammaticamente illustrata dall’interruzione delle catene globali di approvvigionamento e dallo stallo delle domande nazionali imposto dalla pandemia Covid-19 e dalle connesse misure di confinamento erallentamento produttivo. L’accorciamento delle filiere, per essere minimalisti, distrugge buona parte del lavoro informale e dei sub-appalti, disperdendo pezzi di moltitudine non facili a riaggregarsi in tempi brevi. Al di là dell’impressionante espulsione dal lavoro di fabbrica di milioni di operai in Usa, interi settori sembrano destinati su scala mondiale a una prolungata paralisi – per esempio l’automobile e il turismo con i loro giganteschi indotti –, un terremoto dalla conseguenza incalcolabili e non recuperabili nei modi consueti alle precedenti crisi, a causa del declino della domanda che sopravvive a parziali restauri delle catene produttive (se anche si verificassero).
Insomma, una moltitudine che può avere (o non avere) l’umore di non essere comandato e oppresso – neppure Machiavelli stava troppo a distinguere fra condizione simbolica e materiale!
Una moltitudine, il cui senso è generico perché indica, da Spinoza alle correnti post-marxiane, la dinamica di rinnovamento di una classe che non è più soltanto la classe operaia (per quanto sfaccettata all’infinito nelle nuove composizioni di lavoro) e neppure il nome indefinito dei subalterni, ma l’Insieme (diviso, di-vergente) dei supporti del general intellect: la potenza dei vulnerabili. Vale a dire, il laboratorio alchemico di ogni sovversione e messa in rete del potere costituente e, maligno gemello, il serbatoio del risentimento e di ogni pullulante fascismo. Il luogo, dunque, di uno scontro di strategie politiche ognuna delle quali mira a dividere il campo avverso e a succhiarne le energie volgendole all’affermativo o al negativo. Qui vedremo l’effetto Covid.
Siamo ben lontani dallo schema neoliberalismo-populismo, si tratta piuttosto di tirare l’esposizione al mondo (questo è, in una prospettiva generica, la vulnerabilità, la pelle scoperta) verso la costruzione di eguaglianza e felicità invece che verso il risentimento e la discriminazione di chi è ancora più vulnerabile. Il contropotere è un momento di organizzazione dell’indignazione diretto verso il giusto obiettivo – qui si determina la corretta e non irenica mescolanza di odio e amore –, l’assemblaggio di pulsioni distruttive e destituenti in un movimento costituente, che vuol dire alleanze, compatibilità, convergenza di trasformazioni.
Al momento non abbiamo in atto la figura compiuta del contropotere, quella che si chiamava il dualismo di potere, che si iscriveva nella logica e come tappa intermedia della conquista del potere e del suo esercizio per un progetto di riorganizzazione totale della società (dai soviet alle Black Panthers). Non facciamo scommesse nostalgiche sulla transizione a un altro modo di produzione, ma neppure frettolose liquidazioni del concetto di potere e della sua associazione alla violenza – restando io ottusamente convinto che gli uomini nacquero, vissero e morirono, sempre, con uno medesimo ordine. Cioè vulnerabili, disadattati al mondo e mossi da passioni.
A essere realisti, però, quello che oggi più si avvicina a quel disusato termine (ma ancor meglio a “controcondotta”) è la politicizzazione non governativa di pratiche sociali, la costruzione, per usare un linguaggio sociologico neutro, di corsi d’azione caratterizzati da forti contrapposizioni e conflitti, l’assunzione, de facto e non de jure, della capacità di produrre sistemi di regolazione vincolanti per le forme di organizzazione sociale. Queste possono essere proattive o reattive a processi di depoliticizzazione che hanno svuotato precedenti conquiste in applicazione dei modelli neoliberali di governance. Di norma abbiamo mescolanze variabili di entrambi gli aspetti, con sostituzione dei soggetti attivi o reattivi rispetto ai protagonisti delle precedenti riforme sociali e delle istituzioni politiche. La ripoliticizzazione può muovere da destra (per esempio, la battaglia sovranista contro l’eurocrazia) o da sinistra, ma qui attingiamo esempi solo dal secondo versante. Eccone alcuni.
Agli attori usuali delle politiche abitative urbane, oggi defilati e silenti (amministrazioni comunali, enti case popolari, partiti di sinistra, associazioni inquilini) si sono sostituiti centri sociali e comitati di occupanti, che hanno praticato la presa diretta di possesso di locali abbandonati, organizzandone la gestione e rivendicando una specie di usucapione sociale, ripoliticizzando in nome del diritto alla città settori da tempo depoliticizzati e abbandonati a opache procedure tecniche o abbandonati tout court. Fenomeni analoghi hanno interessato spazi culturali o di convivenza (teatri, ex-cinema, fabbricati industriali, scuole dismesse) mantenendo o variando l’uso originario – celebri a Roma i casi del Teatro Valle e del Cinema Palazzo, ma ogni città ha i suoi.

Se la tipologia di cui sopra si ispira alla prevalenza dell’uso sul diritto di proprietà e alla categoria di beni comuni, la ripoliticizzazione del Secondo Welfare, assai meno vistosa sotto il profilo dell’ordine pubblico, investe invece un nodo strutturale della riorganizzazione neoliberale degli apparati statali e della società. Il punto di partenza è lo smantellamento dello stato sociale in nome dell’efficienza e dell’austerità, che viene implementato con l’appalto alla cattolica sussidiarietà e alla protestante big society, ovvero con il trasferimento al risparmio e all’iniziativa volontaria degli imprenditori di sé stessi delle funzioni un tempo svolte dalla pubblica amministrazione e coperte con la fiscalità generale. Un processo di depoliticizzazione che si rovescia nel suo opposto nella misura in cui i soggetti individuali, ormai deprivati dei benefici assistenziali, cercano di riorganizzarsi costruendo forme cooperative di solidarietà sociali (sportelli di consulenza e assistenza, ambulatori, mutue nello stile del primo movimento operaio, mercati autogestiti) senza affidarsi alle banche, come avviene con i fondi pensione.
Si appalesa qui una certa affinità con il nuovo sindacalismo, che si sviluppa tanto fra gli schiavi bianchi e neri dell’agricoltura e dell’edilizia quanto nei settori produttivi innovativi e delle piattaforme (finte partite Iva, rider, magazzinieri Amazon, schiavi di Mechanical Turk, ecc.) rimasti scoperti della tradizionale tutela sindacale e inclini a recuperare alcune forme originarie del movimento operaio, sul piano sia di leghe di categoria o di disoccupati che di strutture orizzontali: bourses du travail, camere del lavoro, anzi meglio camere del lavoro e del non lavoro.
In entrambi i campi citati si tratta di esperimenti di contropotere in risposta alla perdita di potere contrattuale nell’area del welfare e del lavoro precario o sub-appaltato (servizi, stages, logistica), con implicita assunzione (non insurrezionale, ma questo è un dato contingente, non destinale) di una divisione della sovranità, non più riservata in forma monopolistica allo stato e alle sue propaggini ma esercitata in parte dal basso e per settore. Covid-19 ha messo in vetrina la supplenza dal basso delle attività di prima assistenza scaricate dai pubblici poteri.
Ultimo caso in cui un’attività tecnica di competenza della Guardia Costiera o di soccorritori occasionali è stato potentemente politicizzato è il salvataggio in mare dei migranti nel canale di Sicilia – cui potrebbero essere accostati anche gli interventi alle frontiere terrestri di Ventimiglia e Gorizia e le molteplici attività di accoglienza fuori e contro le logiche carcerarie ufficiali. Salvataggio che è stato assunto da Ong e centri sociali in sfida aperta alle misure restrittive e alla soppressione del soccorso pubblico adottate, con vistosa propaganda razzista, dal governo Conte-Salvini-Di Maio sulla scia delle misure di Minniti e non ritirate neppure dal governo Conte bis-Franceschini-Di Maio. I tuttora non aboliti decreti Sicurezza.
Qui in apparenza siamo agli antipodi dell’immagine di contropotere che si offre nel tumulto – peraltro solo in apparenza, perché del tumulto è tipico non tanto il sangue e il fuoco quanto in primo luogo la messa in gioco dei corpi e questa è decisiva nel salvataggio. La sfida alla sovranità vi è addirittura più netta: la legge dello stato non viene soltanto infranta ma le si contrappone una pratica che si legittima con la superiore e antecedente legge del mare (e invero con un paio di articoli della Costituzione), una logica dissidente alla Antigone, che incrina da sempre la pretesa di sovranità e monopolio giuridico, e con cui Hegel aveva creduto di farla finita facendo leva sul concetto moderno di sovranità razionale e popolare. Lo scontro è quindi al livello più alto e radicale fra due figure del potere, svestito però di ogni trascendenza di antichi dei o di mistica sovrana. È il pescatore contro lo sbirro, alla fine. Non così diverso dal sanculotto contro la guardia svizzera che difendeva Versailles o dal gilet giallo che sfida la Macronia. Il confinamento ha naturalmente sospeso o meglio rinviato la manifestazione pubblica di massa del dissenso…
Cosa vuol dire allora – per chiudere il cerchio – esercitare egemonia attraverso controcondotte, costruire nell’opposizione e nella trasgressione momenti positivi, costituenti? È un processo stabilizzato che svuota di peso l’antinomia fra riforme e rivoluzione? Vocaboli carichi di storia e dottrina ma oggi stravolti nell’uso e ridotti, i primi, a interventi neoliberali per ridurre i diritti acquisiti, a qualsiasi cambiamento a cazzo di cane la seconda.

Resuscitare oggi il dibattito fra Bernstein e Rosa è scivoloso, eppure una cosa almeno va detta: che una situazione di contropotere e a maggior ragione di dualismo di potere, costituisca o meno un superamento di quell’antico dilemma, sia stabilizzabile appare ambiguo, o meglio necessita di articolazione. Nel senso che la stabilizzazione è una risultante più che un obiettivo. L’obiettivo è durare e vincere, rilanciare l’iniziativa e radicarsi, la risultante il fatto che il mancato o parziale raggiungimento dell’obiettivo lascia comunque un sedimento da cui ripartire, anzi da cui ripartono i nuovi agenti che nella fase precedente non erano messi in conto. Stabile, piuttosto, è l’incessante ripresa del combattimento, al limite il “fallire meglio” di Beckett e Deleuze, il riprovarci senza lasciarsi scoraggiare, il passare la mano a nuovi esclusi che incrinano la totalità integrata.
Infine, stabilizzazione può assumere il significato di una presa d’atto che la storia ha interruzioni, faglie, ma non una conclusione e dunque il conflitto e il contropotere ci saranno sempre, perché sempre ci saranno forme diverse di potere, non solo nel passaggio dalla sovranità alla governance, ma anche dopo una (per ora remota) sconfitta della governance neoliberale. Contrariamente all’opinione del giovane Marx (Miseria della filosofia), non arriverà un’epoca in cui le evoluzioni sociali cesseranno di essere rivoluzioni politiche. L’esperienza della dittatura del proletariato e del socialismo reale e i mutamenti nell’esercizio del potere politico capitalistico hanno fatto giustizia di quella scorciatoia. Diseguaglianze e dissimmetrie hanno il fiato lungo.
I poveri non saranno sempre fra noi, ma i tumulti sì.