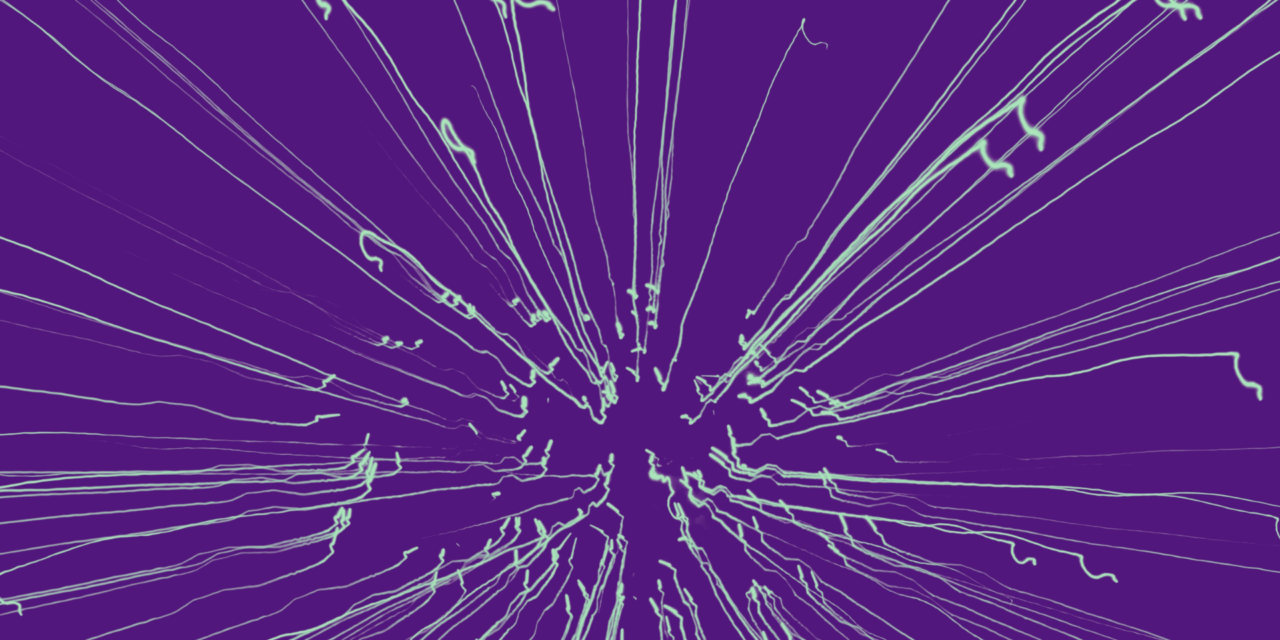Di SANDRO MEZZADRA
Il 5 novembre, a Roma, si è manifestato un movimento di massa contro la guerra. La sua composizione era eterogenea, trasversale rispetto alle generazioni e attraversata dai linguaggi, dai comportamenti e dagli immaginari di precedenti mobilitazioni contro la guerra. Due componenti erano immediatamente visibili, quella in senso lato cattolica (capace di parole radicali sul carattere espansivo della lotta per la pace) e quella sindacale, della CGIL, protagonista di una mobilitazione capillare a livello territoriale e tra le sue diverse categorie. Nonostante quest’ultima presenza, il tema della pace è stato agitato a Roma senza significative connessioni con quelli del salario e del reddito, al centro di un attacco di cui non è possibile non vedere le connessioni con la guerra e con la sua economia. Nelle stesse ore, a Napoli, una manifestazione di “convergenza”, organizzata dal Collettivo di fabbrica della ex GKN e dal movimento disoccupati 7 novembre, tentava di porre a tema quelle connessioni.
Retrospettivamente, è facile pensare che se il percorso (e in particolare il metodo) della “convergenza” fosse confluito nella manifestazione di Roma sarebbe forse stato possibile fare qualche passo avanti nell’affermare a livello di massa la necessità di collegare il rifiuto della guerra con la difesa del reddito e del salario, con le stesse iniziative contro il carovita e l’aumento delle bollette che stanno proliferando nel nostro Paese così come altrove in Europa. Certo, le posizioni sulla guerra di alcuni tra gli organizzatori del corteo romano del 5 novembre sono ambigue, e il tratto tradizionalmente “pacifista” delle posizioni di altri può far storcere il naso a chi rivendica la purezza di un atteggiamento anticapitalistico. Mi pare tuttavia che non sia davvero questo il punto, che non sia concessa alcuna “purezza” oggi a chi ricerca le condizioni di un nuovo internazionalismo e di una nuova fondazione politica della lotta di classe. Quella ricerca andava portata nelle strade di Roma il 5 novembre, con parole d’ordine chiare (ad esempio “giù le armi, su i salari”, come proposto da Emiliano Brancaccio) e senza alcuna arroganza.
Non lo dico, sia chiaro, con spirito polemico. Al contrario, lo dico con spirito costruttivo, guardando a un futuro prossimo in cui costruire convergenza contro la guerra continuerà a essere un compito politicamente decisivo. Indipendentemente dal modo in cui si è concluso, l’“incidente” di martedì scorso in Polonia ha una volta di più alluso allo spettro di un allargamento catastrofico della guerra in Ucraina, mentre ormai da settimane abbiamo ripreso a convivere con l’incubo di quell’apocalisse nucleare che, nel segno di Hiroshima, ha a lungo tenuto sotto scacco la vita sul pianeta terra. Che cosa significa vivere in un mondo costitutivamente esposto alla possibilità di distruzione, domandava ad esempio negli anni Cinquanta dello scorso secolo Günther Anders? È una domanda che è stata successivamente ripresa e riqualificata dai movimenti ecologisti, ma che dobbiamo oggi tornare a porre anche rispetto alla guerra e agli armamenti nucleare.
Attorno a domande come questa non si può che auspicare la crescita tumultuosa di un movimento che potrà apparire di “opinione” ma che in realtà non potrà che essere intessuto di forme di vita, di istanze etiche e di principi di cooperazione del tutto materiali e capaci di confluire nel rifiuto della guerra. Sarebbe un errore contrapporre a un movimento di questo tipo la materialità della lotta di classe: si tratta piuttosto di lavorare affinché le lotte sociali (le lotte per il salario e per il reddito) attraversino – convergendo – la costituzione di questo movimento, ricavando da esso nuova forza per il proprio dispiegarsi. I più importanti movimenti degli ultimi anni, quello ecologista di cui già si è detto e quello transfemminista contro la violenza patriarcale, sono ponti essenziali per determinare questo movimento di convergenza. Senza di loro, anzi, quest’ultima non è né possibile né auspicabile. Inoltre: la convergenza contro la guerra non può che essere al tempo stesso convergenza contro la nazione, contro i vecchi e nuovi nazionalismi che alimentano la guerra. Di qui il ruolo fondamentale dei movimenti delle e dei migranti, dei movimenti antirazzisti.
Ho dunque proposto uno schema, necessariamente generale e astratto, per lavorare a una convergenza contro la guerra. Vanno tuttavia aggiunte alcune cose. La guerra solleva questioni che vengono oggi discusse secondo il registro della “geopolitica”. Una critica rispetto a questa prospettiva è necessaria, a partire dal fatto che essa subordina i rapporti sociali prevalenti in Paesi e regioni alle leggi di movimento di masse ctonie che sembrano spesso destinate a urtarsi, appunto attraverso la guerra. Sarebbe tuttavia errato non cogliere la rilevanza dei problemi che vengono così posti, e in particolare – in riferimento alla guerra in Ucraina – non coglierne le dimensioni e le implicazioni per la riorganizzazione in atto del sistema mondiale nel suo complesso.
Già lo si è detto in precedenti interventi: la guerra in Ucraina interviene in una fase di tumultuosa “transizione egemonica”, in cui la posizione di centro del sistema mondiale degli USA è oggettivamente messa in discussione da un insieme di movimenti e spostamenti di potere. Torneremo presto a descrivere questi movimenti e questi spostamenti, che hanno al centro spazi diversi da quelli degli Stati nazione europei e pongono in modo nuovo il tema dell’imperialismo. Intanto vale la pena sottolineare ancora una volta che storicamente le fasi di “transizione egemonica” nel sistema mondo del capitalismo moderno sono sempre state caratterizzate da una concatenazione di guerre più o meno catastrofiche. È una possibilità aperta anche nel nostro presente, come si vede d’altronde dalla rapida diffusione di un regime di guerra all’interno del sistema mondiale (riarmo, esercitazioni, toni nazionalistici esacerbati). Da questo punto di vista, la mobilitazione contro la guerra acquisisce ulteriori significati e una rinnovata urgenza: porre fine alla guerra in Ucraina per disarmare il regime di guerra.
Certo, lottare per la pace non significa per noi soltanto lottare per far tacere le armi. Significa lottare contro la violenza dello sfruttamento, del patriarcato, del razzismo, della distruzione dell’ambiente, contro la matrice della guerra in una società capitalistica: e da questo punto di vista, certo, nessuno Stato ci darà la pace che vogliamo, non possiamo che lottare per conquistarla giorno per giorno. Ma le condizioni in cui lottiamo, tanto in una singola città quanto a livello globale, non sono indifferenti! E oggi è nostro interesse che tacciano le armi in Ucraina, perché cessi la sofferenza delle popolazioni aggredite e perché si arresti una tendenza alla guerra che va ben oltre l’Ucraina. Evidentemente, non potrà che essere una iniziativa diplomatica a fermare in questo senso la guerra: la nostra mobilitazione deve avere l’obiettivo di imporla e di determinarne per quanto possibile forma e contenuti.
Non possiamo non rilevare, da questo punto di vista, alcuni importanti cambiamenti nelle ultime settimane. Intanto sul campo: alla ritirata russa da Kherson corrisponde un’intensificazione degli attacchi missilistici su tutta l’Ucraina, in particolare sulle infrastrutture civili. È uno schema estremamente pericoloso che può determinare una situazione di stallo nel corso dell’inverno, senza che vengano in alcun modo attenuate le sofferenze delle popolazioni civili. Contemporaneamente, sembra essere almeno in parte cambiato l’atteggiamento degli Stati uniti, che appaiono meno propensi a sostenere l’atteggiamento di assoluta intransigenza di Zelensky (in particolare rispetto alla riconquista della Crimea come condizione preliminare per un negoziato). Crepe e tensioni sembrano emergere anche all’interno del governo ucraino.
Quali sono le ragioni di questo mutato atteggiamento statunitense? Non è facile dirlo, anche se certamente pesano sia l’assestamento del sistema politico interno dopo le elezioni midterm sia le crescenti difficoltà dell’economia americana. Vorrei però avanzare un’ipotesi ulteriore, certo bisognosa di ulteriori verifiche. Il vertice G20 di Bali, nella sua preparazione, e l’incontro Xi Jinping possono avere messo Biden e l’amministrazione statunitense di fronte al fatto che la realtà del potere mondiale ha oggi un livello di complessità tale da impedire forzature unilaterali anche in Ucraina. Il peso di potenze emergenti come l’India e la stessa Indonesia può avere reso chiara l’esigenza di un sistema di pesi e contrappesi che non può essere gestito in modo unilaterale dagli USA, dall’Occidente, e in ultima istanza da nessun attore. Il fatto che il Jacarta Post, nel fare un bilancio del vertice, sottolinei che dopo l’India (che l’ha assunta dopo l’Indonesia) la guida del G20 spetterà al Brasile e al Sudafrica mi sembra particolarmente rilevante in questo senso (Dwi Atmanta, “Mission accomplished,” Jakarta Post, 18.11).
Ripeto, è solo un’ipotesi, da verificare nelle prossime settimane. Può però dare qualche indicazione sulle prospettive della pace in Ucraina. Se un’iniziativa diplomatica in questo senso si aprisse, del resto, molte questioni andrebbero discusse, a partire da quelle al centro dello scontro tra Russia e Ucraina. Più in generale, si porrebbe il problema di riorganizzare il rapporto tra la Russia e l’Europa (quel rapporto che, in particolare in riferimento al gas e ai gasdotti, figura certo tra le cause della guerra). È su questo terreno che un’iniziativa autonoma europea appare oggi al tempo stesso necessaria e impossibile. Il vero e proprio mutamento costituzionale dell’Unione europea a partire dallo scorso febbraio (lo spostamento verso est del suo baricentro, il ruolo di traino della Polonia, la crisi dell’asse franco-tedesco, l’emergere di un assetto “confederale”) rendono in effetti molto difficile immaginare un’iniziativa capace di far valere un interesse europeo autonomo da quello americano nel rapporto con la Russia. E tuttavia quest’iniziativa è necessaria per allentare le tensioni e per rilanciare un progetto democratico nel continente europeo. In Italia e in Europa, la mobilitazione contro la guerra e il movimento di convergenza che la attraversa devono farsi carico anche di questo problema.