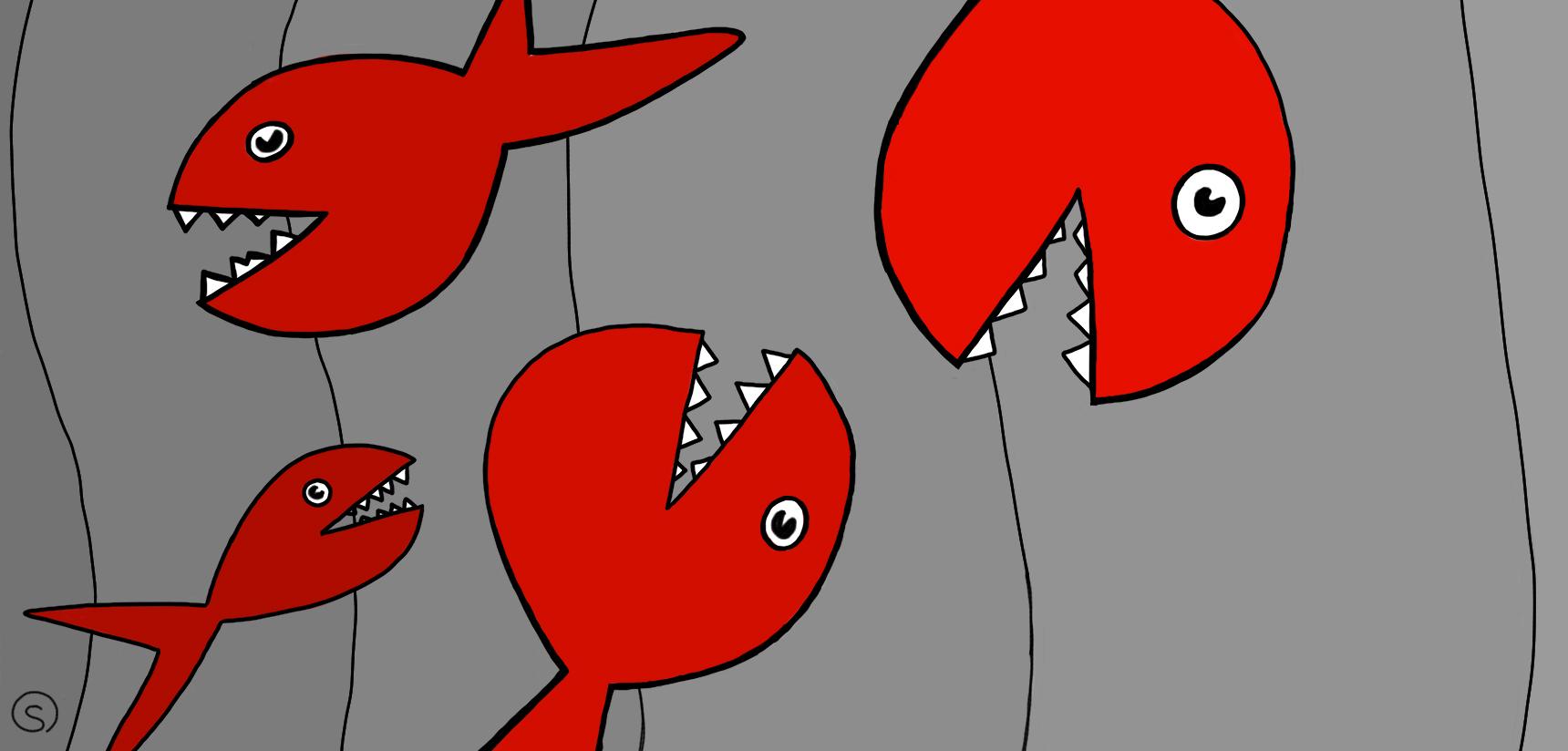di FRANCESCO RAPARELLI.
C’è una bella foto sulla copertina di Storia di un comunista. Chi conosce bene l’autore, Toni Negri, riconosce quel sorriso. Un tratto singolare, quasi un modo di essere.
Con lo stesso sorriso, si immagina, Negri deve aver accolto le recensioni alle sue memorie: una risata materialista contro l’odio del Potere. Sì, un odio quasi smisurato è stato gettato sul libro, da Repubblica come dal Sole 24 Ore. Un odio volgare, invidioso, efferato. Contro l’autore, indubbiamente, ma più diffusamente contro un evento: il lungo ’68 italiano. Evento di cui l’autore è stato parte, tra molti, molti altri. Evento durato un ventennio, da Piazza Statuto (luglio del 1962) fino alla primavera del 1977. Evento che Negri ricostruisce, con amore, e che rilancia oltre la sconfitta, la repressione.
Scrive: «ma chiediamoci di nuovo perché il ’68 è tanto odiato dal potere civile e considerato immorale dal potere religioso? Perché incarna la coerenza del pensiero e dell’azione – costruire un mondo nuovo dentro e fuori da noi stessi: perché l’unione del dentro e del fuori è per sé una potenza rivoluzionaria, è la riforma sempre aperta di se stessi – di questo ha bisogno la rivoluzione. È l’anima che si riconosce nel corpo e viceversa, la singolarità che risorge nella moltitudine: la distruzione di ogni ideologia del potere – di ogni metafisica». Risuona con forza, in queste parole, l’hæcceitas negriana: la combinazione produttiva tra operaismo ed «estetica dell’esistenza», Marx e Spinoza, San Francesco e i cinici. E si chiarisce perché, nonostante la sconfitta dei movimenti avvenuta ormai diversi decenni fa, la borghesia italica, o quel che ne resta, non riesca a dormire sonni tranquilli. Per dirla con Deleuze, a fare ancora paura è il «divenire-rivoluzionario» che ha segnato quel ventennio, «anomalia selvaggia» nel panorama europeo e mondiale. A maggior ragione in un paese, oggi più di ieri, dominato da classi dirigenti corrotte, provinciali, prive di virtù, addirittura di buon gusto.
Certo, la stampa si è presa la sua rivincita. Dopo il successo di Impero e del suo ciclo, le memorie sono sembrate l’occasione propizia per la vendetta. A segnalare che la «ferita-Negri» – nonostante le sue pagine si leggano in tutto il mondo – non può essere rimarginata. E allora varrebbe la pena capire di più e meglio perché, oltre l’incubo del ’68, non ci sia pace per questo filosofo materialista, per il racconto appassionato del suo tempo. Quante volte ancora l’establishment italico dovrà condannare Toni Negri?
Lo scandalo, ciò che non può essere perdonato, è lo stile. Con una formula: «dentro e contro». Un intellettuale, anche brillante, deve stare al suo posto. Così vuole lo Stato, così vuole il Capitale. Fuori dalle lotte di classe, esterno al divenire classe operaia – nello scontro per il salario, nel rifiuto del lavoro – della forza-lavoro. Toni Negri, brillante come pochi, al suo posto non c’è mai stato. Da Quaderni Rossi a Classe Operaia, dal gruppo Potere Operaio al movimento dell’Autonomia Operaia, la vicenda collettiva di Negri fa saltare i perimetri. Perché solo a partire dalle lotte è possibile costruire il politico: l’immanenza alla quale «il professore e il militante» non ha mai smesso di essere fedele. Nella costruzione del politico, neanche a dirlo, non sono mancati i passaggi a vuoto, le incertezze e gli errori. Ma l’immersione nel reale, con la sua durezza, quella no, non è mai venuta meno. Uno scandalo, appunto, pensare che chi studia e scrive senza sosta, mattina e sera, possa seguire passo passo le lotte del Petrolchimico di Porto Marghera. E non si trattava tanto di «identificarsi con la classe operaia, ma [di] viverci assieme: dalla mattina alle 5 – prima della distribuzione dei volantini – alle riunioni di informazione e progetto, fino all’ultima presenza sulle porte all’entrata del terzo turno alle 22».
Nulla di eroico, intendiamoci. Piuttosto la storia di un comunista. Articolo indeterminativo, non casualmente, perché si è comunisti solo nella prassi collettiva, nella forma di vita, nella potenza impersonale degli affetti. Il resto sono chiacchiere. Pure fastidiose. Negri lo afferma con chiarezza quando, in riferimento alla sua formazione giovanile, si definisce comunista e non ancora marxista, quando comincia «a sviluppare la carità e l’amore cristiani in azione politica socialista». E lo afferma ancora quando, da operaista, ricorda l’adagio: «chi non fa inchiesta, non ha diritto di parola». Inchiesta: leggi «intervento di fabbrica», militanza di base tra i poveri, con i poveri. Ma inchiesta significa anche costruzione del sapere nelle lotte, nella cooperazione sociale che eccede il lavoro comandato, che scavalca i cancelli della grande industria. Dunque sono belle le pagine in cui Negri racconta i suoi studi, dall’Historismus a Weber, da Lukács a Merleau-Ponty, dalla scoperta di Marx a Descartes. Ma sono emozionanti perché subito si intrecciano con il volantino e il picchetto, gli scioperi estivi e gli scontri a Porto Marghera (1967, 1968, 1970), e via fino a Torino, corso Traiano (luglio 1969).
Docente di Dottrina dello Stato, il più giovane ordinario d’Italia. Nemico dello Stato. Un paradosso che ancora non può essere perdonato. A pensarci bene, è la critica stessa a essere un paradosso inaccettabile per un sistema di potere incapace di aprirsi alle lotte democratiche, degli operai, degli studenti, dei nuovi soggetti proletari che fanno la loro comparsa a partire dalla metà degli anni Settanta. La borghesia italica risponde con le bombe, con i morti ammazzati nelle strade. Il PCI è complice, Cossiga lo ha chiarito fin troppe volte, ma Negri non può dirlo. Se lo dice, così le penne benpensanti, vuol dire che non si è pentito. No, Negri è un comunista non pentito. Come un comunista combina la critica pratica dello Stato con l’invenzione di nuove istituzioni del lavoro vivo. E, se c’è una violenza che non rinnega (e perché dovrebbe?), è l’illegalità diffusa delle rotture operaie, le auto-riduzioni delle bollette, l’«appropriazione di massa» nei supermercati: «fonti normative» di una Repubblica che non ammette il monopolio della forza da parte del Leviatano, né la prevaricazione sanguinaria della proprietà privata.
Lo scandalo riguarda Negri, l’intellettuale fuori posto. Ma lo riguarda perché, assieme a lui, e a tanti intellettuali fuori posto come lui, sono tanti gli operai che smettono di recitare la parte che gli è stata assegnata. L’evento in questione parla di operai che reinventano Marx nelle lotte per il salario, nel sabotaggio, e di marxisti che imparano a studiare nel picchetto, nel cambio di turno. Non è un caso dunque che il frutto più rilevante del ’68 sia l’intellettualità di massa, la trasformazione in senso cognitivo e linguistico del lavoro, delle tecnologie. E una gran paura del Capitale che, proprio in questi anni sul piano globale, avvia la sua fuga verso la rendita, la finanza, i valori immobiliari. Una sorta di esodo dal rapporto con il lavoro vivo, giunto a maturazione con lo sconquasso della crisi dei mutui subprime e dei debiti sovrani. Fa bene Negri, ma anche questo non gli viene perdonato, a vedere nel Movimento del ’77 la verità del ’68 italiano. In ritardo rispetto all’Europa, ma forse anche un passo avanti: «la prima, decisiva apparizione di una nuova antropologia del lavoro: l’affermazione di una nuova forza-lavoro socializzata e intellettualizzata». Ma è proprio quando la tendenza conquista la scena – un’irruzione senza precedenti – che gli arnesi politici e organizzativi forgiati in un ventennio di lotte girano tutti a vuoto. Tra Parigi e l’Italia il problema viene sentito, drammaticamente. Non viene superato. Si impone, invece, lo scontro tra Stato e partito armato, con il disastro che conosciamo. Iniziato nella grande repressione con la quale le memorie di Negri si chiudono, il disastro si è trascinato con i suoi effetti nefasti in un paese che, di Repubblica in Repubblica, non muove più un passo. Bloccato dal punto di vista produttivo oltre che politico; fallito, allo sbando.
Ho avuto la fortuna di conoscere l’autore, per la prima volta, in una saletta teatrale romana poco battuta, d’altri tempi. In semi-libertà, prima del successo di Impero, l’unica cosa che gli stava a cuore era rilanciare l’inchiesta, afferrare le forme di vita metropolitane, cogliere le trasformazioni del lavoro in una Capitale sempre un po’ di provincia. Dopo aver imparato dalle nuove lotte parigine, quelle del ’94 e del ’95, imparare di nuovo, da un gruppetto di giovani studenti attivi nell’ateneo più grande d’Europa, la Sapienza, che di lì a qualche anno sarebbe diventato ancora una volta scenario di lotte, l’Onda e molto altro. No, la tenacia e la curiosità di un comunista, che come un bambino ricomincia sempre da zero, il Potere non può accettarla. È uno scandalo da condannare, e da condannare ancora.