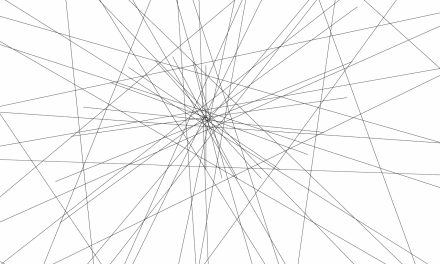di MAURILIO PIRONE.
Lo spettro della devianza e l’apertura di spazi di partecipazione
Il tornello è un dispositivo di sicurezza dalla storia piuttosto recente. Sembra che la sua invenzione si dovuta allo statunitense Clarence Saunders il quale lo installò per la prima volta nel suo shop self-service Piggly Wiggly (poi divenuta una nota catena americana) nel 1916; il tornello serviva ad impedire l’uscita dal negozio senza pagare. Prima della loro introduzione era il venditore a selezionare e mostrare i prodotti al compratore. La locandina che pubblicizzava il negozio di Saunders recitava: “through the turnstille to a land of adventure” [attraverso il tornello verso una terra d’avventura]; l’altro slogan era “make your own decision” [decidi da solo]. Il varco del tornello era presentato come l’accesso a uno spazio di libertà di consumo in cui questa libertà era, da un parte, acquistata da chi poteva pagare e, dall’altra, negata a chi restava fuori.
Questa funzione produttiva (di un consumatore “libero”) si affiancava a quella selettiva (tra chi è titolato ad accedervi e chi no) anche se col tempo la seconda ha ottenuto sicuramente più visibilità.
Nel giro di non molto tempo i tornelli iniziarono ad essere installati anche in prossimità dell’accesso ai mezzi di trasporto (in particolare le metropolitane) per consentirne l’uso solo a chi avesse acquistato il titolo di viaggio. In questo caso il tornello è la porta di accesso alla città, in particolare al suo centro. Chi ne resta escluso rimane confinato spesso nella periferia.
Gli stadi sono il luogo che negli ultimi anni ha subito maggiormente questa tipologia di normazione; il tornello è stato presentato come uno dei meccanismi per eliminare il rischio di disordini durante le partite ad opera di soggetti indesiderati come gli ultras. In realtà più dei varchi di accesso hanno potuto misure amministrative e penali come il Daspo che si basano sulla criminalizzazione della persona (piuttosto che sul giudizio del singolo fatto).
In questi giorni le cronache nazionali hanno dato ampio risalto alle proteste scoppiate all’Università di Bologna attorno all’installazione di tornelli all’ingresso della biblioteca di discipline umanistiche in via Zamboni 36 (qui si trova una buona ricostruzione dei fatti). Strana – verrebbe da pensare – tutta questa attenzione per una vicenda che parrebbe di carattere locale. 
A mio avviso, sono due gli elementi che vanno presi in considerazione per provare a comprendere quanto accaduto.
Il primo è il processo di trasformazione che sta attraversando da alcuni anni l’Università di Bologna, sempre più orientata verso un modello di elité fatto di campus e percorsi e d’eccellenza. Non è un caso che le proteste studentesche degli ultimi mesi si siano concentrate attorno a problemi come il costo della mensa, il problema affitti, la riduzione dell’accesso alle borse di studio. Tutti nodi che mettono in evidenza la difficoltà sempre maggiore ad accedere a quel tipo di istituzione e il cambiamento in atto rispetto alla composizione studentesca desiderata, che per la città rappresenta una importante fonte di guadagno economico.
Il secondo è la specificità territoriale di via Zamboni. Da tempo questa strada costituisce materialmente una delle sedi storiche della partecipazione politica e sociale alla vita dell’Università, luogo di conflitti e innovazione in un rapporto dialettico tra studenti e città. La biblioteca del 36 è pregna di questo spirito – come hanno affermato in questi giorni molti di quelli che la frequentano. Non si tratta di una semplice biblioteca, di uno sterile erogatore di servizi. Il 36 è un luogo nel senso pieno della parola, uno spazio di relazioni, discussione, partecipazione, contraddizioni. Questa specificità è quella che non viene colta da chi riduce la questione a un semplice problema tecnico (badge si/badge no).
Un luogo del genere all’interno di una mondo della formazione che si trasforma sempre più in una industria di capitale umano costituisce una anomalia. Come spesso accade, i più lucidi dei detrattori a volte sono in grado di mettere in chiaro quali sono i termini del discorso, schierandosi – purtroppo per loro – dalla parte sbagliata. In un articolo di venerdì scorso apparso su Il Foglio le proteste che da mesi vanno avanti a Bologna attorno allo spazio universitario sono presentate come lo scontro fra chi vede nell’istruzione un processo orizzontale e aperto a tutti e chi invece vuole farne un luogo di competenze ristrette a pochi “meritevoli”. La funzione di spazio pubblico dell’Università è contrapposta a quella di ambito privato basato su logiche di business: formare cittadini – nel senso alto, rivoluzionario del termine ovvero partecipanti alle dinamiche politiche e sociali degli spazi in cui vivono – oppure formare capitale umano altamente qualificato da spendere profittevolmente sul mercato del lavoro. L’installazione di tornelli al 36 quindi assume il chiaro valore, sia materiale che simbolico, di violazione di uno spazio eterotopico non sussunto da quel paradigma paternalista/aziendalista.
Molto si è detto sulle motivazione di questo dispositivo. In tutti i casi si è trattato di istanze securitarie volte a impedire l’accesso alla biblioteca a soggetti indicati come socialmente pericolosi: tossicodipendenti, molestatori, ladri. Lo spettro della devianza è agitato come strumento per imporre una normazione fittiziamente neutrale ad uno spazio auto-nomo (ovvero con regole sue proprie). La stessa partecipazione politica è descritta come una devianza nella narrazione becera dei giornali che contrappongono i collettivi (cattivi) agli studenti (vittime): l’università è presentata come un luogo neutro, di semplici servizi, crediti e lezioni rispetto ai quali qualsiasi eccedenza costituisce un corpo estraneo. Forse non è un caso che proprio in questi giorni si discuta di un nuovo (ennesimo) pacchetto sicurezza che interviene sulle città riproponendo la figura del sindaco-sceriffo – quello di Bologna, noto per la lunga lista di sgomberi effettuati negli ultimi anni, si è dichiarato da subito favorevole – per colpire quei soggetti deviati perché stigmatizzati come pericolo per la pace sociale (mendicanti, migranti, writers, dimostranti). Le logiche securitarie, come è noto, nascondono ben altro. Molto spesso sono integrate in processi di trasformazione più larghi. Scrive Tamar Pitch a proposito del pacchetto Minniti: “ciò che conta è che le città diventino pulite e asettiche vetrine di beni di consumo, attraenti per i turisti ricchi e gli investimenti delle grandi corporations”.
 Cosa può un tornello? Di sicuro non può risolvere il problema della violenza di genere, tanto meno affrontare la questione dell’uso di sostanze. Chi lo afferma non è semplicemente in buona fede, anzi opera una strumentalizzazione di alcuni soggetti (le donne, gli studenti) per imporre loro una condizione di subalternità patriarcale (la presunta fragilità è utilizzata per giustificare l’esercizio di un potere dispotico che li protegga in loro vece). Il tornello non elimina una cultura maschilista che fa del corpo della donna un oggetto a disposizione, tuttalpiù la nasconde dietro la falsa promessa di sicurezza. Questo può farlo solo l’autodeterminazione delle donne e la diffusione di pratiche di genere – come sta facendo il percorso Non una di meno. Allo stesso tempo, il tornello serve solo a nascondere la progressiva distruzione di servizi di assistenza e aiuto rispetto all’uso di sostanze. Non è un caso che Bologna sia la città con più morti l’anno per tossicodipendenza per mancanza di servizi di prossimità.
Cosa può un tornello? Di sicuro non può risolvere il problema della violenza di genere, tanto meno affrontare la questione dell’uso di sostanze. Chi lo afferma non è semplicemente in buona fede, anzi opera una strumentalizzazione di alcuni soggetti (le donne, gli studenti) per imporre loro una condizione di subalternità patriarcale (la presunta fragilità è utilizzata per giustificare l’esercizio di un potere dispotico che li protegga in loro vece). Il tornello non elimina una cultura maschilista che fa del corpo della donna un oggetto a disposizione, tuttalpiù la nasconde dietro la falsa promessa di sicurezza. Questo può farlo solo l’autodeterminazione delle donne e la diffusione di pratiche di genere – come sta facendo il percorso Non una di meno. Allo stesso tempo, il tornello serve solo a nascondere la progressiva distruzione di servizi di assistenza e aiuto rispetto all’uso di sostanze. Non è un caso che Bologna sia la città con più morti l’anno per tossicodipendenza per mancanza di servizi di prossimità.
Di sicuro la lotta contro i tornelli ha riattivato la partecipazione degli studenti alla vita politica della città. Ha permesso l’apertura di uno spazio di protagonismo e partecipazione non etero-diretta attraverso il rifiuto di un paradigma securitario e aziendalista per il quale spazi e logiche eterotopiche non sono ammessi, pena la loro chiusura e l’uso della forza. Cosa potrà essere non è facile dirlo. E forse non è questo il punto. Sta a quello spazio di protagonismo generazionale – emancipato dall’ordine patriarcale del discorso sui “bamboccioni” viziati e incapaci che per anni è stato portato avanti in nome della rinuncia a qualsiasi pretesa o desiderio rispetto alla totale disponibilità alla messa a lavoro – produrre un campo di azione e rivendicazione. In ogni caso questa può essere un’occasione da cogliere. Un messaggio che da Bologna va ben oltre. E ci parla della necessità di sviluppare conflitti per riaprire spazi di autonomia moltitudinaria rispetto al grigiore di un presente sempre più schiacciato fra la sofferenza individuale spinta fino al suicidio e la socializzazione dell’odio per il diverso, fra la retorica legalitaria e securitaria incarnata dalle frontiere e la tentazione dell’uomo forte al comando. Riprendere in mano le proprie vite – come fonte di produzione economica e sociale – contro la subordinazione a logiche manageriali e patriarcali.