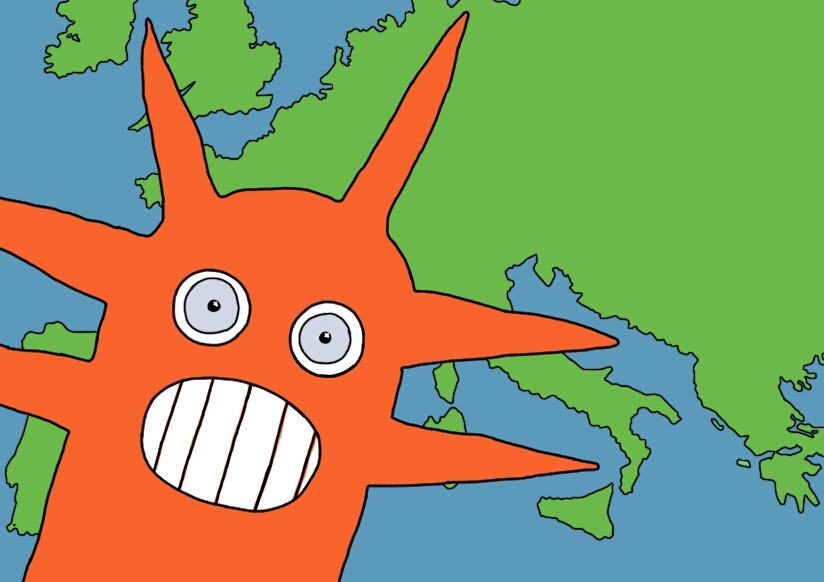di TONI NEGRI.
È probabile che siamo davvero giunti alla fine dell’Europa che conoscevamo, nella quale siamo cresciuti e nella quale abbiamo lottato. Alex ha ragione. L’Unione Europea è fallita su Schengen, su Dublino, sul brexit – e cioè sulla politica della circolazione interna dei lavoratori, del controllo delle migrazioni e del rapporto con il mondo atlantico. Ma soprattutto il fallimento è stato quello di un metodo: la costruzione di un’“unità doganale” pensando che lo sviluppo giuridico di questa potesse portare alla costituzione di un’entità culturale e politica. Si è privilegiata la costituzione di un mercato alla costituzione di un popolo. Anche su questo Alex ha ragione: il suo testo merita attenzione perché a partire da questa fase di profonda crisi si pone una domanda essenziale: in nome di quale Europa vogliamo ora muoverci? Quale Europa desideriamo? Un’Europa unificata e federale, che protegga e sviluppi il contesto di libertà che la cultura democratica propone?
Ci sono due maniere per rispondere a queste domande. La prima è quella che Alex propone. Ci dice: è inutile cercare un’“altra” Europa; alla ricerca di questa siamo stati sconfitti; ora dobbiamo cercare alleanze che ci permettano di costituire un fronte, meglio, una coalizione che permetta di salvare il progetto europeo da una possibile dissoluzione. Se vogliamo un’Europa riunificata e federale dobbiamo muoverci su un terreno realistico, misurare le forze e comprendere che solo attivando “buonsenso democratico” potremo raggiungere quel fine.
C’è tuttavia una seconda linea, probabilmente meno chiara ma, credo, altrettanto degna di esser messa in discussione. Anch’essa parte dalla constatazione della crisi di questa Europa. E tuttavia non si limita a deprecare gli esiti della crisi o a denunciare, con il metodo, la sua genealogia. Si chiede piuttosto quali siano le forze che ci hanno illuso (qualora mai lo fossimo stati) che l’Europa potesse essere così costruita e riconoscono questa responsabilità in quel movimento di liberismo economico e in quella politica ordoliberale che fin dall’inizio hanno presieduto ai destini europei. Se dunque oggi è difficile pensare un’“altra” Europa, è difficile credere che possa esistere un “buon senso” democratico abbastanza efficace da battere quella prepotenza liberista ancora egemone. Tanto più che la crisi dell’Europa non è percepita semplicemente da noi, buoni e generosi sudditi, ma è avvertita soprattutto dalle élites europee: all’interno dei singoli paesi esse stanno difendendosi dalla crisi attraverso una ristrutturazione costituzionale bastata sull’emergenza. Non sorge a questo punto il sospetto che illudersi di poter rispondere “laicamente” alla crisi, possa essere cecità nei confronti dell’attuale disporsi del ceto dominante europeo?
Alex chiede che si dia un fondamento di realpolitik all’azione degli attivisti europei nel prossimo periodo. C’è qui, credo, una sottile ma evidente polemica dentro questa esortazione – Alex diffida di una battaglia politica che unisca “Europa e Commonwealth”. Per Commonwealth intendo una politica efficace sul terreno monetario, economico e sociale che riorganizzi la società europea su uno schema costituzionale retto da una “pratica del comune”. Alex ne ha forse intuito il formarsi attorno alla proposta costituente prodotta da DiEM25 e da Varoufakis. Io credo invece che questa preoccupazione non possa e non debba darsi. Sono convinto che non c’è possibilità di ricostruire l’Europa, di muoversi in maniera realista a questo scopo, se non ci si libera da quell’élite liberale, inefficiente e corrotta che ci ha portato a questo punto, che si è consolidata nelle istituzioni europee facendone uno strumento di austerità e che ora tenta di salvare il proprio potere attraverso politiche di emergenza.
Resta l’altro corno del problema che Alex ha proposto: come collocare sul livello internazionale la ricostruzione di un progetto europeo. Direi che questa proposta di discussione è in generale carente e nel pezzo di Alex troppo succinta. Inutile ricordare che spesso si tratta di chiacchiere da caffè. Non è detto che le nostre non lo siano. Proviamoci. In questo caso bisognerebbe ripartire da un’osservazione centrale e chiedersi se gli Stati Uniti abbiano mai voluto la costruzione di un’Europa indipendente e potente. Finché l’Europa unita poteva costituire un bastione contro il socialismo sovietico, poteva andare; ma ora che farsene? Per quale beneficenza autolesionista aiutare un possibile concorrente – l’Europa unita – sul mercato e nella cultura? L’asse politico della politica americana si sta sempre di più spostando sul Pacifico. Il liberalismo europeo, soprattutto quello che oggi governa i paesi dell’Est-Europa, sta subendo questo spostamento strategico degli interessi americani, ne è consapevole e ne soffre. È il rapporto USA/Cina che è ormai al centro di ogni dibattito di politica internazionale e rappresenta il punto di caduta di ogni opzione o previsione nei foreign affairs. I liberali dell’Est-Europa si sentono abbandonati e tanto più, quindi, spingono per determinare ulteriori emergenze allo scopo di consolidare la loro attuale condizione dominante, all’interno dei loro piccoli e sgraziati paesi. La guerra ucraina e la ripresa dell’iniziativa della NATO su quel fronte risultano effetti perversi da quella nuova insicurezza. Altrettanto vale per i paesi legati all’Europa nel Mediterraneo orientale. Dalla Turchia ad Israele la tensione di insicurezza che essi vivono (una volta spostatosi l’asse strategico americano sul Pacifico) si esprime in una forsennata volontà di emergenza e di guerra. [È probabile che tutte queste siano chiacchiere da caffè. Sicuramente non lo è – ringraziando il cielo – il fatto che Obama sia riuscito a concludere l’accordo con l’Iran: questo permette di spostare i tempi di una guerra altrimenti vicina e potrebbe aiutare il concentrarsi delle opposizioni al feroce islamismo mediorientale.]
Che cosa vuol dire realpolitik in questo quadro? In nome di quale Europa possiamo muoverci? Vi sono alcuni “no” che si possono immediatamente dire: siamo per un’Europa che non si impegni in continue scaramucce belliche sull’Est del continente e in Medioriente. Siamo per un’Europa che tuttavia si riconosca come “penisola asiatica”, che prenda dunque coscienza che lo spostamento strategico dell’asse egemonico americano (presto seguito dal Regno Unito) ci lascia, se non soli, certo con un padrone meno sollecito, in un ambiente di forte crisi e trasformazione. Di qui – e questa è anche la consapevolezza dei ceti neoliberali dominanti chez nous – un aumento precipitoso di insicurezza e di incertezza. Ma anche molti diversi giochi potrebbero e possono qui aprirsi. Dire che questa insicurezza e incertezza non tocchino anche noi, sostenitori di una repubblica europae, sarebbe stolto. Ma la cosa più stolta sarebbe il non prendere coscienza di questa nuova situazione e dei pericoli che essa determina, che non sono solo quelli di una dissoluzione di questa Europa ma anche quelli di una sua permanenza. Questa permanenza non potrebbe che darsi nella costruzione di un ulteriore accentramento di poteri sulla base di una politica di emergenza continua sia nelle singole nazioni, sia a Bruxelles. Una sorta di fascismo molle che invade le strutture politiche di Europa e dei paesi europei. Prima della catastrofe. Perché così l’Europa non può continuare. A questo punto la crisi dei migranti e quella dei costi della circolazione interna dei cittadini europei sembrano cadere a puntino.
A me sembra che una realpolitik per l’Europa (e non parlo di una scienza sovrana ma di quello che possiamo fare) oggi non possa, caro Alex, che formarsi attorno alla seconda ipotesi indicata sopra: “Europa e Commonwealth”. È sì un’“altra” Europa rispetto a quella che fin qui abbiamo vissuto ma è anche l’unica Europa che potrà esistere. Per arrivare a questo risultato, dovremo provarci a costruire una forza europea in movimento che riplasmi un percorso europeista e federalista. Non è detto che ci riusciamo. Può darsi tuttavia che altri ci riescano. Comunque, se questo non avviene l’Europa davvero finisce ed è male che finisca – ma, come dicono i miei compaesani, “no xe pol cavar sangue dai muri”, in latino “ad impossibilia nemo tenetur”.