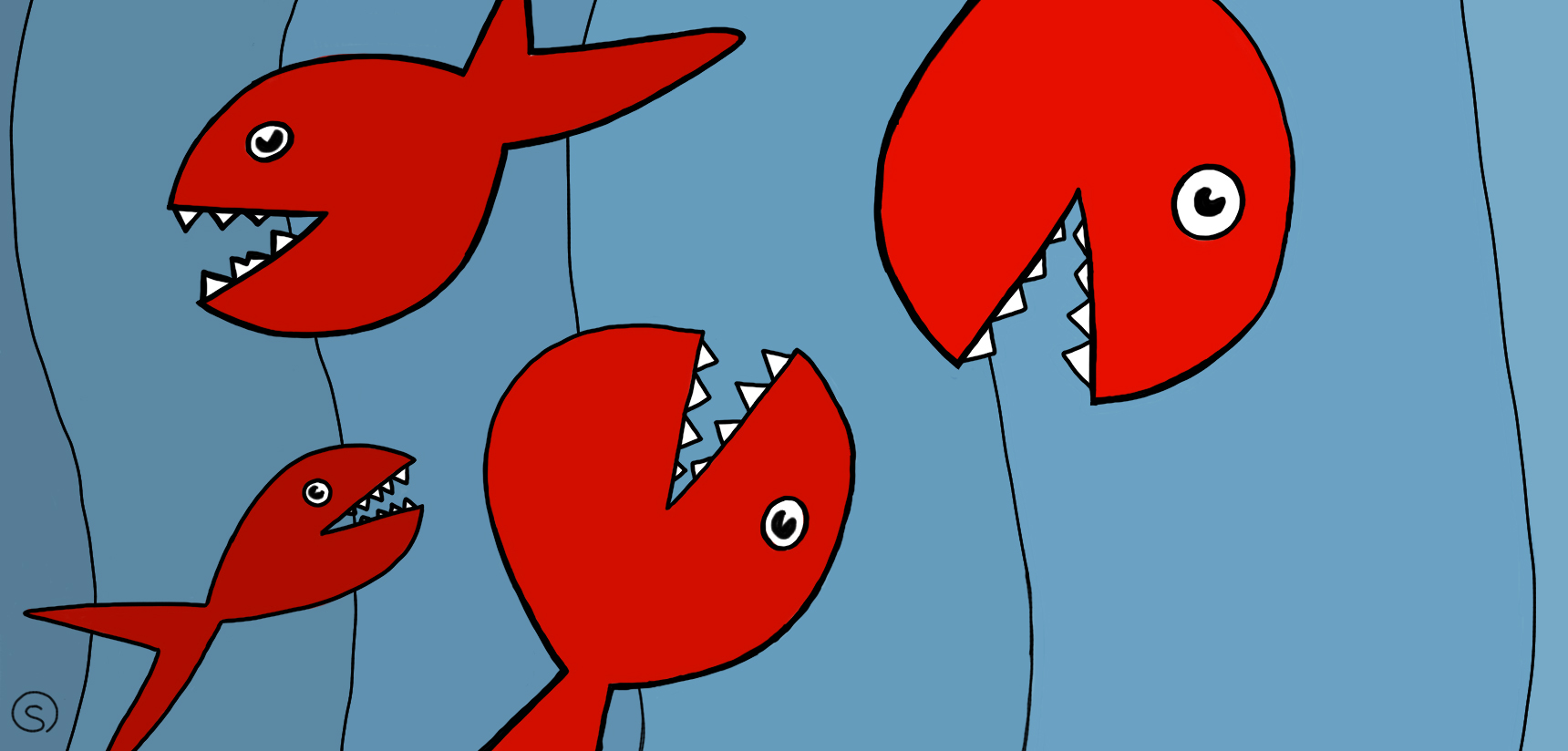di MARIA ROSARIA MARELLA.
Il disegno di legge Cirinnà, nella struttura, nelle intenzioni e nella discussione pubblica che lo ha accompagnato sin qua, esemplifica o, meglio, tende a essere liquidato come una vicenda persino un po’ ridicola e comunque tutta italiana, che un osservatore esterno e digiuno di cose italiche troverebbe incomprensibile e illogica, a cominciare dallo stralcio della norma sulla step-child adoption immediatamente seguito dall’annuncio dell’imminente (ed ennesima) legge di riforma dell’adozione. Ma come sempre accade, uno sguardo più largo, volto a inquadrare le scelte che quel testo sottende dentro linee di tendenza che si registrano a livello globale, consente poi di leggere in controluce l’evoluzione del diritto di famiglia nazionale degli ultimi anni e di coglierne i risvolti (biopolitici) meno evidenti e gli obiettivi non dichiarati. La prendo un po’ alla lontana e traendo spunto da un recente convegno cui ho partecipato1 tento una breve analisi a partire dal diritto umano alla bigenitorialità.
1. Il riconoscimento dei diritti umani è, come noto, uno dei caratteri distintivi del diritto globalizzato nell’attuale fase della sua diffusione. Esso per sua natura si articola attraverso l’individuazione di specifiche e differenti identità che tendono a frammentare la soggettività giuridica per genere, età, razza, orientamento sessuale, ecc., in tal modo occultando le condizioni economiche e sociali che nella realtà connotano le singole forme di vita (e con ciò il progetto politico che sta dietro l’individuazione di tali specifiche identità). In seno alla retorica dei diritti umani un capitolo importante è dedicato ai minori, i quali rispetto al passato hanno acquisito un’inedita centralità nel discorso giuridico multilivello, ponendosi come soggettività autonoma e distinta rispetto alle famiglie d’origine e ai genitori. Convenzioni internazionali e carte dei diritti sovranazionali e nazionali riconoscono oggi diritti precipuamente modellati sui bambini, volti a garantire loro tutela a prescindere dalla protezione accordata alle loro famiglie e talora esplicitamente contro le famiglie stesse. Parallelamente una folta giurisprudenza intitolata al best interest of the child si è diffusa in ogni giurisdizione di quella area che fino a qualche tempo fa è stata chiamata Western Legal Tradition.
In questa cornice si iscrive il diritto alla bigenitorialità, inteso come diritto del figlio a ricevere cura, educazione e sostegno da entrambi i genitori, che, almeno nelle formulazioni generali che attualmente conosce, può ritenersi un diritto di nuova generazione.
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989) all’art. 9, comma 3 stabilisce che “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”. L’art. 8 CEDU, intitolato al rispetto della vita privata e familiare, garantisce per giurisprudenza consolidata il diritto del minore di conservare le sue relazioni familiari con entrambi i genitori. Il 7° Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmato a Strasburgo il 22 novembre 1984, all’art. 5, rubricato «Uguaglianza degli sposi», prevede che: «I coniugi godono dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento. Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell’interesse dei figli». E la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea all’art. 24 sancisce espressamente il diritto di ogni bambino “di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i due genitori salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse”.
Precedentemente erano intervenute due raccomandazioni del Consiglio d’Europa, emanate rispettivamente il 28 febbraio 1984 – in tema di «responsabilità genitoriale» – e il 5 febbraio 1985 – in tema di protezione contro le discriminazione sessuali e segnatamente di uguaglianza fra uomo e donna nell’adempimento delle responsabilità familiari e nell’esercizio della potestà genitoriale – che invitavano gli Stati membri a dotarsi di modelli di affidamento dei minori che coinvolgessero entrambi i genitori.
Arriviamo così alle ricadute sul diritto nazionale, in particolare alla discussa legge 8 febbraio 2006, n. 54, la quale proprio alla luce del diritto alla bigenitorialità ha riscritto la disciplina dell’affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione, di divorzio, nei casi di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. In sostanza questa legge prevede che “Anche in caso di separazione personale dei genitori [e casi ad essa equiparati dalla legge stessa, n.d.r.] il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (art. 155 c.c. come riformato dalla legge 54/2006 – successivamente abrogato).Pertanto i figli devono essere affidati come regola ad entrambi i genitori e soltanto come eccezione ad uno di essi, quando lo imponga l’interesse del minore oppure quando l’affidamento condiviso determini una situazione di pregiudizio per il minore stesso. Si opera con ciò un ribaltamento di prospettiva nella considerazione del rapporto tra genitori e figli, ora non più disciplinato a partire dai doveri e dai poteri dei genitori nei confronti del minore, ma piuttosto in ragione del diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, anche nelle ipotesi di elevata conflittualità tra i genitori, e anche dopo la disgregazione del nucleo familiare. In realtà in Italia la legge sull’affido condiviso pur conformandosi, come si è visto, ad una tendenza diffusa a livello globale, è stata cavalcata in modo strumentale da un movimento di padri in cerca di rivalsa. Come avvertiva Letizia Gianformaggio2 all’epoca della presentazione della proposta di legge (siamo nel 2002), già la sua relazione introduttiva appariva, sin nel linguaggio utilizzato, esplicita nel giocare il diritto dei figli minori contro le madri, colpevoli di volersi scuotere di dosso ruoli di genere tendenti a subordinarle in nome dell’interesse superiore all’unità della famiglia. E in effetti dietro la legge si cela l’ansia per le sorti di un’istituzione giudicata ormai in crisi.
2. L’ultima riforma, quella che ha cancellato la distinzione fra figli naturali e figli legittimi, ha completato il quadro in cui il diritto alla bigenitorialità si iscrive, integrandolo. Con lo stabilire un unico stato di figlio, la riforma del 2012-13 (vale a dire la l. 219/2012 e il d.lgs. 154/2013) ha ridisegnato la filiazione biologica ascrivendo nuovi diritti ai figli: il diritto alla cura e il diritto a crescere in famiglia, mantenendo significativi rapporti coi parenti, emergono come tratti distintivi di una nuova relazione genitori-figli che permane con questi caratteri anche oltre la maggiore età, con ciò sancendo per legge anche il ruolo della famiglia come ammortizzatore sociale (art. 315 bis c.c.). Di converso la responsabilità genitoriale (“potestà genitoriale” prima della riforma) deve essere esercitata congiuntamente anche quando i genitori non convivono e non sono coniugati (art. 316, 4° co.).
Come può intuirsi anche attraverso questi brevi cenni, i diritti dei figli, che nella riforma del diritto di famiglia del 1975 acquisivano una nuova fisionomia, segnando il superamento del modello patriarcale fondato sulla patria potestà, tendono ora a tradursi in uno strumento penetrante di valutazione e controllo dello stile di vita dei genitori. Sul piano più strettamente giuridico devono registrarsi due dati niente affatto trascurabili. In primo luogo l’autonomia privata dei genitori in tema di rapporti coi figli è imbrigliata entro margini ristrettissimi segnati da ampi poteri dell’autorità giudiziaria e da norme inderogabili, a cominciare dalla prevalenza, stabilita per legge, dell’affidamento condiviso in caso di separazione e divorzio. Ciò a fronte di un’opposta tendenza, celebrata nel recente passato in tutto l’occidente come la nuova frontiera del diritto di famiglia, alla c.d. contrattualizzazione delle relazioni fra coniugi e partner, che pur con esiti discutibili puntualmente segnalati soprattutto dalla letteratura femminista in riferimento alle disparità di condizioni economiche fra partner-contraenti, aveva comunque segnato un ampliamento dell’area coperta dal diritto dispositivo e con esso la possibilità di esprimere modelli di relazione e stili di vita difformi dal canone espresso dal regime legale. Sembra allora che il diritto di famiglia contemporaneo, lasciato ormai alle spalle l’organicismo di stampo comunitarista esemplificato dalla forza prescrittiva dell’interesse superiore della famiglia rispetto ai diritti dei suoi singoli componenti, sia attraversato da una tensione – forse insanabile – fra un individualismo che si esprime con lo strumento tipico del diritto liberale ‘classico’, quello del contratto, e l’individualismo proprio del rights discourse, dei diritti umani in particolare, che si afferma attraverso strumenti imperativi e pubblicistici. In altre parole, due appaiono i modelli regolativi che si contengono il campo nel diritto delle relazioni familiari oggi: da una parte un modello in cui i diritti riconosciuti dal sistema a ciascun membro della famiglia costituiscono quelle background rules sulla cui base si allestisce la scena della negoziazione fra familiari, fra genitori e figlie e, soprattutto, fra coniugi e partner a vario titolo. Dall’altra un modello in cui le posizioni all’interno della famiglia sono determinate autoritativamente attraverso la logica degli status e dei diritti ad essi corrispondenti. La protezione dei minori che è oggi al centro di riforme e nuove carte dei diritti segue questo secondo modello, riducendo enormemente i margini di autonomia.
Un secondo ordine di considerazioni è suggerito dal cambiamento di prospettiva imposto dalla riforma del 2012-13. Con l’introduzione dello stato unico di figlio, il diritto di famiglia italiano, non diversamente dal diritto di famiglia di altri paesi, sembrerebbe trovare il suo fulcro nei diritti del figlio, attorno a cui si struttura ora il rapporto coi genitori – e persino fra i genitori medesimi. Si appanna invece la centralità del matrimonio, che a seguito della riforma perde una delle sue funzioni essenziali, quella di dar luogo alla discendenza legittima. In ultima analisi il motore della disciplina delle relazioni familiari appare oggi l’esistenza di un figlio e il suo coté normativo, il best interest of the child, nelle varie declinazioni che ne offrono legislazione e giurisprudenza, mentre meno rilevante appare la via (o le vie)3 d’ingresso alla famiglia legalmente riconosciuta, proprio perché essa è unificata sul versante del legame socialmente più pregnante, quello che si traduce nel rapporto di filiazione. Questa è quanto meno la tendenza nel diritto di famiglia globalizzato: non è un caso che negli Stati Uniti, fra i primi sistemi a riconoscere le famiglie LGBT(QIA), ciò sia appunto avvenuto a partire dalla garanzia del best interest of the child, e dunque a partire da una diffusa applicazione della stepchild adoption in favore delle coppie dello stesso sesso, accompagnata o meno da accordi di surrogacy o di inseminazione medicalmente assistita, mentre solo decenni dopo si sono aperte le porte al same sex marriage.
La realtà italiana riserva però su questo versante qualche sorpresa dovuta a sue (sembrerebbe) insuperabili ‘peculiarità’, com’è apparso chiaro proprio in questi giorni…
3. In realtà per cogliere appieno la portata prescrittiva e biopolitica del diritto alla bigenitorialità, particolarmente nel sistema italiano, bisogna volgere l’attenzione alle riforme della precedente generazione, in particolare a quella dell’adozione c.d. legittimante del 1983. La legge n. 184 del 1983 disciplina l’adozione piena, quella in grado di instaurare un rapporto di filiazione modellato sulla (allora vigente) disciplina della filiazione legittima (di qui la denominazione ‘adozione legittimante’), con totale cesura dei rapporti fra adottato e vissuto precedente, e, giuridicamente, fra il minore e la sua famiglia biologica. La capacità dell’adozione di far rinascere il minore in un nuovo contesto sociale e giuridico è affidata ad una minuziosa disciplina dell’idoneità degli aspiranti genitori all’adozione. L’assunzione del canone dell’imitatio naturae, dove ‘natura’ corrisponde invero a un modello legale, quello della famiglia biologica resa legittima dal matrimonio fra i genitori, importa che gli adottanti siano una coppia stabile e coniugata, quindi di sesso diverso, e con una differenza di età con l’adottand@ non superiore ai 45 anni (55 per il secondo coniuge). Solo dove siano presenti tutti questi requisiti (essere in due, essere eterosessuali, essere coniugati, essere relativamente giovani) è possibile accedere all’adozione legittimante. Le eccezioni a questa regola, ossia le ipotesi di adozione in casi particolari (art. 44 l. 184/1983 come sostituito dalla l. 149/2001) – di cui molto si è parlato di recente a proposito della stepchild adoption prevista nella prima stesura del ddl Cirinnà e di alcune applicazioni fattene dal Tribunale di Roma in contesti omogenitoriali – ammettono l’adozione da parte del/la single solo nei casi in cui il/la minore abbia già sviluppato legami affettivi significativi con l’adottante (coniuge del genitore adottivo o parente sino al sesto grado) ovvero si trovi in situazioni di disagio (minore difficile o disabile).
Appare allora chiaro che la bigenitorialità, prima ancora di individuare il contenuto di un diritto umano, rappresenta un parametro a partire dal quale il sistema giuridico definisce l’idoneità delle persone adulte e dei contesti familiari a crescere una figlia.Ed è altresì chiaro che qui bigenitorialità significa (anche) eterosessualità.
4. Alla luce del complesso degli interventi normativi che dopo la riforma del 1975 hanno rimodellato il diritto della filiazione nel sistema italiano, il significato del principio della bigenitorialità, che abbiamo visto enfaticamente affermato come il diritto del figlio minore a essere educato e ‘curato’ da entrambi i genitori, si ribalta traducendosi nella legittimazione della sola coppia eterosessuale ad accedere alla filiazione. La vicenda del ddl Cirinnà lo dice a chiare lettere.
Scopriamo quanto peraltro era già sufficientemente chiaro anche prima che i riflettori si accendessero ancora una volta sullo stato del diritto di famiglia in Italia: che bi-genitorialità non è amore per il numero 2, che il 2 non è neutro, ma corrisponde al paradigma dell’eterosessualità: un padre e una madre, un maschio e una femmina. A sua volta un modello non egalitario, ma gerarchicamente ordinato al suo interno. Cioè patriarcale. È il modello che residua nel matrimonio – se ne colgono gli echi nella prevalenza del cognome del marito, nella costruzione del lavoro di cura in favore dei familiari come non-lavoro; ed è il modello che, almeno secondo una certa lettura femminista, esce rafforzato dalla disciplina dell’affidamento condiviso, molto giocato sulla rivendicazione dei differenti ruoli di genere nella genitorialità. Un modello, quello della bigenitorialità/eterosessualità affermato con forza, come si è visto, nella disciplina dell’adozione, rimasto inalterato anche a seguito delle modifiche intervenute dopo il 1983, e ribadito dalla discussa legge 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, preclusa alle persone singole e alle coppie dello stesso sesso. In sostanza il canone della bigenitorialità/eterosessualità domina l’intera disciplina della famiglia e della procreazione.
5. Ora, gli effetti di tale pervasività non interessano solamente gli ambiti disciplinari direttamente riguardati. Come è noto, il diritto di famiglia è un formidabile dispositivo di costruzione delle identità. Ed allora la scansione bigenitorialità/eterosessualità/diritto si rivela un invisibile motore di produzione di norme apparentemente autonome e distinte rispetto al diritto di famiglia, ma sottilmente avvinte a quella matrice.
Un esempio eloquente è offerto dalla regolamentazione del transessualismo, materia formalmente lontana dalla filiazione, di cui si è tornato a parlare di recente in occasione di una sentenza di Cassazione del 20 luglio 2015 (la n. 15138) che ha ampliato i margini del diritto di autodeterminazione della persona transessuale escludendo l’obbligo di modificare chirurgicamente i caratteri sessuali primari. Il diritto italiano ha consentito e regolato il cambiamento di sesso sin dal 1982 (l. 164/1982), ben prima di altri paesi europei, tanto che vien da chiedersi il perché di una tale apertura a fronte di una tanto netta e pervicace chiusura nei confronti delle unioni same sex, appena confermata, del resto, dalla discussione pubblica e parlamentare sul ddl Cirinnà. Ma la risposta è autoevidente. Proprio questo contesto normativo rende infatti palese come attraverso quell’armamentario ideologico, di cui labigenitorialità è parte integrante,il diritto sperimenti la sua capacità di produrre soggettività. Soggettività che si danno in quanto, e solo in quanto, appartenenti a un genere o all’altro, cosicché la disciplina del transessualismo risulta funzionale alla eliminazione di possibili aree di ambiguità. Il breve itinerario che propongo di seguito serve a meglio comprendere la pervasività delle strutture profonde del diritto di famiglia.
A) La giurisprudenza sul transessualismo, anche quella più recente, conferma che l’interesse dello stato a eliminare situazioni di ambiguità sessuale è giuridicamente rilevante tanto da entrare in bilanciamento con il diritto individuale, costituzionalmente riconosciuto, all’autodeterminazione. Di conseguenza, anche se la modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari non è più imposta, comunque il soggetto che cambia sesso deve chiaramente essere riconoscibile come appartenente al genere di elezione e non dev’essere in grado di procreare.
B) Il ddl Cirinnà prevede che se in costanza di matrimonio uno dei coniugi cambia sesso, il matrimonio si converte, ove le parti lo desiderino, in una unione civile, così modificando la legge del 1982 che prescrive in quell’ipotesi lo scioglimento automatico del vincolo coniugale. L’idea di fondo è che tutto ciò che non è eterosessuale meriti il medesimo trattamento giuridico: a questa stregua omosessualità e transessualismo sono dunque la stessa cosa e l’unione civile destinata a formalizzare le unioni gay e lesbiche può ben accogliere anche questa diversa situazione. Un tale esito era stato peraltro prefigurato nel 2014 dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 170), la quale, a tutela della eterosessualità del matrimonio, aveva invocato una soluzione legislativa al c.d. divorzio imposto che consentisse ai coniugi di continuare a convivere all’interno di un ménage familiare legalmente riconosciuto, ma diverso dal matrimonio. Ora lo stesso d.d.l. Cirinnà, che finalmente risponde alla questione posta dalla Consulta, rivela però che quella vicenda, evidentemente segnata da una spinta ad ampliare la sfera di autodeterminazione delle persone, non ha insegnato nulla e in una norma (comma 26 del maxi-emendamento) prevede, specularmente a quanto prescriveva la norma della legge del 1982 poi reinterpretata dalla Corte, che la sentenza di rettificazione di sesso di uno dei partner determina ipso iure lo scioglimento dell’unione. Quindi secondo il legislatore c’è anche una ‘purezza’ dell’omosessualità – o forse della non-eterosessualità – da salvare: se si è/diventa di genere diverso non si può restare uniti in unione! E se le due partner – ora non più omo – volessero continuare a vivere insieme legalmente? Dovranno sposarsi (e così compiere l’upgrade al modello eteronormato)?
C) Cos’ha a che vedere tutta questa storia con la bigenitorialità? Molto! Tutto, nella misura in cui la bigenitorialità è originariamente connessa al paradigma eterosessuale. Alla fine di questo tortuoso percorso emerge, spero, con chiarezza quanto la bigenitorialità/eterosessualità sia posta a tutela prima che di presunti interessi esistenziali dei bambini, di un ordine sociale fondato su identità sessuali certe e immutabili. Per essere genitori si deve essere una coppia eterosessuale, e questo spiega il no per ora definitivo alla step-child adoption per le unioni civili. Con il che però anche il cambiamento epocale segnato dalla riforma del 2012-13, che aveva spostato il focus della disciplina giuridica della famiglia dal matrimonio all’interesse del minore, si rivela fallace e il matrimonio, in quanto istituzione che segna la rilevanza e la primazia giuridica della eterosessualità, torna a essere al centro dell’intera architettura. Evidentemente c’è minore e minore, e il best interest non sempre prevale. Non a svantaggio dell’imperativo dell’eterosessualità.
Sappiamo poi quanto il dibattito recente sul punto sia stato falsato da argomenti puramente ideologici. Rispetto alla stepchild adoption delle coppie gay si è ventilata ad arte la minaccia di una diffusione indiscriminata e perversa della maternità surrogata (che oggi una nuova ventata di political correctness vuole GPA, gestazione per altri). Tralasciando per il momento ogni presa di posizione sul punto, mi limito a osservare che in realtà molte figlie di lesbiche e figlie di coppie gay sono nate da precedenti rapporti eterosessuali. Ma in parlamento sembra non ammettersi che si possa cambiare orientamento sessuale, essere eterosessuali in una fase della vita, procreare ‘naturalmente’ e poi cambiare orientamento sessuale, semplicemente perché le relazioni affettive e la sessualità stessa sono fluide e si può essere omosessuali, ma anche eterosessuali, in tanti modi. E l’esito è che per queste bambine e questi bambini non valgono i diritti di cui godono le bambine e i bambini che crescono nelle famiglie etero. Neanche il diritto alla bigenitorialità, si capisce!
Così il diritto/canone della bigenitorialità si rivela per quel che è, non tanto un principio posto a salvaguardia del diritto del minore a una famiglia, quanto piuttosto un dispositivo posto a salvaguardia di un ordine sociale che si radica in una forte istituzionalizzazione della sessualità, ricercata attraverso l’attribuzione di identità di genere certe, distinte e fisse. I diritti dei bambini, in quest’epoca sempre solennemente proclamati, scadono allora a mero pretesto. Eppure, ove presi sul serio, sarebbero, e sono stati altrove, una leva potentissima per scardinare il dogma dell’eterosessualità nella famiglia. Con una ormai storica decisione, la Corte Suprema del Massachusetts4 nel 2003 aprì il matrimonio alle coppie same sex proprio in nome del benessere dei bambini che vivono in famiglie omoparentali. Con una buona dose di realismo la Corte analizzò il matrimonio non come il santuario dei valori della famiglia tradizionale ma come quell’istituto attraverso cui il sistema giuridico attribuisce benefici e diritti successori, sociali, previdenziali, fiscali, di proprietà ai membri della famiglia che su esso si fonda. Su questa base giunse alla conclusione che precludere l’accesso al matrimonio alle coppie same sex equivale a escludere dalla piena cittadinanza non solo le persone adulte di orientamento omosessuale ma anche le loro figlie, così dando luogo ad una discriminazione odiosa e ingiustificata.
Si tratta del convegno “Genitorialità e pari opportunità” svoltosi lo scorso 3 marzo a Perugia e organizzato dal comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Perugia. ↩
V. il contributo pubblicato sul sito della Giuriste d’Italia-Giudit al link https://giuristeditalia.files.wordpress.com/2010/11/affidamento-gian.pdf. ↩
Ove altre forme di unione diverse dal matrimonio siano previste. ↩
Goodridge v. Department of Public Health, 798 N.E. 2d 941 (Mass. 2003). ↩