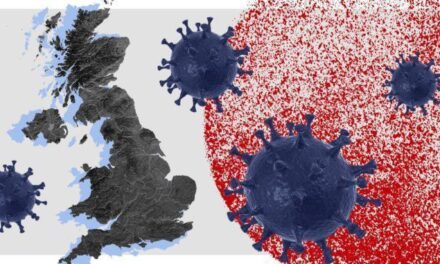di GUSTAVO ESTEVA e IRENE RAGAZZINI.1
17/01/2013
Questo lavoro è il risultato di una collaborazione tra Gustavo Esteva, intellettuale deprofessionalizzato di Oaxaca, e Irene Ragazzini, italiana emigrata in Messico, entrambi membri della Universidad de la Tierra (Oaxaca, Messico), uno spazio di apprendimento libero e descolarizzato. Il tema che abbiamo scelto di presentare è relativo all’atteggiamento e alle proposte politiche a fronte dello smantellamento del welfare, mettendo a confronto la prospettiva di matrice europea della precarietà con la proposta dei movimenti sociali e dei settori popolari in America Latina, che utilizzano altre parole per pensarsi collettivamente, come “costruzione di autonomia” o Buen Vivir (Buon vivere). Crediamo che le loro pratiche presentino una forte consonanza con la proposta concettuale di Ivan Illich, che parlava di “società conviviale” come orizzonte alternativo alla società istituzionale moderna e industriale, della cui contro-produttività stiamo attualmente soffrendo le conseguenze. Per questo segnaliamo qui l’urgente necessità di passare dalla descrizione della precarietà alla ricerca e al riconoscimento delle relazioni “conviviali”.
Per iniziare, raccontiamo un breve aneddoto personale.
Io, Irene, ho avuto il mio primo incontro con il concetto di precarietà circa undici anni fa, quando il collettivo “Rebelde” del Liceo Classico Parini di Milano distribuiva volantini agli studenti per invitarli a una manifestazione contro la precarietà che li aspettava al momento di iniziare il percorso di carriera individuale verso il capitalismo. Ricordo la sensazione che ho provato nel leggere quel volantino che ci spiegava sinteticamente il significato della parola “precarietà” pretendendo di descrivere la situazione in cui tutti noi ci trovavamo. Ho avvertito contemporaneamente due sensazioni contrastanti: da una parte, una maggiore comprensione della realtà in cui mi trovavo, dall’altra sentivo che mi si voleva imporre come mi sarei dovuta sentire a riguardo. Mai prima, né mi ero definita né mi ero sentita precaria, nonostante già capissi che non avrei mai avuto un lavoro simile a quello dei miei genitori e già avessi l’intenzione di iscrivermi a un corso di laurea che non offriva alcuna possibilità di impiego. Ricordo che in quel momento quasi mi vergognai con me stessa per non avere raggiunto questa conclusione sulla mia situazione prima di ricevere un volantino che me lo spiegasse. Tuttavia c’era qualcosa che non mi convinceva, che mi suonava come un discorso politico prefabbricato. Pur non sapendolo argomentare, sentivo che quell’idea di precarietà era vuota anche se non potevo non concordare con l’analisi su cui poggiava.
In un suo articolo del 2005, Franco Berardi (Bifo), rifacendosi a un saggio di Angela Metropoulos, sottolinea che quella di precariato è una nozione precaria. “Questo perché definisce il suo oggetto in modo approssimativo, ma anche perché da questa nozione derivano strategie paradossali, autocontraddittorie, insomma precarie. Se la nostra attenzione critica si concentra sul carattere precario della prestazione lavorativa quale sarebbe l’obiettivo che ci proponiamo? Quello di un rapporto di lavoro fisso, garantito per tutta la vita? Naturalmente no. (…) dobbiamo riprendere il filo della composizione e decomposizione sociale se vogliamo intravedere linee possibili di un processo di ricomposizione a venire” (Bifo 2005).
Se ci collochiamo ora dal lato dell’America Latina, parlando a nome della maggioranza della popolazione, possiamo dire di essere esperti in precarietà. Abbiamo vissuto per generazioni in una condizione che si può descrivere come precaria. E abbiamo già imparato che fare. Per molto tempo, attratti dalle luci al neon dello sviluppo, abbiamo lottato per l’integrazione al Primo Mondo: volevamo essere accettati nel mondo dell’impiego e del welfare. Eravamo visti per quello che ci mancava: disoccupati, senza sicurezza sociale, né classe sociale, informali, sottosviluppati. Insomma: non eravamo visti. Tuttavia già da alcuni decenni la lotta in America Latina ha assunto altre caratteristiche di fondo: la lotta per l’autonomia degli zapatisti e di molte comunità indigene, le fabbriche recuperate in Argentina, le lotte per la difesa del territorio, la rivalutazione dell’ambito domestico come spazio di riproduzione della vita e non come spazio di mancanza di emancipazione o di salario. Osservando queste esperienze, vediamo che la parola lotta non è associata tanto al conflitto o al confronto, quanto all’ambito quotidiano, alla costruzione di comunità, all’organizzazione e al controllo della propria vita sociale o collettiva. L’atteggiamento comune in queste lotte non si concentra nell’esigere meno precarietà, più lavoro, più diritti, più sanità, più educazione, piuttosto implica un esercizio di libertà attivo, organizzato e senza intermediari. La relazione con l’apparato statale si limita, se esiste, alla pretesa di vedere rispettata questa autonomia e di non subire intromissioni.
Partendo da questa osservazione ci è apparso rilevante costituire, alla Universidad de la Tierra, un gruppo di ricerca e analisi su quello che viene correntemente definito in America Latina il “settore informale” o la “popolazione marginale”, insomma, tutta quella parte di popolazione (di cui facciamo parte) che non si trova in condizione di lavoratore dipendente. In Messico più della metà della popolazione può essere classificata come precaria parlando in termini europei. Nel dibattito che a partire dagli anni Sessanta ha interessato l’America Latina, questa parte della popolazione è stata classificata prima come marginale e poi come appartenente al settore informale.
Nella sua sintesi di questo dibattito, Giosa Zuazúa spiega come le visioni di Quijano o di Nun, tralasciando le loro differenze, si concentrano entrambe sul concetto di marginalità economica. Partendo da una prospettiva marxista sostengono che, nel processo di sviluppo delle economie capitalistiche dipendenti, alcune attività, che erano state centrali per il processo di accumulazione del passato, si trasformano in attività marginali in un momento successivo. La marginalità si stabilisce in relazione al processo di accumulazione, concepito come egemonizzato da un polo capitalistico dominante. Qui l’unità di analisi sono le attività economiche (le quali si classificano come centrali o marginali) e le relazioni di produzione che si stabiliscono di conseguenza.
Zuazúa continua spiegando che l’esistenza di lavoratori esclusi dai benefici del processo di sviluppo assume maggiore rilevanza durante gli anni Settanta, arrivando a porsi come tema di analisi e dibattito per alcuni organismi internazionali. “É in questo momento che, all’interno dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), nasce la teoria del Settore Informale Urbano, in principio più una categoria empirica che una categoria concettuale, parte di un quadro teorico più generale. Keith Hart, all’inizio degli anni Settanta, introduce per la prima volta questo concetto, e la Missione per l’Impiego della OIL che lavora in Kenya lo proietta a livello internazionale. L’innovazione principale del Rapporto del Kenya è il concetto di “poveri che lavorano”. I suoi autori scoprono che la massa di sottoccupati che svolge diverse attività riesce a sopravvivere in condizioni sfavorevoli. Queste attività sono descritte come informali e caratterizzate da: facile accesso, piccola scala, capitale proprio e ridotto, uso intensivo di mano d’opera in mercati non regolati e competitivi” (Zuazúa 2005). La visione imperante del settore informale nella Missione Kenya è quella di un segmento più o meno autonomo, che non solo offre impiego e beni e servizi a gruppi di minor reddito, ma che ha anche il potenziale di generare eccedenza per favorire la crescita economica. Si conclude che se non se ne ostacola il funzionamento, queste attività possono svilupparsi e generare redditi crescenti. Senza dubbio, in quel momento, l’idea di informale descrive ancora unicamente la contrapposizione alle attività formali, mancandole un quadro concettuale di riferimento.
La relazione tra questa idea poco precisa d’informalità con la teoria di Lewis dà inizio alla costruzione di un quadro teorico in cui il settore informale diventa categoria analitica. “La teoria di Lewis visualizza un’economia duale: due settori, uno di sussistenza o arretrato, e l’altro capitalistico o moderno, differenziati dal livello di produttività e dai salari. La dinamica si avvia quando gli imprenditori capitalisti, che ottengono maggior produttività di quella generata nel settore di sussistenza, possono rifornirsi di mano d’opera dall’altro settore, offrendo un salario che sebbene maggiore del reddito ottenuto nella sussistenza, è inferiore a quello pagato nel settore capitalista” (Zuazúa 2005). La teoria formula così la possibilità di assorbire l’eccedenza di mano d’opera. Caratteristica di questa visione è sostenere che lo sviluppo economico ha un’unica traiettoria, in virtù della quale, grazie alla spinta del settore moderno, si arriverà con più o meno difficoltà alla sparizione del settore arretrato.
Un’altra corrente, che costituisce chiaramente una voce fuori dal coro, non valorizzata in questo dibattito, è rappresentata da Teodor Shanin, Harry Cleaver e Gustavo Esteva, tra altri. Shanin introduce il concetto di “‘expoliary economies” e sottolinea due caratteristiche del fenomeno in questione: “in primo luogo l’essere esterno alla polis quando, come l’antica Grecia, questa risponde tanto allo Stato come all’origine della società di mercato; in secondo luogo, il collocarsi fuori dai due poli della consacrata scala analitica di “pianificazione” versus “mercato” e di fatto mette in dubbio la pertinenza di tale dicotomia (Shanin: 1988, p. 112). I modelli economici attuali che entrano nella categoria di “expoliary” sono individuati come segue:
a. L’unità di produzione familiare, le cui caratteristiche risultano avere una logica operativa diversa da quella del mercato e della pianificazione statale.
b. La piccola unità specializzata che si caratterizza per una maggiore flessibilità di risposta, contatti personalizzati e accesso privilegiato a certe risorse. In alternativa si fonda sulle diseconomie di scala in un campo particolare.
c. La prestazione di lavoro part-time, che dal punto di vista di coloro che la usano, funziona come una fonte soprannumeraria di reddito generata dall’uso del “tempo libero”.
d. L’economia nera che implica spesso l’uso illecito di risorse monopolizzate dallo Stato e operazioni che trovano terreno fertile nell’industria malavitosa dell’evasione fiscale, del contrabbando, dello sfruttamento della prostituzione e dell’associazione a delinquere.
Shanin evidenza quindi la diversità sostanziale delle expoliary economies così come la loro natura relativa, ovvero, l’esistenza di un “centro” o “corrente principale” con cui si relazionano i modelli expoliary, che ne sono influenzati pur rimanendo strutturalmente diversi. Sulla stessa linea, in un articolo del 1983, intitolato “I Tradifas o la fine dell’emarginazione”, Esteva propone di cambiare prospettiva nell’osservare questo settore della popolazione: osservarlo dal punto di vista dei lavoratori e non dal punto di vista del capitale. E’ in questo senso che Esteva, rifiutando le formulazioni teoriche che vedono questa parte della popolazione dal punto di vista di quello che non è (non ha formalità, non accede alle condizioni socio-economiche necessarie), ci parla dei tradifas, sigla che sta per trabajadores directos de la fábrica social: lavoratori diretti della fabbrica sociale. In questo saggio propone una descrizione molto dettagliata delle relazioni di sfruttamento (non basato sul salario) di questi lavoratori da parte del capitale. Esteva si focalizza inoltre sulle relazioni di reciprocità, mutuo soccorso e solidarietà, mostrando che è lì, tra di loro, che stanno crescendo piccoli semi di nuove relazioni sociali non capitalistiche.
Per descrivere la fabbrica sociale, Esteva, rifacendosi a Cleaver ed Emmanuel, afferma che la società moderna deve essere vista come una fabbrica sociale che produce per la propria riproduzione. Nella fabbrica sociale si esprimono numerose e complesse relazioni sociali. La loro riproduzione si effettua in modo privilegiato nelle fabbriche del capitale, nelle industrie. Ma non esclusivamente. Nella società capitalistica qualsiasi prodotto tende a diventare una merce, alienandosi dal produttore diretto per acquisire questo carattere. Al divenire merci gli oggetti che soddisfano i bisogni, assumono rilevanza universale come oggetto di scambio. Questa è però solo una tendenza: infatti le merci disponibili sul mercato soddisfano solo parzialmente i bisogni dei lavoratori, sia perché non tutte le cose di cui hanno bisogno esistono in forma di merce, sia perché essi non possono sempre pagarne il prezzo. Per questo, i lavoratori si vedono obbligati a produrre direttamente, con il proprio sforzo, diversi beni e servizi. Nell’occuparsi in questo modo della propria riproduzione come forza lavoro, lavorano direttamente per la fabbrica sociale. Quest’attività non richiede l’intermediazione del capitale che si realizza nel circuito mercantile. Per questo i lavoratori non producono valore, ma uso, nel realizzare questo sforzo, perché non producono merci, anche se l’umanità che contribuiscono concretamente a riprodurre – la propria vita – può convertirsi di nuovo in merce: la forza lavoro.
Esempi di tradifas si possono vedere dappertutto nelle società latinoamericane: contadini che coltivano mais per l’autoconsumo e caffè per l’esportazione; donne che vendono frutta o cibo agli angoli delle strade e poi vanno a fare le pulizie a casa di altri; muratori o sarte indipendenti che lavorano nelle loro reti di appartenenza e per imprese private; migranti temporanei che fanno gli artigiani quando non lavorano per il capitale, etc. Mentre i capitalisti cercano di ottenere il massimo profitto dal valore della forza lavoro, i lavoratori si impegnano ad elevare al massimo quel valore. Il tema centrale del conflitto di interessi tra i lavoratori e il capitale è la durata della giornata lavorativa. Visto che il tempo che la forza lavoro non utilizza nel processo produttivo è, per il capitalista, tempo perduto, egli cerca di metterla a produrre più tempo possibile, senza altro limite in questa pretesa che la resistenza fisica dei lavoratori. Siccome per i lavoratori il tempo perduto è invece quello in cui lavorano per il capitale, essi impongono un limite storico a tal pretesa, attraverso la loro lotta sociale e politica per ridurre la durata della giornata lavorativa (Cleaver, 1979).
I tradifas, in questa negoziazione costante con il capitale e durante la riproduzione autonoma di una parte delle loro vite, si costituiscono in gruppi umani distanziandosi da altri, a partire da una forma di mobilitazione specifica che in America Latina è legata alla occupazione e conquista della terra (rurale ed urbana) e quindi richiede una organizzazione in continuo rinnovamento. In questo modo il gruppo si identifica come una comunità di interessi, non esclusivamente materiali, anche se è sempre necessario adattarsi a questi ultimi.
In quanto al funzionamento di questi gruppi, si considera che la fase del processo economico della circolazione è il punto di partenza per comprendere la specificità dell’economia tradifa. Lí si materializza l’organizzazione grazie alla quale le risorse sociali trovano applicazione. La circolazione tra i tradifa funziona come “fondo di sicurezza”, che non ha necessariamente prende la forma di denaro, non ha un carattere formale e non adotta nemmeno la forma di risparmio o di accumulazione. In generale la circolazione non è concentrata e, anche se con lo sviluppo del gruppo essa tende ad acquisire una forma definita, centralizzata, questa non sostituisce mai completamente la forma di esistenza di base (informale e dispersa). Questo “fondo di sicurezza” è costituito dai fondi correnti di consumo, generati dalla normale attività dei tradifas. Circolando nel gruppo esso costituisce condizione di sopravvivenza.
I tradifas, com’è stato già detto, sviluppano attività produttive – nel senso capitalista del termine – che rappresentano per loro un reddito: ricevono un salario o i suoi equivalenti. Ottengono “reddito” pure in altri modi come per esempio, la prestazione diretta di servizi remunerati. Si tratta di attività che svolgono “individualmente” e le relative entrate passano attraverso la via individuale all’economia del gruppo, dove si consumano ugualmente in forma individuale o circolano con gli effetti indicati. Sulla base della circolazione, elemento chiave della stabilità del gruppo, e in combinazione con altri elementi, l’organizzazione tradifa può intraprendere un’attività di produzione che può presentare diverse caratteristiche:
- può riprodurre relazioni di tipo capitalista. In questo caso l’attività produttiva può inserirsi nella logica di funzionamento del gruppo tradifa e formare parte del suo schema globale di riproduzione oppure – cosa più probabile – tendere a lacerare il gruppo o almeno alienarsi da questo;
- in secondo luogo, questa produzione può assumere caratteristiche di produzione (autarchica o no) per il consumo collettivo: si tratta di produzione di valori d’uso, organizzata su basi cooperative;
- infine, può assumere le caratteristiche di produzione cooperativa autogestita per la vendita.
In queste attività, i tradifas non si differenziano a rigore dai lavoratori non tradifas, ma il reddito dei primi, indipendentemente dalla loro fonte, ha un significato aggiuntivo rispetto a quello che ricevono gli ultimi: invece di limitarsi alla riproduzione individuale o familiare, il reddito si inserisce nella logica di funzionamento dell’organizzazione tradifa e forma parte delle sue condizioni e dei requisiti di riproduzione in quanto tale.
Obiettivo centrale del nostro studio a Unitierra è analizzare se i tradifas stanno costruendo nuove relazioni sociali che vanno oltre il capitalismo. Ci chiediamo se i tradifas si possono considerare come soggetti di una rivoluzione quotidiana i quali, pur agendo all’interno del capitalismo ed essendo sfruttati (in forma diversa da quella salariale), si inventano e recuperano spazi di libertà e di comunità, di fiducia e di autonomia dai diversi sistemi istituzionali.
Partiamo dall’idea – che in Messico oggi è più evidente che mai, ma che consideriamo valida in generale – che a questo punto della storia del capitalismo e dello Stato-Nazione, diventa un atto privo di senso quello di pretendere che lo Stato garantisca i nostri diritti sociali ed economici. In Messico si dice che è come “pedirle peras al olmo” (ovvero chiedere pere all’olmo), visto che non esiste più uno Stato con tale capacità, nonostante le promesse siano rinnovate ad ogni ciclo elettorale. Al contrario, è ormai evidente ciò che Ivan Illich avvertiva già dagli anni Settanta: e cioè che i diversi sistemi istituzionali a cui abbiamo delegato per decenni funzioni fondamentali per la riproduzione della vita umana e sociale (come sistemi educativi, sistemi di trasporto, sistemi fognari e di raccolta e trattamento dei rifiuti, sistemi di sanità, sistemi elettorali, sistemi idrici, sistemi di sfruttamento della forza lavoro) ci hanno sottratto il controllo su noi stessi, hanno smantellato le nostre comunità e, al momento di entrare in crisi, si ritorcono contro di noi, che ora siamo deboli e precari.
Come fare per uscire non solo da una situazione materiale di precarietà, ma soprattutto da quella condizione psicologica di precarietà che ci fa guardare solo verso l’alto, verso le stesse istituzioni che ne sono la causa? Per fare un esempio concreto: in una protesta recente, alcuni giovani precari italiani gridavano “Vogliamo lavorare! E non possiamo!”. Questa frase crea un misto di ilarità, rabbia e frustrazione. Da un lato implica un “vogliamo che ci sfruttino e non troviamo nessun capitalista disponibile”, dall’altro contiene pure un “siamo giovani e abbiamo energia, però non abbiamo immaginazione per pensare ad un agire collettivo (o un altro lavoro o un altro agire) creativo, degno, organizzato tra di noi”. Infine segnala anche un “ci prepariamo nelle scuole e nelle università dove ci hanno trasformato in individui-pezzi di un puzzle che ormai non esiste”.
Che fare? Dove cercare una fonte d’ispirazione per trasformare la frustrazione in immaginazione? L’io in noi? Come trasformare la mia carriera fallita e il mio curriculum pieno di master inutili nel nostro progetto collettivo? Lo sguardo verso l’alto in sguardo in basso e tra di noi? In poche parole: come approfittare della crisi per la rivoluzione?
Magari iniziare a volgere l’attenzione verso le opzioni dei tradifas dei paesi periferici può darci elementi e farci vedere che esistono opportunità ormai in essere da anni: come per esempio organizzarsi tra disoccupati, come hanno fatto i Movimenti di Lavoratori Disoccupati noti anche come piqueteros; o i lavoratori che hanno recuperato le proprie imprese per trasformarle in cooperative in Argentina; o i produttori e i commercianti dei mercati mesoamericani che tradizionalmente operano così; o le comunità indigene; o i lavoratori sem terra in Brasile che si organizzano autonomamente nelle terre occupate; come in decine e decine di quartieri dove la gente si costruisce la propria casa da sola.
Si tratta di gente comune e semplice che è cosciente di dipendere dal proprio lavoro diretto e in comune, non di operai salariati che, invece di potenti soggetti rivoluzionari, si sono allineati ai settori più conservatori, per cercare di mantenere ciò che ormai è uno status, ovvero un posto di lavoro. Ora sono le donne, gli indigeni, i contadini, i giovani, i venditori ambulanti e gli immigrati i soggetti della nuova rivoluzione i quali non cercano di conquistare il potere dello Stato, ma si uniscono nel loro spazio comune, oltre la cosa pubblica e quella privata, smantellando lo Stato nella pratica quotidiana.
In Europa, il problema è in larga misura differente. Ci si trova in una situazione di precarietà perché si stanno togliendo diritti sociali e del lavoro a persone che non hanno un tessuto comunitario forte, che non sono cresciute all’interno di reti di reciprocità de-mercantilizzata, mutuo soccorso, lavoro collettivo a servizio del bene comune, ma in famiglie mono-nucleari nelle quali i genitori hanno mantenuto un lavoro dipendente più o meno fisso fino a pochi anni fa, con diritto a pensione, e nelle quali i nonni, dopo la guerra, hanno tagliato le relazioni con i loro paesi e sono venuti nelle città a godersi i benefici del Plan Marshall, vendendo le loro botteghe e le loro terre, convinti che non erano più buone per coltivare. Non hanno insegnato i loro dialetti ai loro figli e li hanno mandati a scuola: meglio che finissero l’università per trovare un buon lavoro invece di imparare un’arte o un mestiere, uscire a vendere per strada (attività peraltro illegale nei paesi europei) o imparare a produrre per la economia domestica.
È per questo che si sta vivendo in maniera così traumatica la consapevolezza di questa nuova povertà ed incertezza… ma non si sta sperimentando la povertà per mancanza di posti di lavoro o per la perdita di diritti sociali garantiti dallo Satato-Nazione, si stanno invece soffrendo le conseguenze di un impoverimento della comunalità durato vari decenni. Lungi dal comprenderlo, si continuano a chiedere le stesse catene: essere sfruttati parecchio e di più, visto che si è iper-formati per essere impiegati da altri e che ormai non si sa più fare niente per risolvere le proprie necessità fuori dai sistemi istituzionali.
Però tra i precari europei non ci sono solo giovani laureati disoccupati, o cinquantenni licenziati. Ci sono pure quelli che sono sempre stati precari, gli esclusi (volontariamente o no) dal welfare: i rom, gli immigrati, gli abitanti delle periferie, i contadini (vecchi e nuovi), i lavoratori di piccoli negozi o imprese familiari, le prostitute, le colf, i senzatetto, gli esclusi dalle scuole o dai concorsi pubblici, le casalinghe, gli occupanti delle case vuote… gente che per molti anni ha cercato di mantenere la propria dignità, attraverso reti familiari e di amicizia, collettività o comunità etniche, etc. A volte al margine della legalità, ma con tutta la forza della legittimità di esistere come esseri umani in questa società. Sono i tradifas europei. Tanto in America Latina come in Europa, è chiaro che noi tradifas siamo ancora immersi nel capitalismo ma siamo sempre di più e stiamo ampliando le nostre capacità autonome e l’agire conviviale, oltre il modo di produzione industriale.
Il modo di produzione industriale, guardato con prospettiva storica, ha offerto una soluzione di dignità della vita alla maggior parte della popolazione, solo in società che rappresentano una piccola parte della popolazione mondiale durante appena trenta anni dei due secoli e mezzo della sua esistenza. I “trent’anni gloriosi” che, secondo gli analisti francesi, seguirono la fine della Seconda Guerra Mondiale grazie agli accordi keynesiani costruiti sul modello del New Deal, culminarono con gli “anni d’oro” dal 1960 al 1973. Lo spirito degli anni sessanta fu alimentato dalla tensione tra una corrente individualista e libertaria e un’altra solidaristica, egualitaria e comunitaria e mostrò un rifiuto profondo delle relazioni sociali dominanti e della tecnificazione. Furono anni di speranza, in cui si esaminarono le questioni fondamentali con una forza senza precedenti e si generò un’ambiziosa agenda per la ricostruzione dei valori culturali. “Ogni cosa fu posta in questione: la famiglia, il lavoro, l’educazione, il successo, la ragione, la pazzia, la cura dei bambini, l’amore, l’urbanesimo, la scienza, la tecnologia, il progresso, la ricchezza (Sbert 2009: 57)”. Deleuze e Guattari si riferirono a questo momento storico stellare in termini inequivoci: “ Si diedero momenti in cui sembrava potersi vedere improvvisamente tutto ciò che una società aveva di intollerabile, e allo stesso tempo la possibilità di un’altra realtà sociale (Weber 1998: 58)”.
In questo clima sociale, il Rapporto sui limiti dello sviluppo del Club di Roma del 1972 si rese presto famoso: avvertì che a meno di prendere misure radicali per limitare la crescita economica si sarebbe prodotto il collasso del sistema economico e sociale del mondo in settant’anni. Si pronunciò con vigore sulla necessità di raggiungere uno stato di equilibrio stabile, dando per scontato che si era vicino al limite massimo di abitanti che il pianeta avrebbe potuto sopportare. Pur riconoscendo la necessità che i paesi meno avanzati e le popolazioni più povere migliorassero la propria condizione, si batté perché avvenissero cambiamenti sostanziali nel comportamento umano e nel tessuto sociale, in particolare in relazione all’ambiente. Il rapporto mise particolare enfasi sulla necessità di limitare la crescita demografica, ma senza trascurare la restrizione alla crescita economica ed in particolare in considerazione del suo impatto sull’ambiente (Meadows et al. 1972).
In quel contesto morale, intellettuale e politico, Iván Illich pubblicò i suoi “saggi di Cuernavaca”. Facevano parte del risveglio critico che condusse al Rapporto del Club di Roma. Illich condivideva con quest’ultimo la preoccupazione per urgenza di moderare la crescita demografica, la produzione e il consumo di beni, tuttavia portava il dibattito molto più in profondità. Prima di tutto, segnalava che l’espansione dei servizi avrebbe nuociuto più alla cultura di quanto la produzione dei beni nuocesse all’ambiente. La critica radicale della scuola in Descolarizzare la società (Illich 2006), del sistema di trasporto in Elogio della bicicletta (Illich 2006) e del sistema sanitario in Nemesi medica (Illich 2006), illustrarono ciò che denominò la contro-produttività propria di tutte le istituzioni moderne: e cioè il fatto che, oltrepassata una certa soglia, queste iniziano a produrre un effetto contrario a ciò che si propongono.
Nel settembre del 1971, Illich scrisse con Valentina Borremans La necessità di un tetto comune: il controllo sociale della tecnologia (Illich 2006). Presentò qui l’ipotesi secondo la quale solo una società che accetti di adottare dei limiti massimi per alcune dimensioni tecniche dei suoi mezzi di produzione, sarà possibile e rappresenterà un’alternativa politica. Tra il 1971 ed il 1973 pubblicò il saggio conosciuto come La convivialità (Illich 2006), che comincia con le seguenti parole: “ Nel corso dei prossimi anni mi propongo di lavorare a un epilogo dell’età industriale. Vorrei tracciare il profilo delle storture e delle ipertrofie intervenute nel linguaggio, nel diritto, nei miti e nei riti, in quest’epoca nella quale uomini e prodotti sono stati assoggettati alla pianificazione razionale. Vorrei ritrarre come è venuto declinando il monopolio del modo di produzione industriale e la metamorfosi subita dalle professioni che esso genera e nutre (Illich 2006: 371)”.
Cent’anni prima, Marx ammoniva: “se la Russia continua la sua marcia sul cammino che sta percorrendo dal 1861, sprecherà la più bell’occasione che la storia abbia mai offerto a un popolo per schivare tutte le fatali vicissitudini del regime capitalista (Marx 1946:711).” Illich, dal canto suo, scrisse: “i due terzi dell’umanità possono ancora evitare di passare per l’età industriale se sceglieranno sin d’ora un modo di produzione fondato su un equilibrio postindustriale, quello stesso al quale i paesi sovraindustrializzati dovranno ricorrere di fronte alla minaccia del caos” (Illich 2006). Si definirono quindi due possibili opzioni che non furono scelte. La Russia buttò via la sua opportunità storica. Le nazioni sovraindustrializzate fanno fronte ormai alla minaccia del caos, mentre le altre continuano la loro folle corsa per raggiungerle. Vent’anni fa ancora si pensava che la Cina si sarebbe potuta trasformare senza trascinare il mondo verso l’abisso: si muoveva in bicicletta. Oggi risorge il timore del “pericolo giallo” di cui parlava Napoleone: cento milioni di automobili limitano la circolazione di 700 milioni di biciclette. A Pechino, dove le biciclette disponevano di 6 corsie, ora sono confinate in una sola. Il panorama così aperto impone danni ambientali insopportabili tanto per la Cina come per il mondo intero. Le conseguenze sociali e politiche sono ancora più dannose.
Oltre a realizzare una rigorosa critica radicale del modo di produzione industriale, sia capitalista o socialista, Illich annotò ne La convivialità le condizioni di ricostruzione conviviale ed anticipò le lotte che avrebbero permesso l’inversione politica necessaria e le forme in cui le persone avrebbero reagito nel momento della crisi – il momento attuale. Le sue idee costituiscono un’utile guida per leggere ciò che sta avvenendo nel mondo. Mentre i governi funzionano sempre più come meri amministratori delle grandi imprese private, la gente comune, per ragioni di sopravvivenza o in nome di antichi ideali, sta reagendo con forza. Le loro iniziative si estendono e si radicalizzano sempre di più, fino a dar forma a un’insurrezione che resiste alla tempesta mortale che distrugge senza distinzioni l’ambiente e la cultura, iniziando la ricostruzione in termini molto simili a quelli anticipati da Illich.
In questa direzione, se c’è un’espressione capace di raccogliere il senso dei movimenti sociali che percorrono ora l’America Latina è quella di buen vivir, vida buena (buon vivere, vita buona). Il buen vivir normalmente genera ogni sorta di tensioni e contraddizioni con i governi di ogni ideologia, i quali tendono a screditare, criminalizzare o cooptare questa visione. La definizione della vita buona, una sfera dell’immaginazione e dell’azione che apparteneva tradizionalmente alla società civile, è stata attribuita al governo nello Stato-Nazione moderno, che di solito l’ha condivisa con le imprese private e i media.
Negli ultimi cinquanta anni, l’ideologia dello sviluppo ha teso a operare come una definizione universale della buona vita, associata alla condizione media degli abitanti dei paesi sviluppati ed in particolare degli Stati Uniti, e si è proposta come idea universale. Molto presto è risultato però evidente che questo non era fattibile e che sarebbe ecologicamente insensato che tutti gli abitanti delle regioni che il presidente Truman chiamò sottosviluppate adottassero quello stile di vita. Nonostante ciò, anche se dagli anni settanta si è ridotto realisticamente l’impegno di garantire a tutti la soddisfazione di certe necessità di base, non si è abbandonata la definizione universale della vita buona nella costruzione delle mete sociali. Quest’orientamento continua a determinare la forma e la sostanza delle politiche pubbliche nel detto “Sud del mondo”, pur con le differenze ideologiche che nei diversi paesi portano a dare più enfasi al mercato o all’iniziativa pubblica per la risoluzione delle questioni sociali.
Questi atteggiamenti si iscrivono chiaramente in una tradizione tipicamente occidentale, orientata alla costruzione di “un mondo” – con le bandiere politiche e i pretesti più diversi (Sachs 1992a). L’agenda occulta dello sviluppo diventa una nuova forma di occidentalizzazione del mondo, espressione del punto massimo al quale sarebbe arrivata l’umanità, guidata dalla freccia unidirezionale del progresso. Da anni, tuttavia, la freccia si è rotta: l’idea stessa di progresso è già matura per i musei (Sbert 1992). L’omologazione culturale associata con lo sviluppo trova crescente resistenza dappertutto. Come hanno indicato gli zapatisti dal 1994, adesso si tratta di costruire un mondo in cui ci sia spazio per molti mondi. Invece di continuare a dissolvere interi popoli e culture, per integrare tutti in un disegno universale ed uniforme, esplorare forme di coesistenza armonica dei diversi è diventato una priorità. Questo nuovo atteggiamento tende verso un orizzonte politico oltre lo Stato-Nazione, riformula il senso delle lotte democratiche e recupera le definizioni autonome della vita buona che sorgono dai centri autonomi di produzione di conoscenza. I governi, inclusi quelli che si oppongono apertamente ai paradigmi dominanti, come quelli di Bolivia, Ecuador e Venezuela, adottano invece ancora quel catechismo dello sviluppo e reprimono come eretici i movimenti di base che lo mettono in discussione.
Il nuovo atteggiamento di molti movimenti sociali presuppone l’abbandono dell’universalismo convenzionale, senza cadere nel relativismo culturale. Si fonda su tradizioni autoctone ed esperienze secolari di resistenza e liberazione, adottando forme di pluralismo radicale. Il recupero dei verbi illustra il significato del buen vivir. Nel momento in cui sostituiamo sostantivi come educazione, sanita’ o alloggio – che definiscono i bisogni fondamentali e la conseguente dipendenza dagli enti pubblici o privati che dovrebbero soddisfarli – con verbi come imparare, curare o abitare, si recupera l’azione personale e collettiva e si abilitano percorsi autonomi di trasformazione sociale e di definizione propria, sempre in costruzione, di ciò che significa vivere bene.
In tutta la regione latinoamericana è possibile trovare esempi in ogni ambito della vita quotidiana di nuovi atteggiamenti, ben radicati nei loro contesti fisici e culturali, che prosperano all’interno di nuovi orizzonti politici, superando le ideologie dominanti e i regimi convenzionali. Tali iniziative acquistano visibilità crescente nel momento della crsisi, posto che offrono opzioni creative di sopravvivenza e resistono con efficacia ai mega-progetti (grandi opere) che si promuovono senza sosta nella regione. È sempre più difficile attaccare l’etichetta dello sviluppo, con qualsiasi dei suoi aggettivi, su tutte queste iniziative.
Come i popoli andini propongono il modello del “buen vivir” partendo dalla loro cosmovisione, così Illich propone la convivialità partendo da una critica alla società industriale. Convivio è una parola di uso comune in Messico, che allude a una calorosa riunione di vicini di casa o amici. Illich ha investito di un nuovo significato questa parola che, a partire da lui, ha iniziato a indicare un nuovo contesto, un nuovo tipo di società. Così la convivialità diventa ora libertà personale esercitata in una società tecnologicamente matura, che potremmo definire post-industriale. Dobbiamo distinguerla dalla coabitazione fraterna e solidale che troviamo in alcune comunità intenzionali come anche da altre iniziative isolate, ad esempio quelle di chi decide di emarginarsi gradualmente, con apatia e frustrazione, dalla società dei consumi. Essa si riferisce a un’alternativa sociale resa possibile dalla piena maturità industriale. “Chiamo società conviviale” scrisse Illich, “quella in cui gli strumenti moderni sono al servizio della persona all’interno della collettività e non al servizio di un gruppo di specialisti. Conviviale è quella società in cui è l’uomo a controllare gli strumenti”. Dopo aver riconosciuto il suo debito a Brillat-Savarin, Illich precisa anche che “nell’accezione innovativa che conferisco all’aggettivo, sono gli strumenti a diventare conviviali e non l’uomo, perché l’uomo che trova giovamento ed equilibrio nell’impiego degli strumenti conviviali, io lo chiamo austero”. E quest’austerità, chiarisce Illich, non implica isolamento o reclusione ma l’essenza fondante dell’amicizia; si tratta di una virtù che esclude solamente quei piaceri che peggiorano le relazioni personali. “L’austerità è parte di una virtù più fragile che la supera e la ingloba: l’allegria, la eutrapelia (piacevolezza), l’amicizia (Illich 2006: 374).”
Secondo Illich, “si deve salutare la dichiarata crisi delle istituzioni dominanti come l’alba di una liberazione rivoluzionaria che ci permetterà di emanciparci da quelle istituzioni che mutilano le libertà fondamentali dell’essere umano… questa crisi planetaria delle istituzioni può farci raggiungere un nuovo stato di coscienza sulla natura degli strumenti da utilizzare e delle azioni da intraprendere affinché la maggioranza della popolazione possa prendere il controllo… (Idem: 385)”. Di questo si tratta, oggi; questo è ciò che milioni di persone stanno cercando di realizzare in ogni parte del mondo, mentre altrettanti milioni, in un atto di indignazione estremamente conservatore anche se comprensibile e legittimo, invocano a pieni polmoni il ritorno del capitale a riprendere il controllo delle loro vite.
D’altra parte le multinazionali, pensava Illich, possono servirsi del diritto e del sistema democratico per stabilire il loro impero. Illich stimava che la democrazia statunitense sarebbe potuta sopravvivere alla vittoria del generale vietnamita Giap che seppe utilizzare la macchina bellica nordamericana per vincere la guerra in Vietnam, però non sarebbe potuta sopravvivere al trionfo delle multinazionali. Egli avvertiva che la crisi totale avrebbe reso evidente come lo Stato-Nazione moderno altro non è se non un conglomerato di società anonime, dove ogni costellazione di sindacati, corporazioni e istituzioni si occupa di promuovere il proprio prodotto e lavorare per il proprio interesse. “Il corporativismo produce benessere… e il successo si misura attraverso la crescita del capitale all’interno della società. Per loro convenienza, i partiti politici riuniscono tutti gli azionisti per eleggere un consiglio di amministrazione (Illich 2006:478/9)”. Lo stato quindi non assolve più la sua funzione di gestione politica essendosi convertito in mero guardiano delle istituzioni dominanti e l’opportunità di cambiamento nasce proprio nel momento in cui, nel mezzo di una crisi generalizzata, i cittadini percepiscono chiaramente questa situazione. “La perdita di legittimità dello Stato, divenuto una società per azioni, invece di invalidare la necessità di un processo costituzionale, la riafferma. La perdita di credibilità dei partiti, convertitisi in fazioni rivali di azionisti, sottolinea l’importanza del ritorno al dibattito politico… Dalla medesima crisi generale possono avere origine, e durare nel tempo, un patto sociale in cui il potere di creare benessere è lasciato al dispotismo tecnico-burocratico e all’ortodossia ideologica, oppure un’opportunità per la costruzione di una società conviviale che sia in continua trasformazione all’interno di una cornice materiale definita da abolizioni razionali e politiche”. (Ibidem)
Illich era convinto che gli ideali socialisti non si sarebbero potuti convertire in realtà sotto il controllo delle istituzioni dominanti, cioè senza sostituire l’insieme degli strumenti industriali con strumenti conviviali. E la trasformazione degli strumenti (ri-strumentazione) della società, si sarebbe potuta realizzare solo adottando gli ideali socialisti di giustizia. Anticipando la crisi delle istituzioni che avrebbe dato luogo a una liberazione rivoluzionaria e a un nuovo stato di coscienza, Illich sottolineava che se gli strumenti non vengono sottomessi a un controllo politico, “la collaborazione dei burocrati del benessere e dei burocrati dell’ideologia ci farà scoppiare di «felicità». La libertà e la dignità dell’essere umano continueranno a peggiorare, e l’uomo raggiungerà un assoggettamento ai suoi strumenti senza precedenti. Alla minaccia di un’apocalisse tecnocratica, io oppongo una società conviviale. La società conviviale riposerà su contratti sociali che garantiscono a ognuno il più elevato e libero accesso agli strumenti della comunità, con la condizione che nessuno leda l’uguale grado di libertà altrui di accedere agli stessi strumenti (Illich 2006: 385/6)”.
A quarant’anni da queste previsioni sembra che siamo giunti al momento del loro compimento. Le persone si sono trovate a reagire a una crisi che segna un cambiamento epocale e una rottura epistemologica (Esteva 2009). Di fronte a governi andati nel panico per la mobilitazione dei cittadini e strutture di potere economico e politico disposte a qualunque cosa pur di non perdere le posizioni conquistate, milioni di persone si sono messe in movimento. Le loro iniziative hanno assunto ormai le fattezze dell’insurrezione (Esteva 2012). Si mantengono all’interno della resistenza ma sono passate alla disobbedienza. Protestano, ma sono ormai orientati a rifiutare di obbedire in maniera radicale. Denunciano le decisioni prese quotidianamente, gli oltraggi subiti giorno dopo giorno, l’aggressione senza fine, i morti, gli arresti, le distruzioni ambientali e, allo stesso tempo, sfidano la legittimità del sistema stesso e non solo dei suoi emissari: negano loro qualsiasi forma di appoggio e non accettano che la rappresentanza attuale si possa definire ancora una sintesi del consenso sociale. Le persone si assumono sempre più l’obbligo morale e sociale di rifiutare l’obbedienza a un apparato in fin dei conti anonimo e affermano la loro indipendenza da questo apparato, per smettere di essere schiavi degli strumenti, sottosistemi dei sistemi. Riconoscono la decadenza della società consumista e del benessere, di un capitalismo organizzativo e monopolistico interconnesso con lo Stato. Rifiutano con crescente fermezza il dispotismo democratico dominante sotto le cui mentite spoglie si dissimula l’imperialismo politico, economico e tecnico a cui tutti sono sottomessi, ciò che rende ogni promessa elettorale solo un anello in più della catena che imprigiona. Mostrano e dimostrano che la dominazione di classe è innanzi tutto una dominazione sulla coscienza della gente e sulla sua fiducia in se stessa – la cui conseguenza è che il cambiamento viene ridotto alla sola sostituzione dei dirigenti. Gradualmente le persone stanno articolando i termini di un’organizzazione sociale basata sull’energia personale, l’energia che ogni persona è in grado di controllare, all’interno di una condizione di libertà regolata dai princìpi del diritto consuetudinario nella congiuntura dell’antica triade “persona, strumenti e società” e col sostegno dei tre pilastri classici di “amicizia, speranza e sorpresa”.
Riferimenti bibliografici
APFFEL-MARGLIN, Frederique, with PRATEC. The Spirit of Regeneration: Andean culture confronting western notions of development, Zed Books, Londres, 1998.
BERARDI, Franco (BIFO). Lavoro Sapere Precarietà, en republicart.net, abril de 2005 <http://www.republicart.net/disc/precariat/berardi02_it.htm>
CHUJI, Mónica. Modernity, development, interculturality and Sumak Kawsay or living well not better, paper given at the international forum on ‘Interculturality and Development’, Uribia, Colombia, 23 May 2009.
GIOSA ZUAZÚA, Noemí. De la marginalidad y la informalidad, como excedente de fuerza de trabajo, al empleo precario y al desempleo como norma de crecimiento. Los debates en América Latina y sus tendencias. Los debates en Argentina, CIEPP (Centro Interdisciplinarios para el Estudio de Políticas Públicas) Buenos Aires, Octubre 2005.
ESTEVA, Gustavo. Los Tradifas o el fin de la marginación, El Trimestre económico. Vol.L (2),núm. 198, abril-junio 1983.
ESTEVA, Gustavo. Antistasis: L’insurrezione in corso,Asterios Editore, Trieste, 2012.
ESTEVA, Gustavo. Desde Abajo, ponencia presentada en el Coloquio Internacional “Hacia un nuevo paradigma social” Universidad Autónoma Metropolitana (Unidad Xochimilco), abril de 2011.
ILLICH, Iván. Obras reunidas, Vol. I, Fondo de Cultura Económica, México, 2006
MARX, Carlos. El Capital, Vol. I, Fondo de Cultura Económica, México, 1959.
MEADOWS, Donella y otros. The Limits to Growth, New American Library, Nueva York, 1972. En español: ebookbrowse.com/los-limites-del-crecimiento-pdf-. (consultado 24/10/2012)
SBERT, José María. Epimeteo, Iván Illich y el sendero de la sabiduría, Ediciones sin nombre, México 2009.
SHANIN, Theodor. Expoliary Economies: a Political Economy of Margins. Agenda for the Study of Modes of Non-Incorporation as Parallel Forms of Social Economy, Journal of Historical Sociology Vol. 1 No. 1, March 1988.
WEBER, Henri. Que reste-t-il de mai 68? Essai sur les intreprétations des “événements”, Éditions du Seuil, París 1998.
Relazione scritta per il Convegno “Avere il coraggio dell’incertezza. Culture del precariato” – Parigi, 6-7 dicembre 2012. ↩