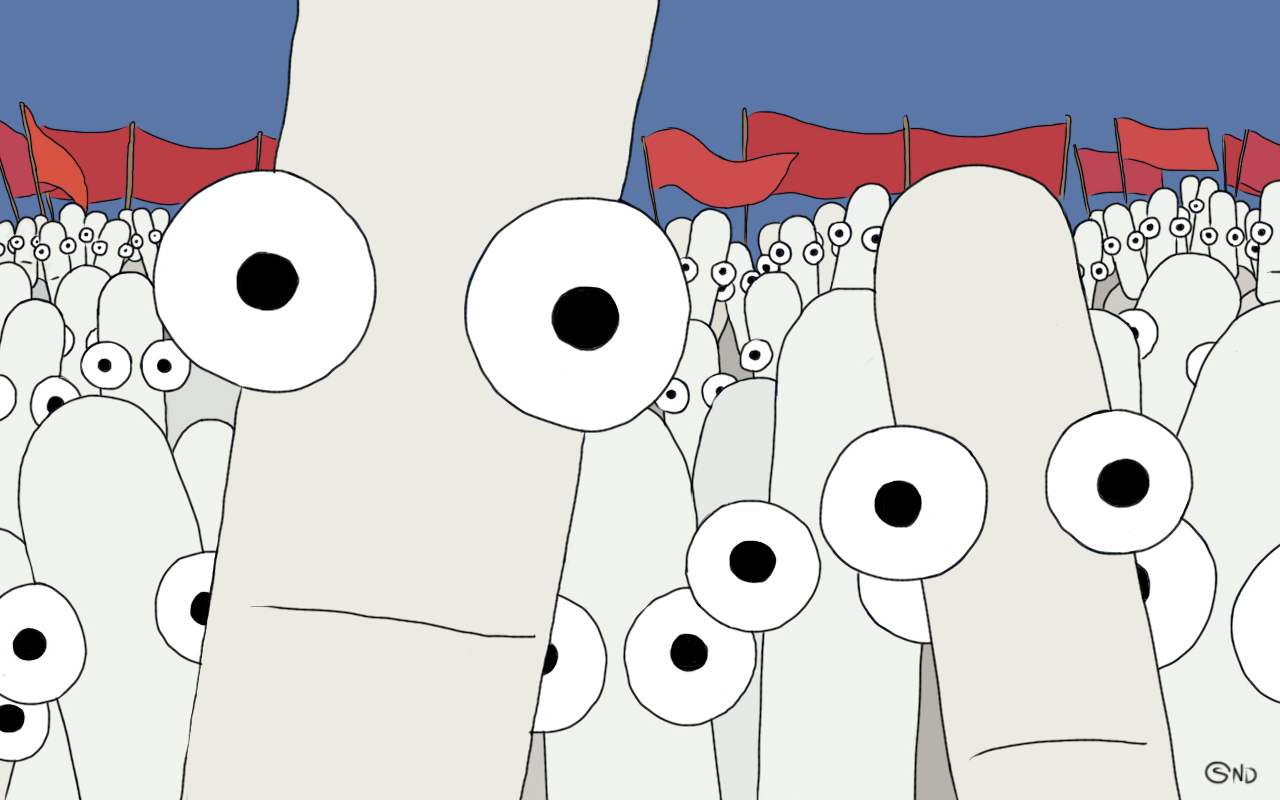di MARCO ASSENNATO, TONI NEGRI.
A Parigi si è appena concluso il 13° congresso della Confederazione Europea dei Sindacati, cartello che conta circa 60 milioni di aderenti per 90 organizzazioni su 39 paesi. Dal congresso è stato prodotto un Manifesto nel quale si tracciano le linee generali dell’iniziativa per i prossimi anni. «Malgrado la forza che rivendica – ha scritto il quotidiano Le Monde – la confederazione ha fatto spesso la figura della stella morta nel panorama europeo». La questione allora è la seguente: può l’esito di questo congresso riaprire l’agenda dell’Europa sociale? Ci pare di no. Il Manifesto di Parigi si limita piuttosto ad incarnare una serie di terreni polemici: più che di una piattaforma programmatica, vi leggiamo l’elenco dei problemi e dei limiti che le lotte sociali dovrebbero porsi l’obiettivo di spezzare.
La CES mostra di non avere ancora capito nulla della trasformazione radicale che ha investito – da almeno un quarantennio – la composizione tecnica del lavoro. L’insistenza nel considerare la precarietà una distorsione su un corpo largo di lavoro normale – da correggere con qualche atto di buona volontà – rende il sindacato europeo interamente incapace di intercettare le nuove figure della produzione biopolitica e d’immaginare forme di lotta all’altezza del capitalismo finanziario, del debito e dell’impoverimento di massa. Il neoliberismo si configura innanzitutto come diagramma di estrazione del profitto dalla cooperazione sociale. D’altro canto esso nasce dalla crisi generalizzata di tutte le strutture disciplinari che regolavano la vita fino agli anni settanta del secolo scorso, dalla rottura definitiva della misura del valore prodotto dal lavoro operaio. Si dovrebbe allora discutere di forme di lotta efficaci su questo nuovo terreno. La produzione immateriale e cognitiva investe lo spazio intero della vita: a partire da questo presupposto dunque sindacato, coalizione sociale, sciopero per noi guadagnano una qualificazione immediatamente politica; investono le strutture della produzione come quelle della riproduzione; stringono insieme Nuovo Welfare e salario sociale; declinano le tappe dell’immaginazione democratica e transnazionale contro le derive repressive e le chiusure nazionalistiche. Ma la Confederazione Europea dei Sindacati è incapace di guardare a questi dati di fatto.
Il congresso di Parigi ci consegna inoltre la riproposizione di pesanti limiti di lettura delle dinamiche istituzionali. Dal Trattato di Maastricht, a quello di Amsterdam e poi alle risultanti dei due summit di Lisbona e Nizza, le relazioni industriali e i rapporti tra sindacato e organizzazioni padronali hanno subito una radicale trasformazione. Le politiche di flexecurity e la gestione della crisi finanziaria hanno configurato, almeno dal 2006, un attacco continuo e ripetuto ai diritti dei lavoratori. In particolare sembra derubricato – attraverso la strategia del dialogo sociale interno agli assetti della governance europea – ogni riconoscimento del conflitto come momento naturale della formazione di relazioni produttive più eque. Il diritto del lavoro e i diritti sociali sono stati ricondotti tra le maglie del diritto civile – vengono cioè regolamentati secondo criteri di polizia e di ordine pubblico – mentre l’asimmetria tra capitale e lavoro, fondativa del giuslavorismo della seconda metà del novecento, scompare o si scioglie nel mito di individue parti equivalenti in un regime pluralistico. In questo quadro, il diritto di sciopero che si reggeva appunto sul riconoscimento di quella asimmetria, tende a scomparire.
In particolare il limite fondamentale del sindacato europeo ci sembra consistere nella sua paradossale incapacità di immaginarsi fuori dallo schema dello Stato-Nazione. La Confederazione Europea dei Sindacati ha provato a proiettare sullo spazio europeo le procedure che le risultavano familiari, abitudinarie, negli spazi nazionali. La CES persevera nell’immaginare che la Commissione Europea possa funzionare come Stato regolatore attorno al quale ricostruire, sul livello continentale, il triangolo delle relazioni convenzionali (a livello nazionale) Stato-impresa-lavoratori. Perciò il Manifesto di Parigi rivendica il «coinvolgimento nell’elaborazione delle strategie europee in materia di occupazione e di politica economica e sociale» e al contempo conferma la necessità di «rafforzare i sistemi di negoziazione collettiva degli accordi al livello nazionale». Un corpo burocratico pesante: questo è la CES. Ed essa pensa concluso il proprio compito quando associa lavoratori dipendenti inquadrati da contratti nazionali. Il Manifesto di Parigi definisce il negoziato istituzionale la «ragion d’essere» del sindacato e «la crescita, il pieno impiego e la buona governance» i suoi, essenziali, obiettivi. Così però il sindacato si condanna a un doppio scacco: la vaghezza del suo spazio d’iniziativa continentale – essenzialmente quello di una lobby marginale e interna alle istituzioni europee, con funzione di consultazione in materia fiscale e di mercato del lavoro – si raddoppia solo nella perdita di forza che la contrattazione nazionale registra ormai da decenni (non foss’altro che per la sua strutturale incapacità di includere le nuove figure della produzione biopolitica).
Diamo attenzione al padronato, e le cose saranno più chiare. In primo luogo notiamo che non esiste una Confederazione europea del padronato. Esistono circa 80 federazioni padronali di settore in Europa, le quali si comportano come singoli attori nella rete della governance e non hanno alcuna intenzione di riconoscere la CES come interlocutrice. Unico punto di convergenza dei padroni: mai riconoscere il livello europeo come livello politico. Guardiamo adesso dentro al sindacato: vi troviamo la replica paradossale del medesimo spartito. Basti richiamare alla memoria le imbarazzanti posizioni della Federazione Europea dei Metallurgici (FEM) che dopo avere a lungo cercato – almeno dal 1973 – di immaginare livelli di coordinamento dell’iniziativa operaia sul piano continentale, è ormai svuotata di ogni funzione, per responsabilità soprattutto dell’IGM tedesca del tutto indisponibile a ragionare al di fuori del quadro nazionale. Ma veniamo qui a un punto di necessario chiarimento: il livello europeo che dovrebbe interessare il sindacato è prima di tutto quello delle lotte e delle rivendicazioni. Questioni del tutto obliterate dal congresso di Parigi che conferma l’indisponibilità delle confederazioni all’iniziativa transnazionale (al più flebilmente evocata) e incardina il sindacato in una cultura dai riflessi nazionalistici del tutto funzionale allo schema dell’Europa a trazione tedesca.
Ci pare che sia sostanzialmente su questi nodi che l’esito del congresso di Parigi vada valutato. Resistere contro le politiche di austerità è, almeno formalmente, la divisa che il congresso ha scelto di lanciare. Ma, fuor di retorica, i nodi fondamentali che hanno sin qui impedito la costruzione di uno spazio europeo d’iniziativa sindacale, restano tutti presenti. Nessun riconoscimento delle nuove forme del lavoro; non una parola sul un salario sociale per tutti e tutte; neppure sull’ipotesi di impegnare le singole organizzazioni nazionali in una campagna per il Salario Minimo Legale Europeo, il congresso è riuscito a fare un passo avanti, chiudendo la questione con l’imbarazzante formula secondo la quale il salario minimo è obiettivo comune «nei paesi in cui i sindacati lo reclamano». La questione della democrazia sui luoghi di lavoro è ridotta alla richiesta di ampliare le occasioni di «rappresentanza dei lavoratori nei consigli di amministrazione delle imprese». Uniche rivendicazioni: investimenti per la crescita, una tassa sulle transazioni finanziarie e un rocambolesco riferimento all’impegno di tutti per «contribuire a una mondializzazione più equa».
Ci pare che una iniziativa sindacale fuori dai confini dello stato-nazione sia possibile solo opponendo un nuovo discorso sul salario alla retorica della crescita. Ci è sembrato di scorgere delle tracce interessanti, nelle recenti esperienze tedesche del sindacato Ver.di, ad esempio contro Amazon e, più in generale, nelle iniziative di alcuni sindacati dei servizi, dei trasporti e della logistica: innanzitutto perché queste iniziative incrociano direttamente il fenomeno della mobilità continentale, il tema delle migrazioni e il dumping sociale – forse rovesciandone il senso; e in secondo luogo perché determinano (rompendo il nuovo corporativismo sindacale) un rimescolarsi delle categorie professionali coinvolte, producendo così un dispositivo cooperativo tra categorie di lavoratori sempre più flessibili e mobili.
Comunque, far proposte positive dopo aver raccontato con realismo l’attuale deficienza della CES, sembra fuori luogo. Non sarà certo sulla sua buona volontà che potremo contare. D’altra parte, il terreno sindacale è infido e, come si diceva, oggi predisposto al blocco di ogni lotta, pur anche timidamente riformista. Eppure ogni progetto di lotta di classe, a livello industriale come nella società, non può dimenticare che l’Europa ne costituisce il terreno essenziale. E come già si diceva ci sono settori “sindacali” (reddito sociale, servizi cognitivi ed informatici, “produzioni dell’uomo per l’uomo” – scuola, ospedali, ecc., logistica, trasporti, lavoro autonomo) nei quali possono essere costituiti momenti o tendenze di rottura biopolitica degli equilibri salariali e della loro programmazione budgettaria. Lavorare oggi alla “coalizione sociale” e considerare il ruolo essenziale che qui da noi la FIOM può avere in essa, significa anche tener presente, nel nostro agire, il tema della recinzione della contrattazione dentro i confini nazionali. Si dirà: come farlo nel momento stesso nel quale il padronato sta rompendo ogni prospettiva di contratto a livello nazionale e tentando di spezzettare la contrattazione fino al livello individuale? Quousque tandem. Noi non sosteniamo certo questo. Oltre a sostenere l’efficacia della contrattazione nazionale chiediamo solo che ci si muova, a livello europeo, per stabilire un progetto di costituzione comune della forza lavoro organizzata. Che alla moneta europea corrisponda un salario europeo. Che alla dimensione sociale del salario corrisponda una proposta sociale di lotta. E bisogna farlo subito perché non siano i padroni ad anticiparne, con propri dispositivi di soggezione, ancora una volta la realizzazione. Perché, ricordiamolo, se saranno loro a farlo il proletariato italiano, industriale e cognitivo, sarà nel prossimo secolo rispetto all’Europa, quello che è stato in Italia il proletariato del Sud rispetto a quello del Nord nell’ultimo secolo.