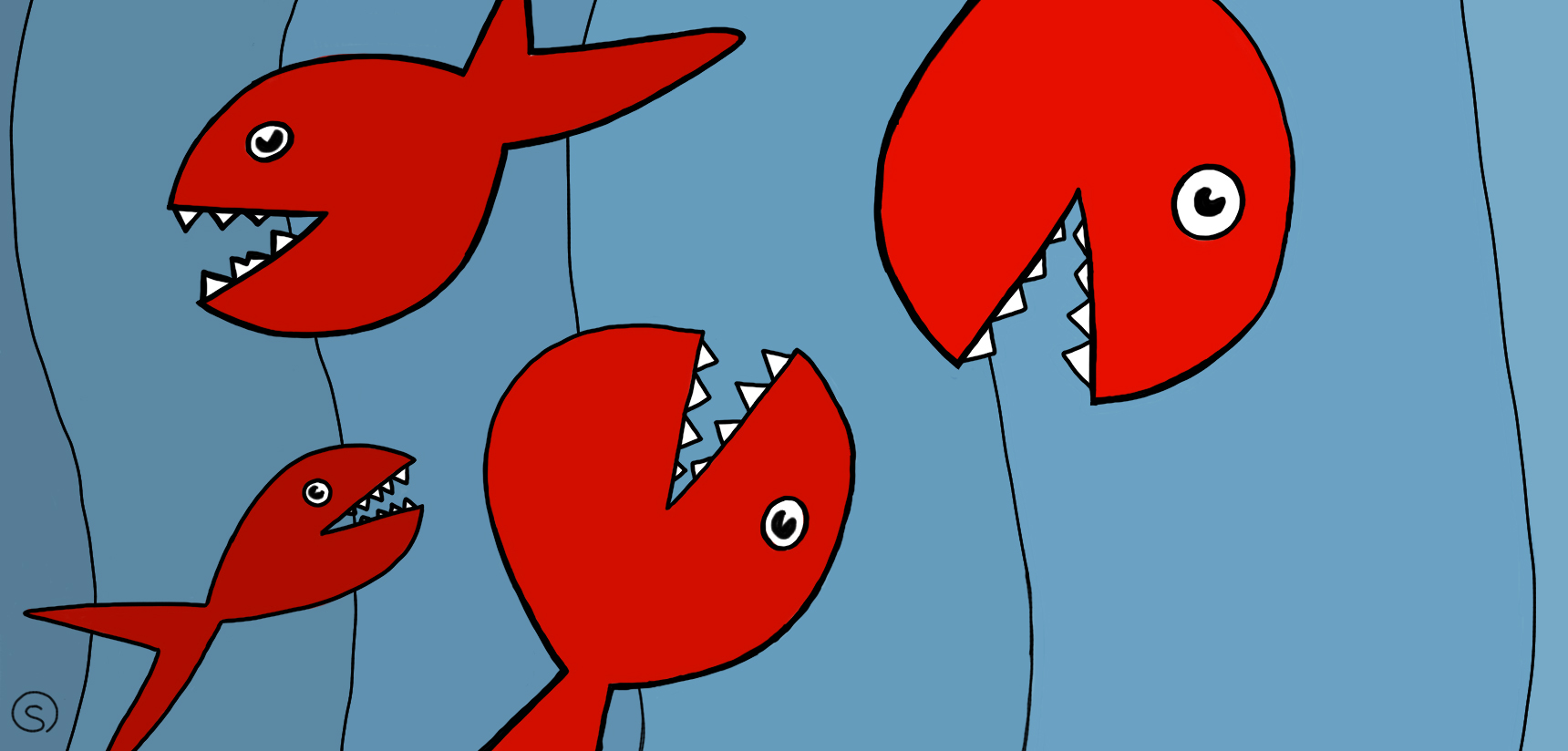di LAURENT BOVE.
Presentazione: La misura comune del divenire-democrazia.
di TONI NEGRI.
Nel presentare questo testo di Laurent Bove, bellissimo ed un po’ paradossale, vorrei prima di tutto evocare il luogo nel quale l’ho sentito pronunciare. Eravamo a Rio, in una villa-albergo (nella quale si teneva il convegno spinozista dell’America latina) alta sulla città, di dove si dominava uno dei più formidabili ed incantevoli paesaggi metropolitani offerti all’occhio ed alla ragione. Sotto c’era la città – Rio, appunto – ancora attraversata dalle tensioni e dalle polemiche, dalla rottura del fronte democratico che le lotte moltitudinarie di giugno-luglio avevano provocato. Queste rotture, non di poco conto, toccano la stessa definizione di “democrazia” e si risentivano fortemente dentro il convegno. Si trattava dunque di discutere di democrazia, di prendere posizione, detto grossolanamente, fra chi considera la democrazia possibile solo nell’ambito di un esercizio di sovranità e chi considera la democrazia come prodotto di lotte e dalla macchina costituente della moltitudine. Il testo di Laurent (concepito e redatto ben prima degli eventi di Rio) non interveniva certo nel dibattito politico in corso e non assumeva posizione in esso, ma ne era per così dire attratto, meglio detto, riordinava la discussione in atto.
E la riordinava proprio a partire da quello che non era solo il problema teorico e politico ma anche la tonalità passionale del dibattito, la sua caratteristica drammatica – perché l’esperienza politica, dinnanzi ad eventi della forma e della pesantezza di quelli brasiliani è sempre tale. Spinoza, ci ricorda Bove (e lo aveva già ricordato nel suo lungo lavoro di lettore del pensiero spinozista – si veda soprattutto: La Strategia del conatus. Affermazione e resistenza in Spinoza, Spinoziana Ghibli, Milano, 2002), lavorava sulle passioni. Ed era dunque su questo terreno che il dibattito (ormai non più solo brasiliano se mai lo fosse stato) veniva riportato: non più sovranità e democrazia, ma la democrazia e le sue passioni/virtù (vale a dire, fiducia, ricerca della sicurezza, e desiderio-misura-esercizio dell’eguaglianza, pietas, fortitudo, e generosità, e poi la melanconia e la hilaritas … oltre all’indignazione e alla paura …). Oggi questo metodo di costruzione della critica sociale e politica a partire dall’analisi delle passioni è di nuovo massimamente presente agli studiosi: Foucault lo ha magistralmente presentato nelle sue Lezioni. E non bisogna dimenticare quanto quel metodo, nelle sue determinazioni classiste (che significano passione e soggettivazione nelle lotte dei poveri, degli esclusi, degli sfruttati), fosse presente in Marx, soprattutto nei suoi Scritti storici. Noi, che su quegli scritti ci siamo formati, siamo poi discesi a Spinoza per trovarne una forte matrice. È quella stessa che Bove – in questa nuova esposizione – mette in luce, scavando, dal punto di vista militante, le passioni costituenti della democrazia.
 Non è qui il luogo per ripercorrere con completezza e tanto meno per criticare le tesi di Bove. Riassumendone il tema centrale al quale aderisco, si dirà che in Spinoza la democrazia è la sola forma di governo che si addice ad uomini liberi. E che questa democrazia si basa non sulla “fiducia politica che gli uomini concedono a quelli che li governano e che, in sostanza, li dominano” bensì su “una concezione nuova, originale, di una fiducia immanente ai fondamenti stessi della sicurezza dello Stato; una fiducia politica che si costruisce e si perpetua sulla base di istituzioni democratiche, armate di contro-potere”. Il secondo tema essenziale riguarda il contenuto dell’azione del governo. Esso, in quanto prodotto dalla moltitudine, in quanto qualificato come governo democratico, non può che essere governo dell’eguaglianza. L’eguaglianza è misura comune della democrazia. Non c’è democrazia senza una comune misura materiale, egalitaria, sulla base della quale alla moltitudine sia permesso non solo di esprimere politicamente la sua fiducia (ed il suo contropotere) nei confronti di un governo ma, su questa base, di costruire istituzioni. Senza l’eguaglianza, scrive Spinoza, la libertà comune sprofonda in rovina. E qui, terzo tema, terzo elemento, tanto paradossale quanto potente: è nell’Hilaritas (definita da Spinoza come affetto di gioia congiunto, ad un tempo, sia all’anima che al corpo) che la democrazia si afferma. L’hilaritas (o eccitazione piacevole) occupa tutto il corpo e ne aumenta la potenza di agire, fino a quell’altissimo livello che vede tutte le parti del corpo e della mente raggiungere equilibrio; ed è inoltre, l’hilaritas, un affetto sempre buono, che non può avere eccesso; essa ci offre, per eccellenza, la misura della passione democratica – una misura di eguaglianza nel corpo politico, nel quale giocano insieme il desiderio di autonomia di ciascuno ed il piacere di vivere insieme, di far Corpo insieme, nell’eguaglianza. Questa dimensione materialista e sensuosa dà pieno risalto all’hilaritas come affetto posto contro ogni malinconia, e come serenità dei corpi posta contro ogni vuota speranza o utopia. Vi è poi un quarto tema: esso riguarda i modi nei quali la moltitudine può garantire, esercitando contropotere, che la democrazia regga nel tempo eliminando ogni tentazione oligarchica o deriva monarchica. A questo proposito, il carattere machiavelliano della politica spinozista risalta con estrema evidenza – per quanto ilare e sereno il cittadino non si farà circuire dalle tristi passioni del dominare che così facilmente corrompono e distruggono la democrazia. Un’attenzione machiavellica è posta a rompere con ogni astuzia (o occasione o evento o eccezione o istituzione) che possa produrre un potere eccedente la forza di contropotere della moltitudine. Con vera intelligenza, preoccupata attenzione, sospettosa vigilanza andranno allora controllate (da parte della moltitudine) le istituzioni e chi ne esercita il governo. Infine, va ricordato un quinto tema – più sottile, ma senz’altro digeribile dai lettori di Euronomade – nel quale Bove ci mostra come l’hilaritas da affetto “passivo” (in quanto determinato da un ambiente esterno) possa trasformarsi in passione “attiva” – in potenza ragionevole che esalta la democrazia come destituzione del dominio e come trionfo dell’autonomia. Poiché “l’hilaritas, la cui causalità è esterna, irradia tuttavia la potenza della moltitudine” ed è attraverso l’opera dell’immaginazione che quella passione gioiosa è portata alla potenza di far corpo con/di Desiderio e Amore (con la cupiditas del corpo e con l’amor della ragione) – vivendo nell’eguaglianza, e in quel comune che è democrazia. Ci sarà chi protesta ritenendo questa hilaritas, questo dell’hilaritas democratica, un paradosso democratico troppo cervellotico. Ma non lo farà chi ha vissuto periodi o epoche di lotta rivoluzionaria e sa che il ridere e le passioni gioiose trasformano l’eguaglianza in fratellanza e chi ha fatto – con serenità – l’esperienza di una moltitudine che produce democrazia – vale a dire, governo del comune.
Non è qui il luogo per ripercorrere con completezza e tanto meno per criticare le tesi di Bove. Riassumendone il tema centrale al quale aderisco, si dirà che in Spinoza la democrazia è la sola forma di governo che si addice ad uomini liberi. E che questa democrazia si basa non sulla “fiducia politica che gli uomini concedono a quelli che li governano e che, in sostanza, li dominano” bensì su “una concezione nuova, originale, di una fiducia immanente ai fondamenti stessi della sicurezza dello Stato; una fiducia politica che si costruisce e si perpetua sulla base di istituzioni democratiche, armate di contro-potere”. Il secondo tema essenziale riguarda il contenuto dell’azione del governo. Esso, in quanto prodotto dalla moltitudine, in quanto qualificato come governo democratico, non può che essere governo dell’eguaglianza. L’eguaglianza è misura comune della democrazia. Non c’è democrazia senza una comune misura materiale, egalitaria, sulla base della quale alla moltitudine sia permesso non solo di esprimere politicamente la sua fiducia (ed il suo contropotere) nei confronti di un governo ma, su questa base, di costruire istituzioni. Senza l’eguaglianza, scrive Spinoza, la libertà comune sprofonda in rovina. E qui, terzo tema, terzo elemento, tanto paradossale quanto potente: è nell’Hilaritas (definita da Spinoza come affetto di gioia congiunto, ad un tempo, sia all’anima che al corpo) che la democrazia si afferma. L’hilaritas (o eccitazione piacevole) occupa tutto il corpo e ne aumenta la potenza di agire, fino a quell’altissimo livello che vede tutte le parti del corpo e della mente raggiungere equilibrio; ed è inoltre, l’hilaritas, un affetto sempre buono, che non può avere eccesso; essa ci offre, per eccellenza, la misura della passione democratica – una misura di eguaglianza nel corpo politico, nel quale giocano insieme il desiderio di autonomia di ciascuno ed il piacere di vivere insieme, di far Corpo insieme, nell’eguaglianza. Questa dimensione materialista e sensuosa dà pieno risalto all’hilaritas come affetto posto contro ogni malinconia, e come serenità dei corpi posta contro ogni vuota speranza o utopia. Vi è poi un quarto tema: esso riguarda i modi nei quali la moltitudine può garantire, esercitando contropotere, che la democrazia regga nel tempo eliminando ogni tentazione oligarchica o deriva monarchica. A questo proposito, il carattere machiavelliano della politica spinozista risalta con estrema evidenza – per quanto ilare e sereno il cittadino non si farà circuire dalle tristi passioni del dominare che così facilmente corrompono e distruggono la democrazia. Un’attenzione machiavellica è posta a rompere con ogni astuzia (o occasione o evento o eccezione o istituzione) che possa produrre un potere eccedente la forza di contropotere della moltitudine. Con vera intelligenza, preoccupata attenzione, sospettosa vigilanza andranno allora controllate (da parte della moltitudine) le istituzioni e chi ne esercita il governo. Infine, va ricordato un quinto tema – più sottile, ma senz’altro digeribile dai lettori di Euronomade – nel quale Bove ci mostra come l’hilaritas da affetto “passivo” (in quanto determinato da un ambiente esterno) possa trasformarsi in passione “attiva” – in potenza ragionevole che esalta la democrazia come destituzione del dominio e come trionfo dell’autonomia. Poiché “l’hilaritas, la cui causalità è esterna, irradia tuttavia la potenza della moltitudine” ed è attraverso l’opera dell’immaginazione che quella passione gioiosa è portata alla potenza di far corpo con/di Desiderio e Amore (con la cupiditas del corpo e con l’amor della ragione) – vivendo nell’eguaglianza, e in quel comune che è democrazia. Ci sarà chi protesta ritenendo questa hilaritas, questo dell’hilaritas democratica, un paradosso democratico troppo cervellotico. Ma non lo farà chi ha vissuto periodi o epoche di lotta rivoluzionaria e sa che il ridere e le passioni gioiose trasformano l’eguaglianza in fratellanza e chi ha fatto – con serenità – l’esperienza di una moltitudine che produce democrazia – vale a dire, governo del comune.
La moltitudine strappa, nella democrazia spinozista, ogni legittimità alla “democrazia” quand’essa sia semplicemente intesa come figura della sovranità dei moderni. Quest’ultima è espressione dell’individualismo, è trionfo della proprietà privata, è trascendenza del potere sovrano. Per Spinoza, non può invece esservi imperium, comando, che non sia il prodotto della potenza della moltitudine – quando non sia tale, l’imperium è logica distruzione del corpo umano. La potenza della moltitudine non può né essere alienata né essere sviluppata in compromessi mediatori, e neppure esser vagamente partecipata: insomma non può vivere nella rappresentanza. La democrazia spinoziana può vivere solo di attività assolutamente espressiva e di contropotere. I compagni che in Brasile lottano sul terreno metropolitano per affermare una vera eguaglianza, negata da un sovrano razzista per 389 anni di storia, per dar corpo ad una moltitudine che goda nel vivere e costruire in comune – bene, essi traggono da questo intervento di Bove una speranza forte – forse un progetto di una nuova costituzione della libertà per quel popolo così generoso, così forte e così voglioso di eguaglianza. Certamente quelle indicazioni di esercizio di contropotere valgono anche per noi alle prese con la necessaria costruzione di una nuova costituzione, fondata sulla misura comune di eguaglianza, per l’Europa. Per farne quello che non è mai stata, per farne quella realtà democratica che le attuali classi dirigenti non vogliono in ogni caso che sia.
DELLA FIDUCIA POLITICA: COSTRUIRE L’HILARITAS DEMOCRATICA
di LAURENT BOVE
La questione della “fiducia” dei cittadini nei confronti della loro “classe politica”, o quella della fiducia delle società nell’avvenire immediato: questo tema è oggi ben presente sia in Europa che in America Latina. Per questo vorrei qui fare il punto su quello che Spinoza può insegnarci sulla questione appunto della “fiducia” politica.
È proprio della fiducia politica che Spinoza ci parla, quando nello Scolio 2 della Proposizione 37 di Eth. IV, a proposito del patto, si interroga sulla maniera in cui gli uomini possono procedere per darsi (egli dice) una mutua assicurazione ed instaurare una “mutua fiducia” (et fidem invicem habere), al fine di vivere insieme in sicurezza. E nel Trattato Politico (I, 6), è proprio sulla fiducia accordata all’uomo politico che Spinoza ci mette in guardia. In effetti, contro la fiducia che i soggetti pongono ingenuamente nella lealtà di coloro che gestiscono gli affari pubblici, Spinoza ricorda che al contrario un buono cammino e la sicurezza dello Stato esigono da parte dei cittadini, una vigilanza e un sano sospetto nei confronti dell’esercizio del potere. E che è su questa vigilanza di tutti che solamente la fiducia politica potrà effettivamente darsi. Una vigilanza che deve materializzarsi attraverso la creazione di istituzioni democratiche di contro-potere che integrino i poteri di resistenza al dominio, fra cui la resistenza armata al sovrano se costui fosse tentato d’opprimere i suoi soggetti (come lo mostra chiaramente l’esempio dato dello Stato degli Aragonesi di cui Spinoza fa l’elogio in TP VII, 30).
Vorrei dunque dimostrare che, contro l’ingenua fiducia che gli uomini concedono a coloro che li governano e che, in sostanza, li dominano, Spinoza propone una concezione nuova, originale, di una fiducia immanente ai fondamenti stessi della sicurezza dello Stato; una fiducia politica che si costruisce e si perpetua sulla base di istituzioni democratiche armate di contro-potere.
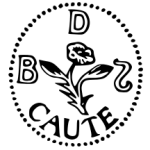 Affermando, in effetti, che “la virtù dello Stato è la sicurezza” (imperii virtus securitas) Spinoza pone necessariamente una potenza del corpo politico (la sua propria virtù, in senso spinozista …) che è capace d’agire per la propria sicurezza attraverso le leggi della sua propria natura (come dice la definizione 8 della “virtù” all’inizio di Eth. IV). E il corpo politico – come individuo – è dunque capace di provare in questo libero esercizio della sua potenza, un affetto, in qualche modo una acquiescentia in se ipso che deborda ampiamente il semplice sentimento soggettivo di sicurezza … È in questa acquiescentia propria del corpo politico, in quella gioia comune a tutti i membri di tale corpo, che io propongo di ritrovare una fiducia politica in senso spinozista. L’acquiescentia di un corpo comune è, in effetti, una gioia condivisa tanto nella, quanto attraverso la fiducia nella virtù, vale a dire con la potenza stessa di quel corpo; una gioia fiduciosa che solo le istituzioni di contro-potere possono rendere possibile, perennizzare e prolungare indefinitivamente.
Affermando, in effetti, che “la virtù dello Stato è la sicurezza” (imperii virtus securitas) Spinoza pone necessariamente una potenza del corpo politico (la sua propria virtù, in senso spinozista …) che è capace d’agire per la propria sicurezza attraverso le leggi della sua propria natura (come dice la definizione 8 della “virtù” all’inizio di Eth. IV). E il corpo politico – come individuo – è dunque capace di provare in questo libero esercizio della sua potenza, un affetto, in qualche modo una acquiescentia in se ipso che deborda ampiamente il semplice sentimento soggettivo di sicurezza … È in questa acquiescentia propria del corpo politico, in quella gioia comune a tutti i membri di tale corpo, che io propongo di ritrovare una fiducia politica in senso spinozista. L’acquiescentia di un corpo comune è, in effetti, una gioia condivisa tanto nella, quanto attraverso la fiducia nella virtù, vale a dire con la potenza stessa di quel corpo; una gioia fiduciosa che solo le istituzioni di contro-potere possono rendere possibile, perennizzare e prolungare indefinitivamente.
Il nostro oggetto di riflessione è dunque questa acquiescentia che condividono in maniere immanente, e à égalité, tutti i membri di uno stesso corpo. È dunque necessariamente, attraverso la questione dell’eguaglianza della gioia comune che noi dobbiamo affrontare la riflessione sulla fiducia politica in Spinoza.
Constatiamo innanzitutto che tanto nel TTP che nel TP Spinoza pone come principio antropologico fondamentale il desiderio di ciascuno di non essere comandato da un eguale.
In effetti, scrive Spinoza nel capitolo V,8 del TTP, “nulla è più insopportabile agli uomini che l’essere sottomessi ai loro eguali (o ai loro simili) ed essere comandati da loro”. Da questo principio Spinoza deduce due serie di conseguenze di natura politica: “ne viene”, dice : in primo luogo, che “la società intera, se è possibile, deve esercitare collegialmente il potere al fine che in questo modo ognuno sia tenuto ad obbedire a se stesso e non a un suo eguale” … E si ottiene così la democrazia. Ovvero, ed è questa una seconda soluzione : “se un piccolo numero o un solo uomo detiene il potere, esso deve avere in sé qualcosa che supera la natura umana comune, o almeno deve cercare con tutte le sue forze di persuaderne il volgo” (TTP, V,8-9). E così noi entriamo nelle mistificazioni che accompagnano necessariamente il dominio.
Questa seconda soluzione prospetta tuttavia anche un caso eccezionale che sembra essere stato unico nella storia. Quello di un uomo che a causa di una “virtù divina”, può offrire a un popolo rimasto allo stato d’infanzia – vale a dire incapace di vivere in democrazia – una soluzione perfettamente adattata alla sua situazione primitiva ma anche al desiderio umano, che è condiviso fra tutti (barbari o civilizzati), di non volere essere comandati da un eguale-simile: questa soluzione eccezionale è quela soluzione teocratica offerta da Mosè al popolo ebraico.
Se si esamina brevemente questo caso di soluzione eccezionale, si vede che Spinoza ci offre, nella descrizione dello Stato degli Ebrei, un esempio di “fiducia” politica perfetta, ma in un regime immaginario e di totale eteronomia mentale dei soggetti poiché si tratta, in questo preciso caso, di far vivere politicamente insieme un “popolo-bambino”.
In questo esempio noi troviamo in effetti, innanzitutto, la fiducia, in quanto fides, al principio stesso della genesi dello Stato degli Ebrei, sotto la forma di una triplice fiducia: fiducia degli Ebrei verso Mosè, fiducia degli Ebrei in Dio, e fiducia di Dio verso Mosè. L’oggetto di questa triplice fiducia è esplicitamente raccontato da Spinoza: è la “potenza”, ed è una potenza benefica. Innanzitutto, la potenza di Mosè, che vive tutta intera la sua “virtù divina”. Di seguito, la potenza di Dio che ha permesso la traversata del Mar Rosso, poi del deserto e che è assunta come oggetto supremo di fiducia.
Noi sappiamo tuttavia che questa fiducia degli Ebrei verso Dio come verso Mosè è, innanzitutto, il segno della loro impotenza a causa della debolezza delle loro forze dopo un lungo periodo di schiavitù che li ha resi incapaci di governarsi da soli – è ciò di cui hanno fatto esperienza terribile al momento del loro primo patto. Terrorizzati tuttavia per la maniera singolare nella quale la Parola di Dio si manifesta quando loro la invocano, gli Ebrei si sono offerti, di nuovo ed interamente, a Mosè. (TTP, XVII,9).
Nella realtà effettiva, la mediazione che Mosè opera allora nell’opinione degli Ebrei, tra Dio e il suo popolo, non è in verità nient’altro, per Spinoza, che la mediazione che questo popolo opera sulla propria potenza-impotente. Una potenza tuttavia politicamente produttiva dentro e attraverso la dimensione costituente della fiducia.
Sottolineiamo allora come Spinoza non cesserà mai, lungo tutto il TP, di denunciare la follia, per un popolo, di accordare la propria fiducia (o di confidare nella propria salvezza) a chiunque, senza essersi prima assicurato condizioni materiali di contro-potere che debbono necessariamente obbligare l’uomo politico ad agire – per ragione, calcolo, o passione – in maniera tale che in tal modo la difesa e la promozione del bene comune siano assicurate. (TP, VI, 3,5; VII, 17,30; X, 10). Nel TTP Spinoza mostra che Mosè – che non è un tiranno – ha avuto lui stesso cura d’instaurare per la libertà del suo popolo una doppia resistenza interna alle logiche della dominazione, dentro e attraverso le istituzioni dello Stato. Resistenza innanzitutto al potere ribelle della moltitudine, certo; ma resistenza anche e soprattutto al potere tirannico dei Capi che dovranno essere controllati da contro-poteri – che sono, ad un tempo, l’interpretazione della legge riservata a un solo Pontefice, la vigilanza di un popolo in armi educato nella Legge e pronto alla propria difesa, il timore infine di un nuovo Profeta che il popolo riterrebbe inviato direttamente da Dio per giudicare gli atti dei Capi o la cattiva interpretazione delle leggi (TTP, XVII, 16-20).
Nel caso di Mosè dunque – eccezionalmente – la fiducia di un popolo non è stata tradita. Questa fiducia, politicamente costituente, è di due ordini: quello di una opinione, e quello di un’utilità effettiva attraverso una verifica pratica.
Ciò che ha valore di opinione, è tutto ciò che si riferisce alla fede. Quello che ha valore di utilità effettiva, è il funzionamento stesso dello Stato che implica che quella fede racchiuda necessariamente un’obbedienza i cui effetti sono benefici a tutti. E ciò perché il diritto di natura di ciascuno, lungi dall’esser stato abbandonato a chicchessia, può al contrario attraverso la perfezione stessa delle istituzioni teocratiche, affermarsi sempre di più come il principio dinamico e continuo della realtà dello Stato (TTP, XVII, 8). In questa fiducia costituente, la fede o l’opinione possono essere distinte dall’utilità effettiva solo astrattamente, poiché quell’opinione degli Ebrei è l’elemento primo e determinante della costituzione della realtà effettiva, totale, attraverso tutte le pratiche. È a causa della pregnanza della loro fede che, scrive Spinoza, “l’amore degli Ebrei per la loro patria era dunque non solo amore ma pietas” (TTP, XVII, 23).
Ma che cos’è la pietas ? è la dimensione pratica ed essenziale della fiducia e cioè l’effettività di un Desiderio che, nel caso degli Ebrei, è un affetto passivo a dimensione immaginativa. E tuttavia la pietas può anche essere un affetto attivo e perciò stesso razionale.
La “pietà”, scrive in effetti Spinoza nello Scolio della Proposizione 37, Eth. IV, è “il desiderio di fare del bene che nasce in noi dal fatto che viviamo secondo la guida della ragione”. La proposizione 41 di Eth. V ricorda la connessione necessaria tra pietà e religione: quest’ultima concerne tutti i desideri e tutte le azioni di cui noi siamo causa in quanto abbiamo l’idea di Dio e in quanto noi conosciamo Dio. La stessa proposizione ricorda anche che pietà e religione si esprimono anche attraverso la forza d’animo (la fortitudo) che si divide poi in Fermezza e Generosità.
Constatiamo allora che la pietas degli Ebrei e la fermezza di cuore che essa esprime, sviluppano di fatto il significato etico della pietà, ma proprio in quel campo chiuso della conoscenza immaginativa che è lo spazio simbolico e politico del loro Stato. Ma qui, è dall’opinione e a causa della razionalità propria alle istituzioni teocratiche che gli Ebrei sono condotti a vivere con una fermezza di cuore eccezionale, e non, certo, a causa della propria ragione.
Bisogna ammettere allora, alla luce dell’Etica, che la costituzione giuridico-politica dello Stato degli Ebrei ha la virtù di permettere l’attualizzazione integrale dell’essenza singolare (ovvero della potenza singolare) di quel Corpo collettivo, in un processo di causalità adeguata di tutte le sue pratiche (considerate come effetti). Questa causalità s’accompagna necessariamente, in quanto adeguata, ad una gioia specifica comune che è quella di una sorta di acquiescentia in se ipso che s’irradia in tutte le azioni di questo Corpo, come pietas e constantia.
Sottolineamo tre cose :
1°) che si può del tutto legittimamente parlare di una acquiescentia nel registro dell’immaginazione, come nel caso nello Scolio della Proposizione 55 di Eth. III che si adatta perfettamente al caso degli Ebrei.
2°) che l’acquiescentia è anche philautia, e che questo amore di sé può anche condurre ad un’idea immaginativa di una gioia accompagnata dall’idea adeguata di se stessa;
3°) infine, che l’Etica indica effettivamente un affetto che corrisponde molto esattamente a una acquiescentia, come gioia passiva e condivisa, comprendente l’immaginazione: è l’Hilaritas. In Eth. III, 11 Scolio, Spinoza definisce l’hilaritas come un affetto di gioia congiunto ad un tempo sia all’Anima che al Corpo, quando tutte le parti dell’uomo, il suo corpo come il suo spirito, ne siano egualmente affette. La dimostrazione Eth. IV, 42 precisa che “relativamente al Corpo”, l’Hilaritas consiste “in questo che tutte le sue parti sono in pari grado affette, cioè (Proposizione 11 della parte III) che la potenza di agire del Corpo è aumentata o favorita in modo che tutte le sue parti raggiungano l’una rispetto all’altra la stessa proporzione di movimento e di quiete; così l’Hilaritas è un affetto sempre buono e non può avere eccesso”.
Si può così dire che l’hilaritas è un affetto che suppone e che esprime l’equilibrio vitale di un principio positivo che è qui conservato. Ma, benché “senza eccesso” (e in questo senso identico agli affetti che trovano la loro origine nella ragione), è un affetto passivo (mentre quegli affetti che trovavano la loro origine nella ragione sono attivi); “passivo” perché la causa di quell’affetto non è l’individuo che lo prova ma consiste essenzialmente nelle circostanze esterne che gli sono favorevoli.
Ora, la maniera in cui Spinoza spiega l’elezione degli Ebrei esprime bene ciò che si potrebbe chiamare una costruzione politica dell’Hilaritas, poiché gli Ebrei “hanno condotto i loro affari con successo in ciò che riguarda la sicurezza della vita ed hanno oltrepassato grandi pericoli, tutto ciò soprattutto grazie al soccorso esterno di Dio” (TTP, III, &).
Donde l’Hilaritas, la cui causalità è esterna ma che irradia una fiducia che s’impianta sulla potenza reale della moltitudine in tutte le sue pratiche – pratiche che si sviluppano in un regime di eteronomia mentale, ovvero in un rapporto immaginario ai processi reali della loro costituzione. Questo stesso immaginario, come pratica sociale costante, è costituente della consistenza, della resistenza e della realtà di quel popolo e di quello Stato.
L’Hilaritas ci offre così l’effetto stesso dell’irradiamento della fiducia comune, del piacere di far corpo insieme, del Desiderio o dell’Amore di vivere in comune, energia virtuosa o vigore della virtù divina comune che, in maniera equilibrata ed equilibrante, sviluppa la pratica costituente dell’immaginazione politica del corpo della moltitudine.
Quel che Mosè poteva realizzare in se stesso grazie alla sua virtù divina – e cioè porre i problemi reali della società ebraica e produrre le risposte più adeguate – diviene dopo di lui quello che (senza Mosè, ma grazie alle sue istituzioni) può realizzare la società ebraica presa nella sua interezza. Società la cui fiducia si è così spiazzata da Mosè verso la Legge divina, per poi finalmente manifestarsi di fatto dentro e attraverso la fedeltà rinnovata in quella legge: la fiducia intrinseca del popolo ebraico dentro e attraverso le sue proprie pratiche potenti, attraverso le quali si irradia la gioia confidente e condivisa, egualmente e in tutte le sue parti, dell’Hilaritas.
Aggiungiamo che questa concezione di una fides – fiducia come Hilaritas negli Ebrei può essere verificata a contrario (in una sorta di contro-prova sperimentale) dalla storia reale di quel popolo, tal quale Spinoza ce la restituisce.
In effetti, una sola modificazione delle istituzioni della teocrazia (il passaggio dell’attribuzione ai primogeniti della sola tribù di Levi, della gestione delle cose sacre) introduce una trasformazione radicale delle disposizioni di ciascuno e una serie catastrofica di deregolazioni che finirà per condurre gli Ebrei (dalla fiducia fondamentale nell’affermazione della loro vita) ad un’altra disposizione inversa nella quale, dice Spinoza, “tutti preferivano morire piuttosto che vivere”. (TTP, XVII, 28). È allora che abbiamo la descrizione della melanconia della nazione. Spinoza definisce la “melanconia”, nell’Etica, in maniera diametralmente inversa all’hilaritas. La melanconia è in effetti una depressione equilibrata, la perdita di ogni fede, di ogni fiducia e di ogni fedeltà nella vita quando tutte le parti di un corpo (e di uno spirito) sono egualmente affette dalla tristezza – e allora più niente permette la resistenza (Eth. III, 11 Scolio e IV, 42 dimostrazione). È un crollo – un crollo della potenza d’agire per perdita di fiducia essenziale e quindi per perdita di ogni punto d’appoggio alla resistenza. La melanconia è dunque la dinamica stessa del suicidio (TTP, XVII, 27-28).
Se si vuol dunque, al termine di questa prima analisi della fiducia, a partire dalla teocrazia ebraica, trarre una lezione spinozista essenziale concernente la fides come fiducia, questa lezione sarà:
1°) che conoscere come un corpo si tiene insieme, è effettivamente conoscere la fede o la fiducia immanente di cui questo corpo è capace;
2°) che essendo stato posto come principio il desiderio degli uomini di non essere comandati, non può esserci fiducia politica, non mistificata e non mistificante, se non quando vi sia una risposa “adeguata” a questo desiderio. E per Spinoza non c’è che una sola risposta adeguata: la democrazia. Una democrazia che prende differenti figure secondo le forme di governo nelle quali e attraverso le quali essa può costruirsi e manifestarsi: cioè la teocrazia (che è la democrazia adattata ad un popolo-bambino) e, per i tempi moderni, le forme democratizzate della monarchia e dell’aristocrazia che Spinoza elabora nel suo Trattato Politico.
In ogni caso, questi regimi rispondono adeguatamente al desiderio degli uomini di non essere comandati da un loro simile, con la costruzione a tal fine di sistemi di contro-poteri che permettano di fare ostacolo all’ambizione di dominio che attraversa ciascuno (desiderio tanto forte quanto il desiderio di non essere comandati…). Ambizione di dominio e desiderio di non essere comandati sono infatti correlativi.
Così, facendo astrazione da ogni altro parametro, dal rifiuto da un lato d’essere comandati da un eguale-simile e, correlativamente, dell’altro, dall’impossibilità di diventare il padrone del proprio simile (data la resistenza di ciascuno al dominio dell’eguale), ne consegue che le contraddizioni effettive e affettive che necessariamente attraversano la moltitudine sono risolte, nelle e attraverso le istituzioni, attraverso una misura consensuale e comune, quella dell’eguaglianza di diritti. In Spinoza, la democrazia è innanzitutto questa soluzione : la democrazia è dunque il risultato di una prudenza comune, una prudenza della multitudinis potentia. Ed è perciò che Spinoza pensa che le prime forme del vivere insieme dovevano essere, logicamente, delle società democratiche (TP VIII, 12).
La democrazia è, in effetti e prima di tutto, l’invenzione di una misura comune che dà la sua condizione di possibilità al vivere insieme.
La dinamica affettiva, complessa e comune, conduce in maniera immanente alla produzione di un rimedio degli affetti distruttivi, vale a dire all’invenzione di una misura comune universalizzante che apporta contentezza a tutti e a ciascuno, poiché (cito dal Trattato Politico) “ciascuno trova giusto di avere nei riguardi del suo vicino il medesimo diritto che il suo vicino ha in rapporto a lui” (TP VIII, 12). Questa “eguaglianza”, come misura comune, definisce una giustizia a partire dal sentimento di giustizia: una giustizia affettiva dunque, provata e desiderata prima ancora che il nuovo Stato prenda quelle misure particolari che definiscono il giusto e l’ingiusto. È dunque l’“eguaglianza” che dà la misura essenziale del vivere insieme. Senza l’eguaglianza “che è uno dei primi bisogni della comunità politica” (TP VII, 20), scrive Spinoza, “la libertà comune sprofonda in rovina” (TP X, 8).
 Qui dunque si tocca con mano non solo il principio della politica della moltitudine come pratica collettiva di resistenza al dominio, ma anche il principio stesso della fiducia politica in quanto essa ingloba e richiede la produzione immanente di una misura comune.
Qui dunque si tocca con mano non solo il principio della politica della moltitudine come pratica collettiva di resistenza al dominio, ma anche il principio stesso della fiducia politica in quanto essa ingloba e richiede la produzione immanente di una misura comune.
L’ambizione del dominio è in effetti un desiderio in se stesso eccessivo, che non produce alcuna misura, ma che al contrario disequilibra l’insieme del Corpo collettivo fino alla sua distruzione. Nella sua Etica, Spinoza denomina titillatio il piacere di un corpo totalmente disequilibrato quando una sola delle sue parti prova un violento affetto di piacere a detrimento di tutte le altre parti (Eth., III, 11 Scolio; IV, 43 Dimostrazione). E si potrebbe pensare che, per il Corpo politico, le cose vadano esattamente nello stesso modo. Nel regime del dominio politico, in effetti, il piacere ossessivo di uno solo (o di alcuni uniti secondo i medesimi interessi di casta o di classe) opprime violentemente tutte le altre parti del Corpo e “impedisce così che questo Corpo sia atto ad essere affetto da un gran numero di altri modi” (Eth., IV, 43 Dimostrazione) (essendo sotto un regime di dominio, la grande maggioranza delle parti del Corpo della società rese impotenti, fissate nel dolore e nella tristezza della solitudine). In termini assoluti (vale a dire in un regime di dominio estremo o di terrore) si noti che è impedita dal dominio anche quella dinamica imitativa di identificazione che conduce naturalmente – per “commiserazione” , “benevolenza” e “indignazione” – a soccorrere il proprio simile nella miseria e a desiderare di vendicarsi di colui che è la causa del suo male. (Eth., III, 27, Dimostrazione del Corollario 3; et L. Bove, La stratégie du conatus, pp. 291-295). Ciascuno, non potendo pensare che alla propria miseria e solamente alla propria sopravvivenza, è raggelato dal terrore nella sua solitudine… ed è allora lo stesso processo dell’antropogenesi che è spezzato, vale a dire la costituzione dell’umanità dell’uomo a partire dallo sviluppo multiplo e diverso dei suoi modi d’affettare e di essere affetto che costituiscono tutta la ricchezza della potentia umana e della democrazia. Tendenzialmente, il dominio è dunque la distruzione logica del Corpo comune.
Il desiderio di non essere comandati da un eguale-simile produce, al contrario, la misura del comune e del bene comune: quella dell’”eguaglianza”. Esso produce così una politica attiva di resistenza al dominio, una politica democratica di costruzione del comune. Si può allora opporre la titillatio del dominio all’Hilaritas del comune e del bene comune della moltitudine, essendo l’Hilaritas, dice Spinoza un affetto “sempre buono e che non può avere eccesso” (Eth., III, 42 e Dimostrazione). Nel campo degli affetti politici, la misura dell’Hilaritas ci offre così la passione democratica per eccellenza. Nell’Hilaritas si esprimono l’irraggiamento di quello che noi chiamiamo una fiducia comune, una fiducia che elimina ogni desiderio di dominio sul proprio simile come, inversamente, di abbandonare la propria salvezza ad un uomo considerato provvidenziale. La fiducia dell’Hilaritas è dunque il piacere stesso di vivere insieme, di fare Corpo insieme, è l’amore di vivere nell’eguaglianza.
La misura comune ha tuttavia un doppio significato. In primo luogo, questo significato s’intende come caso di soluzione politica della multitudinis potentia: è invenzione immanente di un principio dinamico del comune, di una unità di base o di una unità di misura del vivere insieme. Ma bisogna intendere anche, per misura comune, il mezzo che deve essere messo in opera al fine di mantenere e di difendere l’eguaglianza, al fine d’impedire ogni tentativo di dominio. Ed è in questa seconda accezione di misura – quella della creazione di istituzioni sotto la forma di misure e/o di decreti presi insieme dall’assemblea sovrana degli eguali – che il rimedio deciso può stabilire effettivamente la comune fiducia o, al contrario, contribuire a distruggerla. Poiché il rimedio deciso può anche essere molto parziale o molto inadeguato e ciò egualmente a causa di quelle leggi degli affetti che necessariamente continuano a determinare le condotte e le decisioni di una moltitudine in assemblea. In effetti, spiega Spinoza, sono le stesse leggi degli affetti che hanno condotto all’invenzione della democrazia a spiegarci anche perché le democrazie non abbiano potuto mantenersi per lungo tempo. Una democrazia, quando s’instaura, è perpetuamente sotto la minaccia di passioni distruttrici da parte dei propri cittadini quando questi non abbiano saputo inventare istituzioni democratiche di contro-potere capaci di mantenere il Corpo politico nel suo principio dinamico fondatore, cioè l’eguaglianza di tutti e i sentimenti di giustizia e di fiducia che all’eguaglianza sono inerenti.
Dagli inizi della democrazia in effetti, nota Spinoza, “insorge una grande difficoltà”, questa difficoltà “viene dall’invidia” (TP, VIII 12) e/o dalla gelosia che suscitano, in seno al giovane Stato democratico, i nuovi arrivati che possono beneficiare degli stessi diritti che i cittadini d’origine. Di fatto, la coscienza di un’unità e di un’identità nazionale si costituisce storicamente a detrimento della democrazia stessa. Gelosia e invidia dei nazionali fanno ostacolo all’accoglimento di nuovi venuti il cui accesso all’eguaglianza di diritti è considerato ingiusto da coloro che si considerano legittimi proprietari e usufruttuari dello Stato. Poiché, scrive Spinoza, “benché ciascuno trovi giusto d’avere nei confronti del suo vicino il medesimo diritto che il suo vicino ha in rapporto a lui, essi non trovano egualmente giusto che degli stranieri giunti in gran numero a fissarsi nel paese, abbiano un diritto eguale al loro, all’interno di uno Stato che loro hanno costruito, loro stessi, a prezzo di grandi pene e su un territorio conquistato a prezzo del loro sangue” (TP, VIII 12). È così che la decisione politica conservatrice di escludere gli stranieri dalla cittadinanza, che fa dunque dello Stato democratico stesso una nuova istanza di dominio su una grande parte della popolazione, mette in pericola la conservazione stessa della democrazia. E in effetti lo Stato inizialmente democratico cambierà necessariamente di natura chiudendo le sue assemblee sovrane agli stranieri, per trasformarsi piuttosto in un’assemblee di “nobili” che alla fine si affideranno al regno di uno solo.
Spinoza declina allora, nel suo Trattato Politico, una serie di “misure” e/o di contro-poteri che devono prevenire il crollo della democrazia e, correlativamente, la perdita di fiducia dei cittadini nella loro potenza comune, fino ad abbandonare il loro destino alle mani di alcuni, poi di uno solo …
Spinoza deduce queste misure dall’esperienza degli uomini nella storia ed anche dalla sua conoscenza adeguata della logica degli affetti. Non potendo qui entrare nel dettaglio di tutte queste misure, non tratterò che di quelle che Spinoza ritiene essenziali.
Innanzitutto, per ciò che riguarda l’esercito, esso dovrà essere costituito solo da cittadini. (TP, VI, 10 e VII, 22). Un esercito di mestiere impone allo Stato, che dovrebbe proteggere, un vero e proprio “stato di guerra dove solo l’esercito è libero e tutti gli altri schiavi” (TP VII, 22). Inoltre, il comandante in capo dell’intero esercito non dovrà essere nominato che in tempo di guerra e il suo tempo di comando sarà strettamente limitato “al massimo per un anno, e non potrà essere né prolungato né più tardi rieletto” (TP VIII, 9). Spinoza diffida, come della peste, della costruzione di eroi. La fiducia e l’eguaglianza non possono sussistere, scrive, “quando il diritto pubblico dello Stato permetta che si attribuiscano onori straordinari a un uomo illustre per la sua virtù” (TP X, 8). Accade sovente, in effetti, che in una situazione di crisi, oppure a causa delle sue vittorie presenti e passate, un uomo illustre diventi il tiranno del suo popolo: “nelle estreme crisi dello Stato, quando tutti son presi da una sorta di terrore-panico, si vedono i cittadini riunirsi tutti, concordando sul solo pensiero che loro impone la paura del momento e, senz’inquietarsi né dell’avvenire, né delle leggi, volgere i loro sguardi verso un uomo illustrato dalle sue vittorie, e così liberarlo (lui solo) da tutte le leggi, dargli continuità di comando (che è la cosa più pericolosa) e confidare infine alla sua sola lealtà l’intera Repubblica. Fu là sicuramente la causa della rovina dello Stato romano”. (TP X, 10).
Soluzione, questa, tra le più illusorie e le più pericolose che si possono dare, quando invece si dovrebbe agire, ben al contrario, da parte dei cittadini, non per cercare la virtù salvatrice in un uomo provvidenziale, ma piuttosto per costruire fiducia, vale a dire l’equilibrio, la virtù e la prudenza razionale dello Stato democratico. Uno Stato che, in tempo di crisi, potrebbe trovare in se stesso e da solo, dentro le proprie istituzioni, soluzioni adeguate senza lasciarsi sconvolgere dalle speranze e dai timori del tempo presente. (TP I, 5-6).
E quindi una depersonalizzazione radicale delle funzioni pubbliche che Spinoza prospetta definendo figure di administratores della repubblica diametralmente opposte a quelle di dictatores (TTP XVII, 4). Dei dictatores dai quali la democrazia deve proteggersi: in primo luogo, sopprimendo la pratica del “segreto di Stato” che mantiene la moltitudine in uno stato d’impotenza e di irresponsabilità politica (TP VII, 27-29): questo “segreto”, scrive Spinoza, è incompatibile con la fiducia e la libertà comuni; in secondo luogo, instaurando un sistema di assemblee molto largo, di preferenza in ogni città, assemblee esse stesse organizzate attraverso dei vigili sistemi di contro-poteri. È così che, piuttosto che un sistema di rappresentanza politica che richiede di “dar fiducia” a dei rappresentanti, Spinoza preferisce un dispositivo di partecipazione effettiva del più grande numero di cittadini a delle funzioni di decisione comune; funzioni che sono strettamente limitate nel tempo, e in seno ad un’assemblea suprema i cui membri siano in parte rinnovati tutti gli anni. Un’assemblea – essa stessa – strettamente sorvegliata da un’assemblea più ristretta di cittadini il cui ruolo è essenzialmente quello di garantire il mantenimento inviolabile dei fondamenti delle leggi “per quel che riguarda i corpi deliberanti e i funzionari pubblici” (TP VIII, 20).
Spinoza respinge la critica alla pesantezza e alla lentezza di un tale dispositivo sulla base della difesa dei principi della vita comune ed invocando, ancora una volta, la storia romana: “Se Sagunto soccombe mentre i Romani deliberano, è vero anche che la libertà e il bene comune vanno in rovina quando pochi individui decidono di tutto” (TP IX, 14). L’esigenza di principi non dovrà dunque cedere a degli imperativi tecnici, neppure nell’urgenza.
Non c’è alcun idealismo né dogmatismo nella difesa di questi principi. Ma un’esigenza di prudenza e di verità che rifiuta di piegarsi alla pragmatica del potere, quand’essa con la scusa dell’efficacia cancella l’esercizio della politica del comune a profitto del dominio, aprendo così, attraverso l’abbandono della fiducia comune, all’ambizione di alcuni.
Inoltre, se Spinoza ci mette in guardia contro le utopie ed esige, per pensare politicamente, un ritorno all’esperienza, vale a dire alla pratica, questo non significa che egli abbia abbandonato il nesso strutturale della politica con la verità e la certezza o con la fiducia che include necessariamente la verità. Questo nesso della politica, della verità e della fiducia, noi lo ritroviamo nell’idea stessa della virtù ovvero della prudenza intrinseca a costruire le istituzioni della democrazia, e alla difesa della democrazia stessa. Poiché non si tratta semplicemente, nella costruzione della fiducia comune, di combinare dei semplici mezzi tecnici, ma si tratta per Spinoza di costruire una vera e propria causalità adeguata (Eth. III, definizioni 1 e 2) del Corpo comune – cioè il movimento reale di emancipazione attraverso il quale la potenza della moltitudine giunge al suo regime di “adeguazione” e a quella fiducia politica equivalente alla acquiescentia in se ipso dell’Etica. Ora, questo movimento reale del reale secondo il quale, nella conquista dell’autonomia, una cosa qualunque produce e si produce secondo e attraverso i suoi propri effetti – è proprio questo dunque che Spinoza concepisce, nella sua filosofia, come la procedura stessa di produzione di verità (TEI, B 71). Una procedura che è anche quella della certezza e/o della fiducia intrinseca che accompagna questa produzione.
La democrazia non è dunque, per Spinoza, quella forma di governo debole e stolta che noi conosciamo oggi, di cui ci si dice che bisogna razionalmente accontentarsi poiché, anche se si tratta del “peggiore dei regimi”, lo è comunque “a eccezione di tutti gli altri sperimentati nel corso della storia” e che ci hanno spinto verso il peggio del peggio! No. La democrazia da costruire (tal quale Spinoza la concepisce) incarna, al contrario, in sé e attraverso di sé, quella potenza e quell’esigenza e il rigore della verità, che stanno là dove la “fiducia” può effettivamente prodursi, come Hilaritas. Una fiducia politica correlativa alla certezza ed alla gioia etica che accompagnano necessariamente la produzione di verità, poiché si tratta, nella costruzione democratica potente che propone Spinoza, dello stesso movimento reale del reale, quello dell’autonomia ovvero della “libera necessità”: quella dei popoli, degli uomini, così come quella delle idee quand’esse siano vere.
[traduzione di Toni Negri, → qui il testo originale, → qui la traduzione in português]