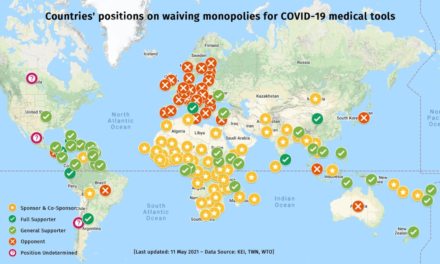Di CHRISTIAN MARAZZI
Il recente fallimento della Silicon Valley Bank, la «banca dell’economia globale dell’innovazione», squaderna questioni e domande decisive. In questa nuova puntata del «Diario della crisi», Christian Marazzi spiega in modo illuminante che cosa sta accadendo e la posta in palio, analizzando il ruolo della banca centrale, l’effetto dell’aumento dei tassi di interesse sui Titoli di Stato, il possibile precipitare degli investimenti delle start-up di tecnologia climatica legati alla Svb. In un contesto in cui, negli ultimi anni, i salari sono cresciuti più lentamente dell’inflazione e i salari reali aggregati sono di fatto diminuiti, l’autore spiega come il problema di fondo della politica della Fed sia il suo essere monetarista, tutta incentrata cioè sull’offerta di moneta, e non, come dovrebbe essere, sull’andamento della domanda di moneta. Sotto le politiche della Fed, dunque, sembra riaffacciarsi l’enigmatico spettro dei comportamenti del lavoro vivo e delle «grandi dimissioni».
Non solo start-up
A un primo livello d’analisi, il fallimento della Silicon Valley Bank (la «banca dell’economia globale dell’innovazione») appare come una tipica crisi da bank run, da corsa agli sportelli causata dal panico dei depositanti, per lo più «startupper» nel settore digitale, per recuperare quanta più possibile liquidità da una banca, la loro, sull’orlo del crac. «Per capire – scrive Paolo Mastrolilli su «la Repubblica» di domenica 12 marzo, riassumendo la narrazione generale – bisogna partire dall’origine della crisi. Prima del Covid, alla fine del 2019, i depositi presso la Svb erano triplicati, da 62 a 189 miliardi di dollari, grazie all’esplosione delle start-up tecnologiche. La banca aveva investito larga parte di questi fondi in obbligazioni del Tesoro, che fruttavano in media l’1,79%. Quando nel marzo scorso la Federal Reserve aveva iniziato ad alzare i tassi per frenare l’inflazione, aveva provocato due effetti molto negativi: primo, il valore dei bond nel portafoglio di Svb era sceso, creando significative perdite sulla carta; secondo, le compagnie tecnologiche che costituivano il grosso della sua clientela si erano trovate in difficoltà, iniziando i prelievi». Durante i giorni che precedono il venerdì nero (10 marzo), si è tentato un salvataggio coinvolgendo la Goldman Sachs, che consisteva nel cercare di colmare la differenza tra la liquidità raccolta dalla vendita dei Buoni del Tesoro detenuti dalla banca e la domanda di liquidità dei depositanti. «Il salvataggio però non è stato gestito bene, si è sparsa la voce del buco, le compagnie di venture capital hanno consigliato ai clienti di ritirare i fondi e solo giovedì la banca ha dovuto fronteggiare richieste per 42 miliardi»[1].
Già a questo livello, si possono enucleare alcune questioni che andranno approfondite in seguito.
In primo luogo, il ruolo della banca centrale, con la sua politica monetaria anti-inflativa, in particolare la rapidità con la quale lo scorso anno ha perseguito l’aumento dei tassi di interesse. Come ricorda Kenneth Rogoff, i rialzi dei tassi d’interesse «agiscono in due modi. Sono una manna per le banche (e i loro profitti) perché permettono di alzare i tassi sui prestiti. Ma sono una disgrazia perché le aziende investono meno e il flusso di denaro rallenta»[2]. Cosa rendeva la Svb particolarmente vulnerabile? Secondo Peter Coy, del «New York Times», «uno dei motivi è che molti dei suoi prestiti sono nel settore tecnologico che, come sappiamo da qualche mese, sta andando male. Un’altra ragione, forse più importante, è che si basa fortemente su depositi di istituzioni piuttosto che sui depositi di individui. Le persone che gestiscono aziende high tech, fondi di investimento, hedge funds o società di criptovalute[3], sono sempre alla ricerca del rendimento più alto che possono guadagnare; quindi sono veloci a togliere denaro da una banca e metterlo, ad esempio, in un fondo del mercato monetario. Inoltre, le istituzioni si affretteranno a ritirare i loro soldi da una banca se pensano che potrebbe fallire, o perché temono che altri tirino fuori i loro soldi»[4]. C’è inerzia nel reagire quando i depositanti sono individui, mentre uno degli effetti della digitalizzazione è che accelera la velocità di disintermediazione da parte delle aziende che (re)agiscono in tempo reale alle minime oscillazioni finanziarie.
In secondo luogo, l’effetto dell’aumento dei tassi di interesse sui Treasury bonds, i Titoli di Stato acquistati dalle banche e detenuti «in pancia» come riserve sicure («massimamente liquide») per effettuare le operazioni di credito e di investimento ben oltre il volume di depositi. Essendo a reddito fisso, quando i rendimenti sui Buoni del Tesoro aumentano, necessariamente il loro valore diminuisce[5]. Così, quando li si vende per procurarsi liquidità, si incassa un bel po’ meno di quanto erano costati in origine[6].
Come ha scritto Paul Krugman, la Svb ha parcheggiato gran parte dei suoi enormi depositi «in attività estremamente sicure, principalmente obbligazioni a lungo termine emesse dal governo degli Stati Uniti e da agenzie sostenute dal governo. Per un po’ ha fatto soldi perché, in un mondo a bassi tassi d’interesse le obbligazioni a lungo termine pagano tassi di interesse più elevati rispetto alle attività a breve termine, compresi i depositi bancari». Però, quando i tassi di interessi a breve termine sono aumentati, addirittura oltre quelli a lungo termine[7], lo spread da cui dipendevano i profitti di Svb sono scomparsi, oltretutto trascinando verso il basso il valore delle obbligazioni, il che ha causato grandi perdite di capitale. «E questo, ovviamente, è esattamente ciò che è successo quando la Fed ha alzato i tassi di interesse per combattere l’inflazione»[8].
Si noti che il 96% dei depositi di Svb non è coperto dalla garanzia di rimborso della Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic), che assicura depositi fino a 250 mila dollari. Il ministro del Tesoro, Janet Yellen, si è affrettata a rassicurare i mercati dicendo che (per evitare un’altra Lehman Brothers) stanno cercando una soluzione per raccogliere fondi con cui rimborsare anche i depositi non assicurati. Non si tratta, così si sostiene, di un salvataggio della banca e dei suoi azionisti con i soldi dei contribuenti (come fu nel 2008), ma del salvataggio dei depositanti che, un po’ ingenuamente, hanno messo tutti i loro soldi in una sola banca e ora, da buoni liberisti libertari, si aspettano di essere salvati dallo Stato (secondo il «Wall Street Journal», ma anche secondo altri analisti, si tratta comunque di un «de facto bailout»[9]). Definire l’intervento dello Stato non è una questione di poco conto, è in gioco la soglia di «azzardo morale» (moral hazard) che legittimerà il prossimo ciclo speculativo e, anche, la soglia di sopportabilità sociale e civile di un sistema politico-finanziario che mentre si inalbera contro l’indebitamento «troppo elevato» degli studenti, per dire, rivendica la protezione pubblica degli interessi finanziari privati. Vale sempre il vecchio adagio: «privatizzazione dei profitti, socializzazione delle perdite».
A partire da lunedì 13 tutti i depositi, assicurati e no, sono disponibili. Inoltre, la banca centrale mette a disposizione uno sportello di liquidità per aiutare le banche, in particolare le banche regionali, a rispondere alle richieste dei clienti in caso di fuga. Nel frattempo, in Inghilterra, la Svb Uk è stata acquistata (per una sterlina) dalla Hsbc.
In terzo luogo, benché la Svb sia una banca focalizzata prevalentemente sul settore digitale, le condizioni esterne che hanno contribuito a portarla al fallimento valgono per molti altri settori. Nel maggio del 2018 Trump, anche su pressione di banche come la stessa Svb, aveva alzato da 50 a 250 miliardi di attivo il tetto per le banche considerate troppo grandi per fallire (too big to fail), tornando indietro rispetto al Dodd Frank Act emanato dopo la grande crisi del 2008. In questo modo la stragrande maggioranza delle banche Usa ha potuto operare senza grandi controlli da parte della Fed e il fallimento della Svb è il risultato di questa politica di eccessiva deregulation[10]. Il calo in borsa tra il 20 e il 70% di First Republic e Western Alliance, il fallimento della Signature Bank, dopo la chiusura di Silvergate (entrambe società di criptovalute), sono solo esempi degli effetti collaterali della deregulation liberista trumpiana. La stessa politica monetaria restrittiva della Fed sta mettendo sotto pressione molti altri settori, come ad esempio l’edilizia commerciale dove sono in circolazione 60 miliardi di prestiti a tasso fisso che andranno rifinanziati a breve a condizioni più costose, e 140 miliardi di mutui a tassi variabili che maturano tra due anni[11].
Un aspetto per il momento poco commentato è che la Svb negli ultimi anni ha lavorato con 1.550 aziende tecnologiche che stanno sviluppando progetti di energia solare, di idrogeno e stoccaggio di batterie. «La Silicon Valley Bank era per molti versi una banca climatica», ha dichiarato Kiran Bhatraju, amministratore delegato di Arcadia, una delle più grandi comunità d’energia solare del paese. I progetti solari comunitari sembrano essere particolarmente colpiti dalla crisi. La Svb aveva diretto o partecipato al 62% degli accordi di finanziamento per progetti solari comunitari, che sono progetti su piccola scala che servono aree residenziali a basso reddito. Il crollo della Svb minaccia di far deragliare quella che era una parte in rapida crescita del settore del capitale di rischio (venture capital). Più di 28 miliardi di dollari sono stati investiti in start-up di tecnologia climatica nel 2022, in forte aumento rispetto all’anno precedente. Molte delle aziende che con la crisi della Svb stanno ridimensionando le loro operazioni, se non semplicemente chiudendo, erano pronte a sfruttare i crediti d’imposta inclusi nell’Inflation Reduction Act, la legislazione federale sul clima firmata da Biden lo scorso anno[12].
La Fed contro la classe operaia
Il fallimento della Svb, se da una parte si iscrive nella crisi del settore dell’high tech digitale con l’ondata di licenziamenti che da mesi ormai attraversa l’intero settore (vedi il «Diario» di gennaio); se, d’altra parte, si spiega per alcune specificità della banca stessa (monocoltura, il suo essere prevalentemente una banca di gestione e investimento dei depositi dei suoi clienti); se, ancora, sconta le conseguenze della deregolamentazione eccessiva di trumpiana memoria, che ha abbassato non poco il livello di guardia delle autorità di vigilanza; se, infine, non sembra paragonabile alla crisi sistemica della Lehman Brothers del 2008 e ai suoi effetti macroeconomici globali, nondimeno evidenzia un serio problema per quanto attiene la strategia monetaria della Fed come di tutte le banche centrali.
La reazione dei mercati tra lunedì 13 e martedì 14 non permette di capire la portata della crisi, la sua profondità e estensione. Per questo occorreranno ancora alcuni giorni. Di sicuro la paura del contagio, così come le rassicurazioni delle autorità monetarie e politiche, contribuiscono ad acuire la volatilità dei mercati, peraltro già alquanto volatili prima dello scoppio della crisi.
Una cosa è però apparsa chiara sin da subito: i mercati e gli investitori dimostrano di volere che la banca centrale freni, addirittura congeli la sua politica restrittiva basata sugli aumenti dei tassi già previsti per i prossimi mesi, ribaditi con fermezza da Joe Powell solo cinque giorni prima del crack della Svb. Si dava per certo un prossimo aumento dei tassi dello 0,5%, ma la corsa degli investitori agli acquisti dei Buoni del Tesoro a due anni ha fatto precipitare il rendimento sotto il 4% in un solo giorno (avevano superato il 5% esattamente una settimana fa, lasciando presagire una recessione imminente), un calo record mai visto dal 1987.
Nei mesi scorsi, i mercati finanziari auspicavano che l’economia entrasse in recessione, perché in tal caso le autorità monetarie abbassano i tassi di interesse per frenarne gli effetti e la durata. La riduzione dei tassi d’interesse, cioè del costo del denaro, per i mercati finanziari significa la ripresa degli investimenti speculativi, e quindi delle rendite finanziarie.
Il fatto è che la recessione non è scoppiata, c’è stato anzi un forte aumento dell’occupazione, un aumento medio del potere d’acquisto e della capacità di indebitamento dei consumatori americani[13], il tutto accompagnato da un processo disinflazionistico (pare che Powell abbia pronunciato la parola disinflazione ben undici volte nella sua conferenza stampa d’inizio febbraio)[14].
Per i mercati questi dati sono la prova che la spinta espansiva convive con un’inflazione in declino, e quindi c’è margine per una riduzione dei tassi d’interesse. Per la Fed, invece, gli stessi dati positivi sono la dimostrazione di una possibile rincorsa salari-prezzi che compromette la battaglia contro l’inflazione. Pochi giorni dopo aver parlato di disinflazione, ecco cosa dice lo stesso Powell: «Dovremo fare più aumenti dei tassi e poi dovremo guardarci attorno a vedere se ne abbiamo fatti abbastanza» (Economic Club, Washington, 7 febbraio).
Ora, come è stato dimostrato da più parti, non solo la crescita dei salari è rallentata, ma laddove vi è stato un aumento è perché sono aumentate le ore settimanali di lavoro (un chiaro aumento del plusvalore assoluto)[15]. Negli ultimi due anni i salari sono cresciuti più lentamente dell’inflazione e i salari reali aggregati sono di fatto diminuiti. Secondo il «Washington Post», la quota attuale dei redditi da lavoro sul Pil, scesa al 56%, è tornata al livello del 2014.
Bisogna quindi escludere categoricamente il rischio di una «spirale prezzi-salari» in stile anni Settanta, mentre bisognerebbe parlare di una «spirale prezzo-prezzo», «in cui i prezzi finali sono aumentati più degli aumenti dei prezzi dei fattori di produzione». A dirlo è Lael Brainard, già vice presidente della Fed, ora nominata da Biden a capo del National Economic Council (inflazione da profitti, insomma: vedi il «Diario» di dicembre 2022).
C’è quindi da chiedersi perché la Fed non abbia dato segni di cedimento con la sua politica monetaria anti-inflativa, perlomeno fino alla crisi della Silicon Valley Bank dello scorso 10 marzo. Nel momento in cui scrivo la Fed non si è espressa su cosa farà con i tassi di interesse nei prossimi mesi. È possibile che, per calmare («stabilizzare») i mercati, decida di aumentarli di un solo 0,25%, piuttosto che di mezzo punto percentuale come era programmato. Vedremo.
Si può sostenere che il problema di fondo della politica della Fed è che è monetarista, tutta incentrata sull’offerta di moneta, e non, come dovrebbe essere, sull’andamento della domanda di moneta. Si può aggiungere che si tratta di una politica basata su modelli econometrici che si ispirano alla «curva di Phillips», secondo cui esiste una relazione inversa tra tasso di inflazione e tasso di disoccupazione, e quindi, dato che oggi la disoccupazione è ai suoi minimi storici, i prezzi non possono che crescere. Tutto vero, salvo che la Fed, perlomeno dai tempi in cui Janet Yellen era presidente, si è dotata di una rete di sensori sul territorio che le permette di «avere il polso» del paese reale, molto più di quanto si creda.
Forse la risposta sta nel fatto che nell’ultimo anno (2022) vi è stato un forte aumento del numero di scioperi e di interruzioni del lavoro. «L’anno scorso ha visto un aumento del 52% del numero di interruzioni del lavoro rispetto all’anno precedente, con il 60% in più di lavoratori che hanno partecipato alle interruzioni». Se confrontato con la statistica delle lotte nel periodo fordista, si può avanzare l’ipotesi che nel 2022 si sia innescato un ciclo di lotte operaie che sembrava definitivamente irripetibile a partire dagli anni Ottanta[16], gli anni della controrivoluzione liberista.
Si aggiunga che per la Fed gli oltre dieci milioni di posizioni aperte delle aziende (vacancies), che non trovano i dipendenti per riempirle, è la prova che il mercato del lavoro è troppo stretto e preme sui costi delle imprese[17]. Le «grandi dimissioni» sono un fenomeno che sfugge a tutti i modelli econometrici della Fed (e non solo), un «enigma» che, come le lotte operaie per migliori condizioni di vita, va combattuto, estirpato. Anche a costo di andare contro il capitale.
[1] Per una ricostruzione dettagliata del processo che ha portato al fallimento della Svb, vedi il «Financial Times» del 13 marzo: «Problems at tech sector lender built for years before collapse. SVB absorbed big risk with only modest potential pay-off so as to boost short-term profit». Vedi anche Alessandro Graziani, Svb, il crack che Vigilanza e agenzie di rating non hanno visto arrivare, «Il Sole 24 Ore», 13 marzo 2023.
[2] Kenneth Rogoff, Il panico si è già diffuso. Altri fallimenti non sono esclusi, «la Repubblica», 13 marzo 2023.
[3] Solo la Circle aveva qualcosa come 3,3 miliardi di depositi presso la Svb.
[4] Peter Coy, How to Understand the Problems at Silicon Valley Bank, «NYT», 10 marzo 2023. Si veda anche Huw van Steenis, History can instruct us on the fallout from SVB’s collapse, «FT», 13 marzo 2023.
[5] Se un’obbligazione del Tesoro vale 100 e assicura un reddito di 5, il rendimento sarà pari al 5%. Se la stessa obbligazione perde valore e da 100 scende a 90, per continuare a garantire un reddito di 5 il tasso di rendimento aumenterà al 5,5%. Infatti, 5.55% di 90 da un reddito pari 5.
[6] Le minusvalenze implicite nel portafoglio titoli avevano praticamente azzerato il capitale di Svb già a fine 2022, ma né le Autorità di Vigilanza né le agenzie di rating, che hanno mantenuto il giudizio di investment grade fino al giorno del default, hanno visto arrivare il fallimento della sedicesima banca americana. La storia si ripete.
[7] Si noti che quando Jay Powell, presidente della Fed, martedì 7 se ne è uscito dicendo che la Fed avrebbe continuato a tenere alti i tassi di interesse per combattere l’inflazione, i rendimenti (i tassi) sui Treasury a breve (due anni) sono balzati oltre il 5%, mentre i rendimenti sui Treasury a lungo termine (10 anni) non si sono praticamente mossi. L’inversione della curva dei rendimenti (così si dice quando i rendimenti a breve termine superano quelli a lungo), in cui costa di più prendere a prestito nel breve termine che non nel lungo, di solito significa che nel prossimo anno o due si entrerà in recessione. Dal 1900 ci sono stati 28 casi di inversione della curva dei rendimenti e 22 di questi episodi sono stati seguiti da una recessione (vedi Gillian Tett, The markets go down the rabbit hole, «FT», 10 marzo 2023).
[8] P. Krugman, Silicon Valley Bank is not Lehman, «NYT», 13 marzo 2023.
[9] Vedi Jeanna Smialek – Alan Rapperport, Was This a Bailout? Skeptics Descend on Silicon Valley Response, «NYT», 1 13 marzo 2023. Si veda anche Branko Marcetic, Silicon Valley Bank’s collapse shows little has changed for big banks since 2008, «Jacobin», 13 marzo 2023.
[10] Vedi Davide Serra, Start-up e cripto torneranno con i piedi per terra, «la Repubblica», 13 marzo 2023.
[11] Si veda a questo proposito Paolo Mastrolilli, La crisi di Blackstone la grande bolla immobiliare e i fantasmi del 2008, «la Repubblica A&F», 13 marzo 2023, p. 7.
[12] Vedi David Gelles, Silicon Valley Bank Collapse Threatens Climate Start-Ups, «FT», 12 marzo 2023.
[13] Quando si parla di crescita dei consumi occorre sempre distinguere tra consumi produttivi (salari) e improduttivi (rendite parassitarie, profitti e sovraprofitti). Negli ultimi due anni sono soprattutto questi ultimi che sono particolarmente cresciuti.
[14] Riprendo qui di seguito un articolo molto documentato di Nicola Capelluto, Enigma inflazione, apparso su «Lotta comunista» nel mese di febbraio 2023.
[15] L’aumento degli affitti pesa per metà dell’inflazione totale degli ultimi mesi e assorbe buona parte degli incrementi salariali.
[16] Vedi Alex N. Press, Strikes were up significantly last year, «Jacobin», 2 febbraio 2023. I numeri esatti: 272 interruzioni del lavoro nel 2021 sono cresciute a 424 nel 2022. Quel numero consiste di 417 scioperi e sette serrate. Mentre circa 140.000 lavoratori hanno preso parte a un’interruzione del lavoro nel 2021, 224.000 lavoratori hanno fatto lo stesso l’anno scorso. Gli anni Cinquanta hanno avuto una media di 352 grandi interruzioni di lavoro all’anno che coinvolgono 1,6 milioni di lavoratori. Incredibilmente, l’intero periodo di tempo dal 1950 al 1970 ha avuto in media oltre 300 grandi interruzioni di lavoro all’anno (quasi una al giorno!) che coinvolgono oltre 1,4 milioni di lavoratori all’anno. Tuttavia, gli anni 2010 avevano solo una media di circa 15 all’anno che coinvolgeva 150.000 lavoratori. L’enorme calo nel 1980 è avvenuto nell’era del fallito sciopero Patco [Professional Air Traffic Controllers Organization], che ha portato al termine «Sindrome Patco», che descrive la paura dei sindacati di scioperare e perdere.
[17] Salvo poi disperarsi quando mezzo milione di salariati è assorbito in un mese, perché questo per la Fed significa un aumento della pressione sui consumi.
Questo articolo è stato pubblicato su Effimera il 16 marzo 2023.