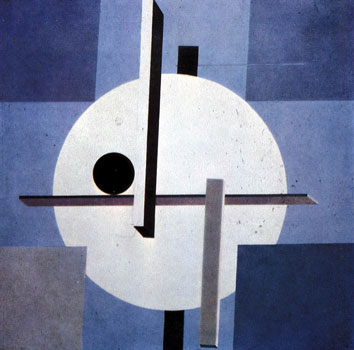di MIMMO SERSANTE.
«Gli scritti della tradizione operaista non sono destinati alla mera lettura o alla mera propaganda, il loro rigore scientifico non è destinato alla valutazione accademica, il loro messaggio è un messaggio puramente politico, esso deve produrre azione, mobilitazione, conflitto, confronto»1.
Giusto. Sergio fa parte a pieno titolo di questa tradizione, e fin dai suoi primissimi anni. Ed era vero allora che i suoi saggi e i suoi interventi alimentavano il conflitto, producevano azione. In particolare durante gli anni settanta, fu il suo progetto di una storiografia militante a colpire nel segno e ad aprirci nuovi orizzonti. I primi numeri di «Primo Maggio» restano un autentico fiore all’occhiello del nostro marxismo operaista. Oggi non possiamo nascondere la delusione leggendo questo suo articolo sul post operaismo italiano. Forse che il lettore inglese ha una soglia di tollerabilità più bassa del lettore italiano sì da doverlo proteggere da quel tipo di contagio? In questa sua ricostruzione c’è lo storico delle idee ma è scomparso il militante e con lui anche la talpa operaista che in verità sembra, scorrendo queste sue pagine, che non abbia mai scavato, neppure durante gli anni settanta. Ma se di Italian Theory è lecito parlare oggi, è perché essa è stata una ben precisa pratica teorica che non ha mai prescisso dalle lotte. Come altrimenti spiegarci la capacità dei nostri operaisti di stare al passo coi tempi fino ad anticipare sul terreno delle analisi il post fordismo? Certo, quella cassetta d’attrezzi è tornata utile per cogliere tutta intera la portata della sconfitta operaia e decifrare il cambiamento di paradigma del capitale lungo gli anni Ottanta evitando a quanti ad essa attingevano l’onta della deriva neoliberista. È proprio Sergio a ricordarcelo con un lungo rosario di nomi di resistenti di ieri e di oggi, tanto più cari alla nostra memoria se defunti. L’affetto di Sergio è riservato ovviamente ai pochissimi intimi, in particolare a Primo Moroni, «grandissimo affabulatore, [che] non ha scritto molto ma ha rilasciato molte interviste e testimonianze [e senza il quale] l’operaismo non avrebbe mai raggiunto le giovani generazioni dell’èra digitale». Dall’elenco mancano moltissimi altri, che pur di Sergio sono stati e sono intimi e pur grandissimi affabulatori. E che furono promotori del movimento di Autonomia e teorici dell’emergente “operaio sociale”. Ora, da questi compagni Bologna prende le distanze. Lo fa insistendo sul fatto che la sua storia dell’operaismo è condotta da un punto di vista soggettivo. Riconoscimento apprezzabile. Non crediamo tuttavia che ciò dipenda da una particolare acribia storica (è già nella «Tribù delle talpe» del ’78 la rivendicazione di una «mappa dell’ultrasinistra» diversa da quella descritta dai giudici e dai repressori dell’Autonomia) e tantomeno crediamo che si tratti di opportunismo politico (a che scopo, oggi?): si tratta piuttosto di una diversa posizione rispetto al ruolo che l’operaismo riserverebbe all’intellettuale. Per Bologna sarebbe quello di imparare dagli operai, saperli ascoltare, trasmettere loro strumenti di pensiero e di analisi, sempre rispettando il suo proprio ruolo; insomma «concepire se medesimo come una cellula di una struttura di servizio». Di contro, l’intellettuale autonomo, impegnato in un’ “attività continua di franco tiratore, di sabotatore, di assenteista, di deviante, etc, etc. La discriminante è tutta qui, in questa diversa idea di militanza di cui l’intellettuale deve farsi carico. Non stupisce allora che Bologna assegni al suo intellettuale l’onore e l’onere dell’attraversamento del lungo inverno neoliberista. Se «Primo Maggio» fa da apripista, altre riviste la seguono a ruota, da «Decoder» a «Altreragioni», tutte riconducibili allo zoccolo duro di questa intellighenzia capace di fomentare negli ultimi vent’anni i movimenti e di ascoltare, lei e lei sola, i precari e i lavoratori del cognitariato scoperti, fotografati e catalogati non a caso da Sergio e da pochi suoi intimi. E va ancor bene! Ma poi si esagera, quando con la presentazione della figura del lavoratore indipendente, vale a dire del freelance e del self employed, la ricostruzione si provincializza restringendosi a uno spazio locale. Tutto si concentra attorno a Milano, il tono, mi fa notare qualcuno, si fa milanista. ACTA con i suoi 2000 soci diventa l’erede designata avendo recepito il meglio delle analisi post operaiste e occupato lo spazio lasciato vuoto dai sindacati e dai partiti di sinistra. Una struttura se non propriamente sindacale, certamente parasindacale, apolitica per via delle caratteristiche dei self employed, modellata sulla composizione tecnica di questo referente, insomma una specie di sindacato di mestiere organizzato su base regionale per sostenere un particolare lavoro professionale nelle grandi questioni del welfare, del fisco e dei diritti. Di nuovo l’idea di struttura di servizio per rendere consapevoli della loro identità di lavoratori i professionisti indipendenti! Si permetta anche a noi qui un «punto di vista soggettivo», scilicet di ironia. C’è infatti da stupire che Aldo Bonomi non sia ricordato come cellula realizzata di questo progetto. Ma ritorniamo all’oggetto: è possibile che la storia dell’operaismo, e in particolare del post operaismo, sia tutta qui, che questa sia la sua trama? Trama tessuta col filo della sola memoria personale mentre le forme di lotta e di organizzazione – vecchie e nuove – messe in campo dall’operaismo stanno a dimostrare che davvero non è andata così. Da Genova in poi l’esperienza e la storia di almeno un paio di generazioni stanno a mostrarlo. Ma già prima, molto prima. La storia della galera e dell’esilio (esilio al quale Sergio Bologna non s’è sottratto) è troppo importante perché possa esser dimenticata. La biforcazione fra tesi piattamente sociologiche e sindacali dell’«intellettualità di massa» e ipotesi politiche ancora tutte aperte (ma altre non ce ne sono) sul protagonismo e l’egemonia di quella figura si è costruita in quella fase. Do you remember revolution?